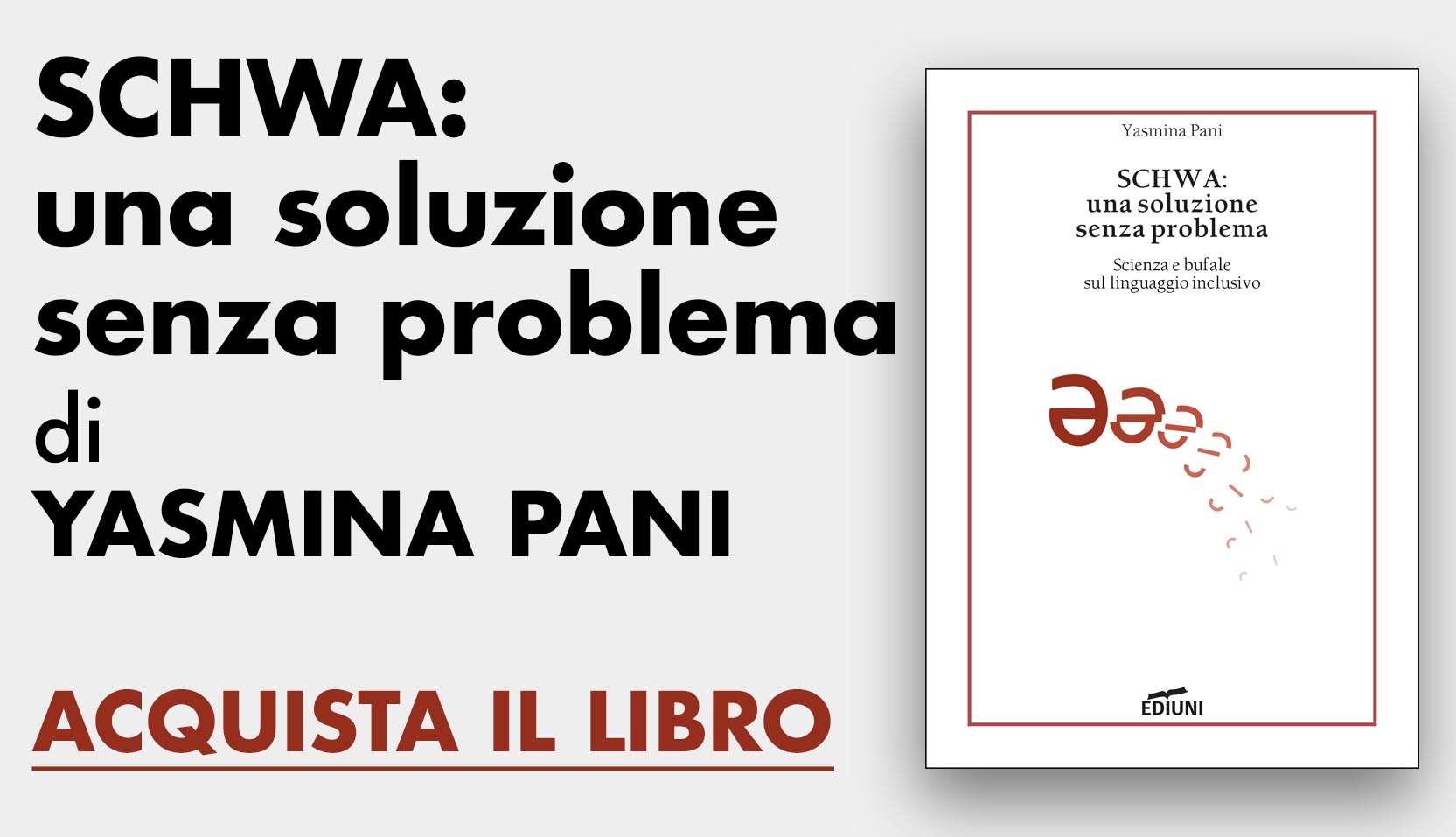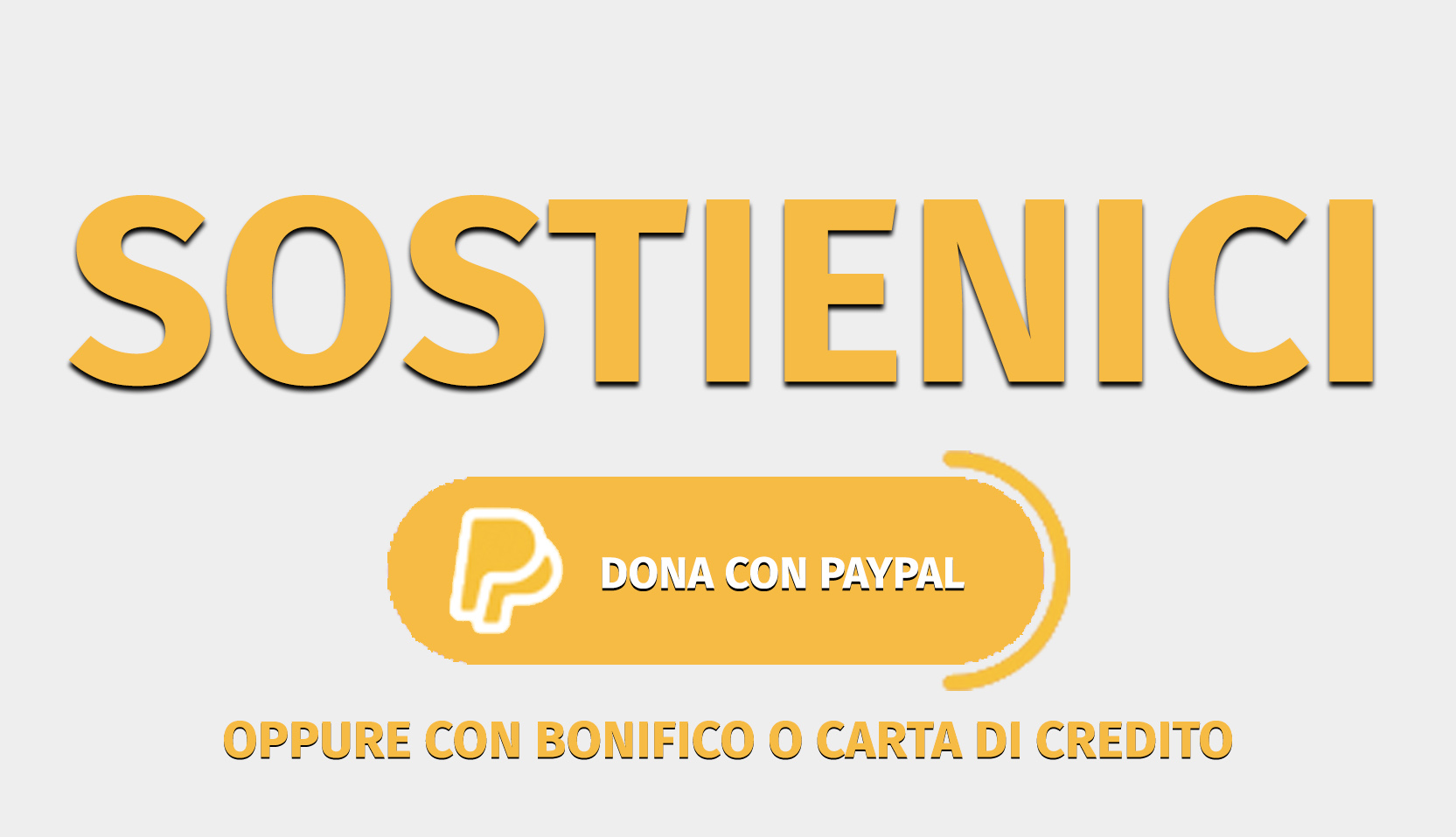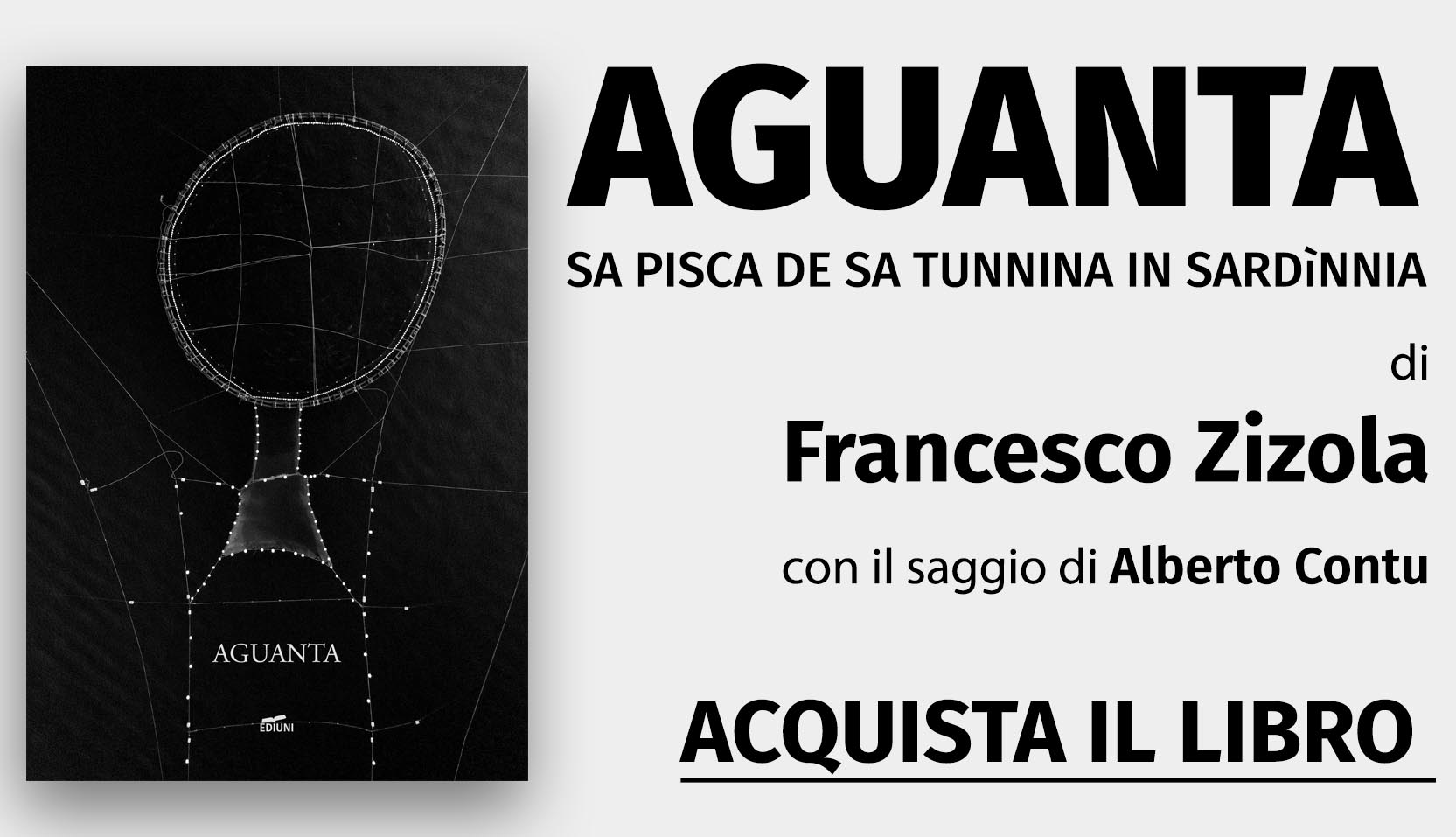Fra sos ghìrthalos d’oggi, l’utopia orunese di Pina Ghisu. Omaggio a lei, ad un anno dalla morte
di Gianfranco Murtas
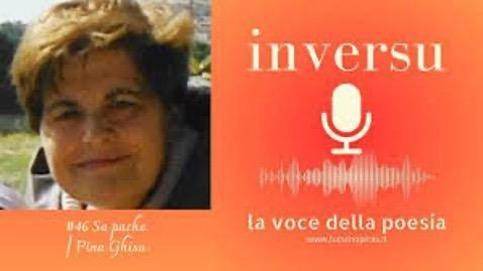
Un anno dopo la scomparsa di Pina Ghisu, donna di scuola, intellettuale barbaricina e speciale, virtuoso ponte fra Orune e Bitti, la ripenso tenendo fra le mani le tante, tante pagine – quasi 600 – di Ghìrthalos, il bellissimo volume che Sebastiano Mariani ha dedicato alla sua Orune “tra la storia e le storie”. Un’opera – giustamente detta “opera omnia” – che l’autore ci ha donato, per le fini arti editoriali di Carlo Delfino, nel 2018 – quattro anni dopo la morte di Bachisio Zizi, altrettanti o poco più (ché nel 2019 s’è prodotta addirittura una terza edizione) prima della morte di Pina, che la fatica di Mariani accompagnò nel tempo in cui gli sforzi generosi del ricercatore felicemente implementavano la raccolta di documenti e memorie. E la accompagnò questa fatica – mi pare bello ricordarlo – anticipandone qualche (lirico e materiale) contenuto nel suo commento al convegno “La violenza contemporanea nella Sardegna tra passato e futuro” organizzato nel municipio di Orune il 28 gennaio 2017: perché si unì agli auspici, presenti proprio nell’allora ancora inedito Ghìrthalos, della creazione di un “laboratorio” utopico di trama sociale capace di introdurre la sua comunità a nuove vie di futuro.
L’amicizia stretta con Bachisio Zizi e Pina Ghisu non mi assicura nessuna competenza per discettare di Orune e dei suoi tesori millenari, neppure di quelli più prossimi, di cento o duecento anni fa, che riporto al chiaroscuro – ma preferisco il chiaro – del rettore Francescangelo Satta Musio (intimo di Giorgio Asproni), o, di qua, alle tempeste esistenziali di un Antonio Pigliaru. Perché poi mi sembrerebbe un’offesa di superficialità ridurre Orune – per come Orune io l’ho capita leggendone (ma purtroppo non ci sono mai stato) – ai più noti cinque o sei o sette grandi nomi, compreso quello dell’attuale direttore del settimanale diocesano L’Ortobene, don Francesco Mariani, personalità che – al di là delle distanze di dottrina o politiche – riconosco prestigiosa per l’acume e il coraggio delle sue posizioni controvento. Perché è risaputo che di uno dei paesi sardi con più alto indice di laureati si tratta. Pasta sociale straordinaria con le sue contraddizioni fra vette di cultura e abissi di crudeltà, so bene comunque che Orune costituisce un soggetto collettivo che ha recitato la sua parte di protagonista nei secoli, e così continua nell’attualità, osservato e studiato, temuto, esecrato, ammirato, amato.
Ho il rammarico – e lo accenno appena, scrivendo queste poche righe in onore del paese e della sua Pina Ghisu – di non aver incontrato la sindaca alla quale, senza ricevere riscontro, avevo scritto per invitarla a sostenere presso le direzioni editoriali de L’Unione Sarda e de La Nuova Sardegna – purtroppo orfane adesso e del dottor Gianni Filippini e del professor Manlio Brigaglia – la pubblicazione, nelle rispettive collane di testi “identitari”, di un’antologia dei numerosi interventi accolti (e spesse volte sollecitati) dai giornali a firma di Bachisio Zizi. Occasione mancata.
Dunque Pina Ghisu e il suo fedele e carissimo amico Sebastiano Mariani cui va anche lo specialissimo merito – lo dico da cagliaritano estimatore del genio barbaricino – di aver impreziosito il suo gran volume con molte pagine, e in prosa e in versi (“Cathones in malu” e “Cathones in bonu”), di lingua orunese: un patrimonio al quale specialmente, di lato ovviamente alla umanità della vita corrente, andava l’interesse morale di Pina: perché la lingua costituiva una delle prove di autenticità dell’inarrestabile flusso storico, demografico e sociale, di una comunità pur tanto crudelmente colpita da non rari sfoghi belluini, da offese delittuose di provocazione e di vendetta. Tali, comunque e sempre, da aver colpito, senza vantaggi riconoscibili, equilibri faticosamente costruiti.
Certamente i titoli di diversi capitoli, taluno entrato nell’affollamento delle sezioni chiamate “Personaggi e spigolature” e “Sa Ura, tra reato, consuetudine e balentia. Alcuni ricordi”, e ancora “Alle radici del malessere” e “Il peso della conflittualità” – sezione comprensiva quest’ultima della meraviglia di tredici quartine dedicate a Bachisio Zizi (“Bachis un annu a oje…”), impressionano per la cadenza degli accadimenti ferali – 118 in settant’anni – che hanno segnato il corso della storia orunese contribuendo, con altri fattori evidentemente (e in primo luogo l’emigrazione alla ricerca di un lavoro dignitoso), a un certo depauperamento delle risorse. Il che è vero se è vero quanto la stessa Pina Ghisu, in un memorabile articolo postato ora sono diversi anni fa (il 26 gennaio 2017) nel sito SardegnaSoprattutto, aveva segnalato, con la popolazione più che dimezzata in pochi decenni, gli stessi che avevano ridotto del novanta per cento le nuove nascite, ormai soccombenti nelle tabelle demografiche rispetto ai numeri dei decessi: 151 nel 1910, 12 nel 2014 a fronte di 23 morti.
« Orune è chiamato a capovolgere il suo paradigma, a far sì che ciò che sino ad oggi è stato orunesità negativa, col suo trascorso faticoso e dolente, diventi una nuova via per proporsi in questa era del post industriale e del post terziario. I valori della resistenza al tempo, che si sono silenziosamente accumulati e stratificati in caratteri forti e indomiti, quei legami di barriera al bisogno, alla disgrazia, al nemico, che hanno unito nei secoli tante mani, oggi possono mettere predas d’unnamentu per un futuro orgoglioso del loro passato. Basterà volerlo » .
È con la passione teologica della credente che Pina individua « l’ultima invisibile risorsa: l’Utopia, il progetto che tutti hanno sempre temuto, ma che rimane nell’aria in attesa che un Folle lo sposi e insieme possano cambiare il corso di una storia sbagliata. L’Utopia è che un giorno finalmente Orune diventi il centro di un grande progetto di salvataggio del suo e degli altri popoli montani dall’erosione, dal pericolo della loro scomparsa, dal crollo definitivo ».
Come fare? « Filosofi, poeti, ingegneri, architetti, linguisti, agronomi, educatori, giovani visionari, dovranno sedersi intorno ad un tavolo in una stanza chiusa e uscire solo quando la loro folle fantasia e la loro scienza avrà un modello da proporre per rivedere questo popolo carico di millenni di storia ». Mi viene da pensare ad un immaginario convegno a porte chiuse – un vero e proprio conclave – fra il rettore Satta e il giovane dialettico Alessio Biote de Il ponte di Marreri di Bachisio Zizi…
« Orune sarà come la cellula in laboratorio sulla quale si sperimenta il nuovo farmaco, dovrà essere un progetto senza luogo né tempo, dovrà rappresentare l’universale, il come un popolo riprende un cammino verso il futuro …
« Dovrà parlarsi di pace, di perdono, di lingua, di lavoro, di emigrati, di rientri, di equità, di onestà, di uguaglianza, di terra, di clima, di assistenza, di animali, di storia, di piante, di poesia, di giochi, di riti, di allegria, di immortalità del pensiero, di luce, di perdono, della salute del corpo e dell’anima.
«È un dovere storico e morale costruire questa Utopia, i popoli non si lasciano morire, i popoli devono essere chiamati a costruire e non a fermare la storia. Sapranno i nostri uomini e le nostre donne essere popolo? ».
Questa poesia di coscienza che Pina Ghisu ha donato alla sua comunità nativa, e pensandola estesa nelle intenzioni all’intera Barbagia, in primo luogo ai bittesi compaesani sì di Giorgio Asproni e di Francescangelo Satta Musio ma anche del suo sposo indimenticato, resta il suo testamento di vita. Di una vita – la vita di una educatrice ed insegnante delle nuove generazioni – che permane feconda oltre ogni convenzione od apparenza.
Devi accedere per poter commentare.