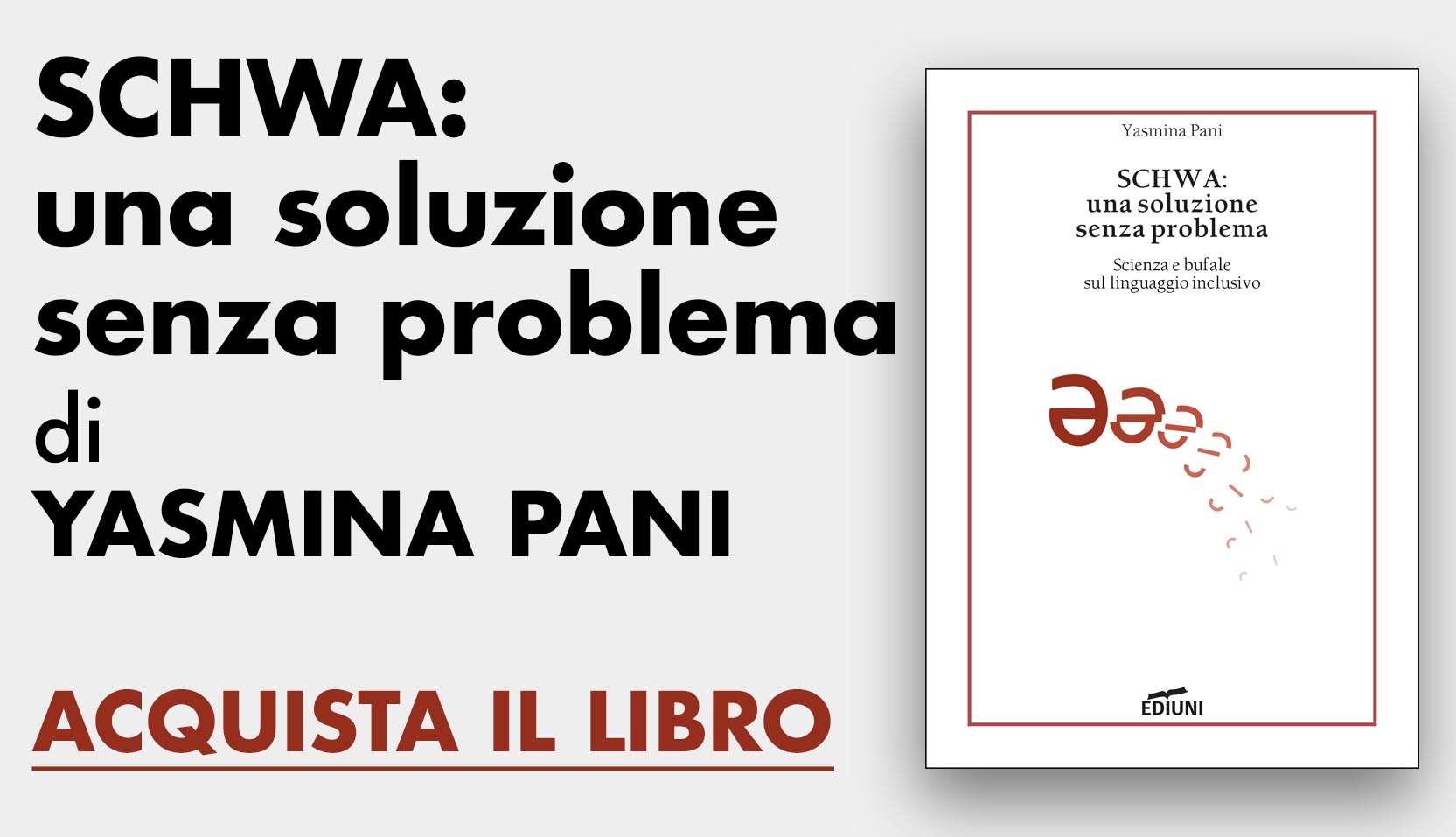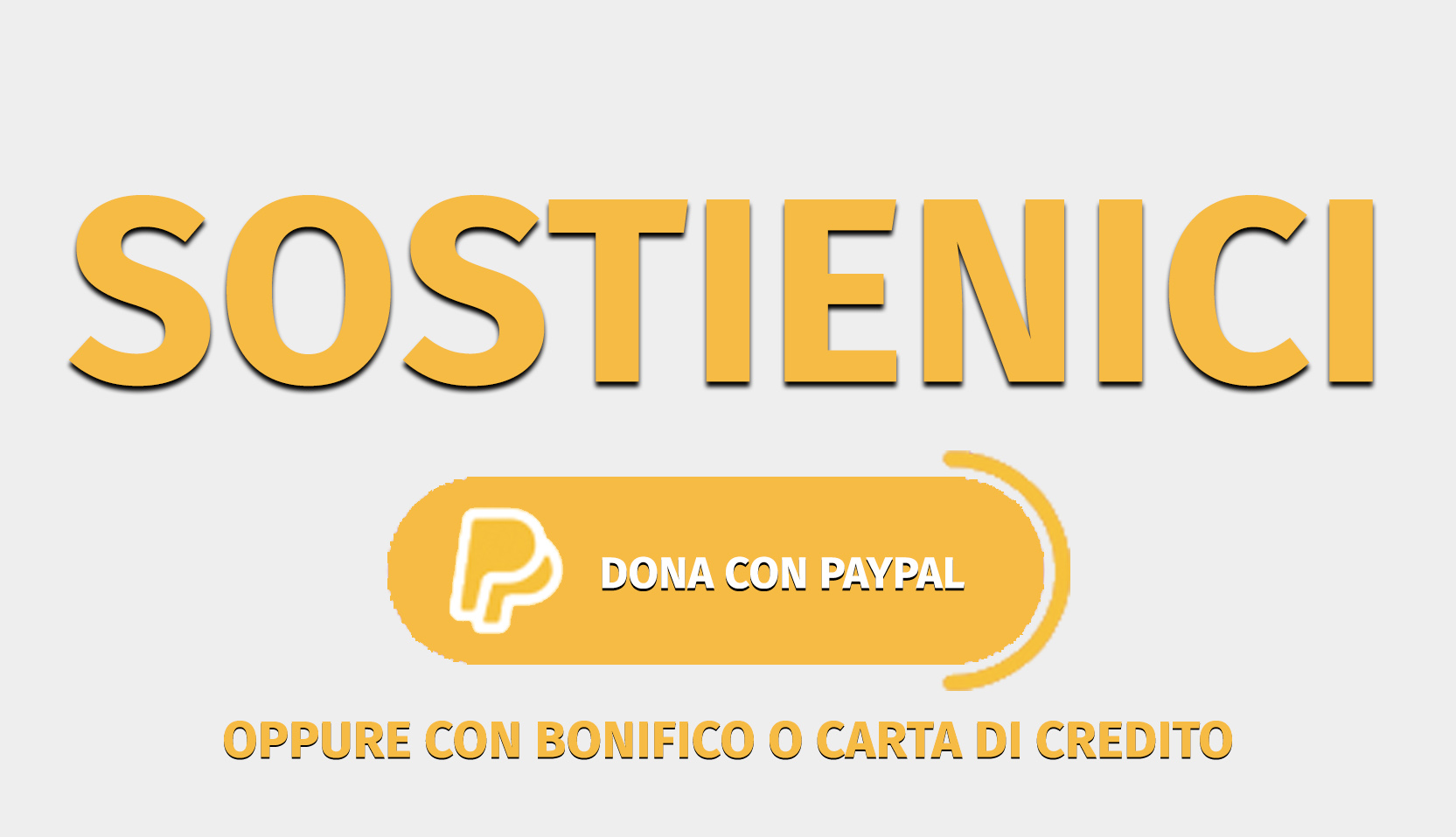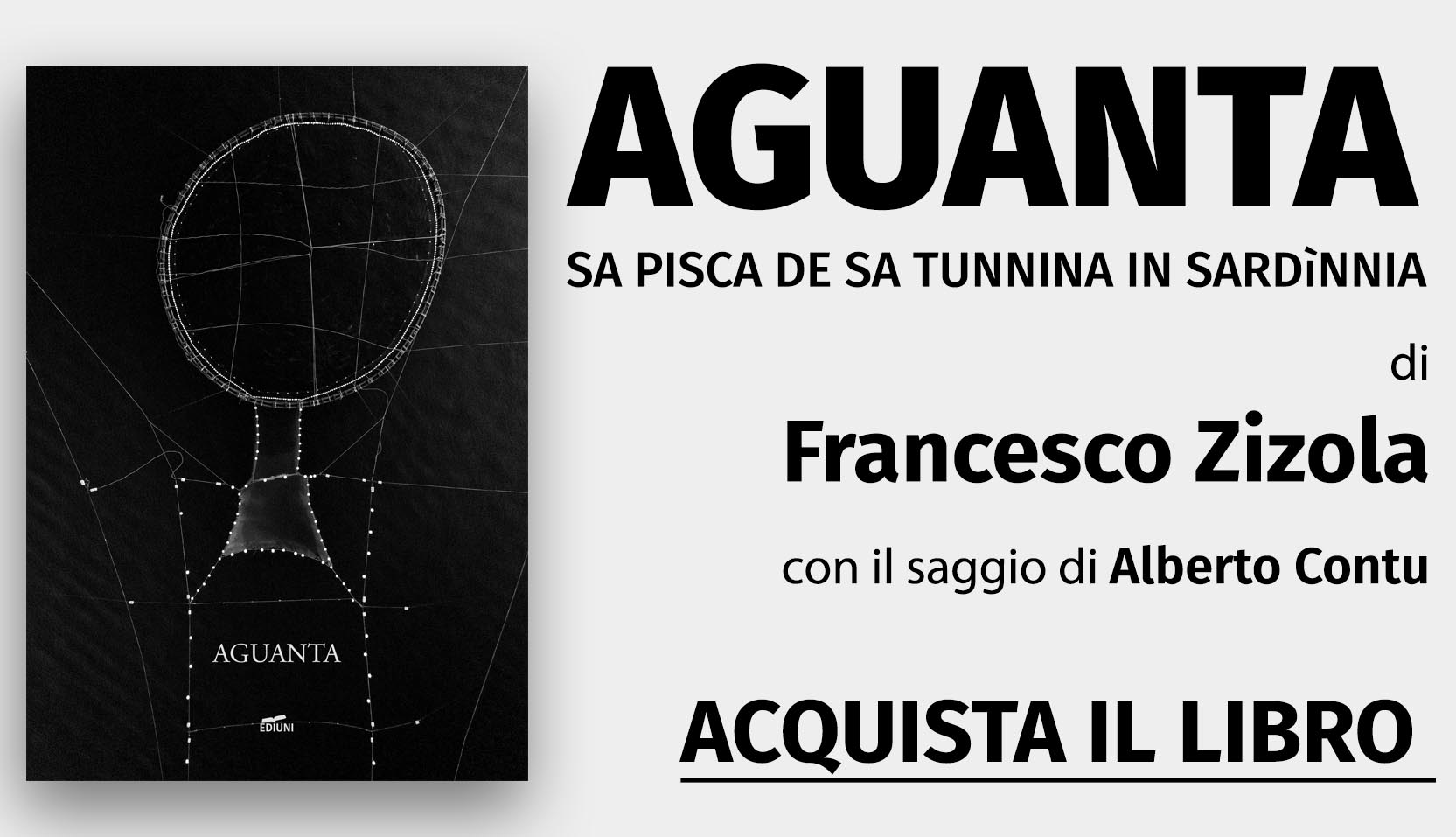Il sardismo dialogico di Pietro Mastino
di Gianfranco Murtas
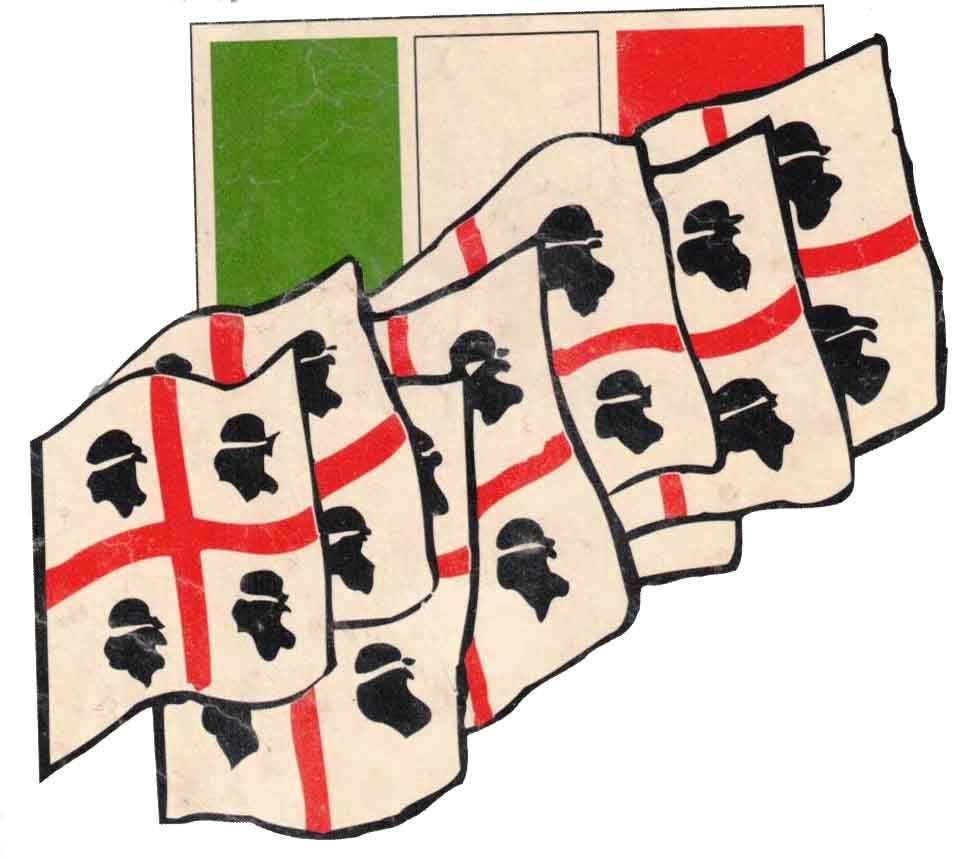
Si è tenuta nella serata dello scorso giovedì 25 settembre, presso l’auditorium della Biblioteca “Sebastiano Satta” di Nuoro, la presentazione del libro curato da Annico Pau “Pietro Mastino fra umanesimo, aule di giustizia, politica e impegno civile”, pubblicato da Paolo Sorba editore con il patrocinio della Associazione Mazziniana Italiana. Si tratta degli atti (utilmente integrati) del convegno celebrativo che si tenne, anche quella volta alla “Satta” di Nuoro, il 20 settembre 2019, a cinquant’anni dalla morte del grande avvocato.
L’occasione è stata opportunamente colta per un “viaggio” ancora largo intorno alla ricca personalità di chi fu, sì, un grande avvocato ma anche parlamentare, prima del Regno poi (dopo la tempesta fascista e bellica) della Repubblica, nel segno del sardismo – s’intende del sardismo d’un tempo! non certo di quello scombinato, cialtrone e senza nessuna bussola ideale d’oggi, che dopo l’ubriacatura antistorica e reazionaria del nazionalitarismo/indipendentismo durata ben vent’anni (“noi sardi, voi italiani!” e bestialità simili si udivano nelle tribune congressuali e nella polemica corrente), s’è, all’opposto, fatto panitalianista/paraleghista in questi ultimi sfortunati tempi. Parlamentare alla Camera negli anni 1919-1924 (o 1926, se guardiamo alla convergenza aventiniana) e senatore di diritto nel quinquennio 1948-1953, nonché padre costituente all’indomani del referendum istituzionale. Ed ancora: abile ed autorevole sindaco di Nuoro fra il 1956 e il 1960, il sindaco che, pur teso nelle impregnative fatiche amministrative, trovò tempo ed energie morali per accogliere nella città amata le spoglie di Grazia Deledda così appagando un sogno dei migliori che verso la grande scrittrice avvertivano un debito di riconoscenza, dopo tanta ingrata e diffusa incomprensione.
Presentati i relatori dal professor Annico Pau – anch’egli, nei primi anni ’80, sindaco del capoluogo barbaricino e sindaco di cultura repubblicana autonomistica, ora e da molti anni presidente della benemerita sezione “Giorgio Asproni” dell’Associazione Mazziniana Italiana * – la bella serata, onorata dalla presenza di un folto pubblico che ha interamente riempito la grande sala, s’è rivelata pienamente rispondente alle aspettative e le copie del libro in distribuzione sono andate presto esaurite.
In quanto ai relatori, è intervenuto per primo l’avv. Basilio Brodu che, da par suo, ha ricordato – con una relazione molto articolata ed approfondita, elegantissima anche nella forma – la bella figura dell’avv. Gianni Sannio, scomparso di recente ed un cui contributo su Mastino protagonista delle aule di giustizia offerto al convegno AMI del 2019, è riportato nel volume degli atti in presentazione e, come detto, già in distribuzione : “Pietro Mastino: maestro dell’argomentazione giuridica”. Un riconoscimento doveroso, questo reso all’avvocato orunese allievo di Antonio Pigliaru, che fu – tanto più nella lunghissima e penosa stagione dei sequestri di persona (talvolta con conseguenze ferali) nell’Isola – uno dei patroni protagonisti della scena giudiziaria sarda.
Dopo l’avv. Brodu ha preso la parola il professor Costantino Murgia, costituzionalista, che – ha raccontato – incontrò da giovane studente universitario l’avv. Mastino che gli si mostrò affettuosamente accogliente e… sapiente nello spazio di quella prima visita nuorese. Il professore ha dato conto di Pietro Mastino deputato all’Assemblea Costituente dove fu, insieme con Emilio Lussu, membro del gruppo cosiddetto “Autonomista” comprensivo degli azionisti e di un valdostano, fra il 1946 e il 1948. Egli ha riferito di alcuni fra i numerosi interventi (con qualche… collegata curiosità) svolti dal leader sardista a Montecitorio su una vasta gamma di temi.
È toccato poi al professor Antonello Pipere, presidente della Fondazione “Luigi Oggiano”, che ha concisamente illustrato la prossimità ideale e politica, oltreché la “pari dignità” professionale, fra l’avvocato siniscolese e Mastino, amici per tutta una lunga vita, e come già documentato in un bel libro di Elettrio Corda (Due storie parallele, 1996). Fu proprio Oggiano, l’avvocato “santo”, il “sempre mazziniano” e fra i primissimi dirigenti del Partito Sardo d’Azione come anche, agli inizi degli anni ’20 dello scorso secolo, della Federazione Regionale Combattenti, ad aver “imposto” Mastino, nel 1956, ai riottosi e maggioritari democristiani quale sindaco di Nuoro. E fu ancora Oggiano a celebrare il collega e fraterno sodale alla sua morte, nella primavera 1969, dopo anche la rottura politica interna al PSd’A, dove le mitologie castriste di Fidel – alias Simon Mossa – si erano insinuate sbalestrando la militanza e raggiungendo perfino qualche zona della dirigenza.
Ho quindi parlato io, rinunciando – data la avvenuta consumazione dei tempi – a leggere la relazione preparata per l’occasione – e limitandomi a una rapida… affabulazione sul “sardismo dialogico” di Mastino, e cioè sulla sua propensione all’incontro, e la concreta attività svolta per sostenere utili relazioni del Partito Sardo d’Azione con alcune forze politiche nazionali di cultura fieramente democratica e sensibilità meridionalista (da Rinnovamento nel 1920 al Partito d’Azione nel 1944, al Partito Repubblicano nel 1963 e 1968, dopo che con gli olivettiani nel 1958), così come alla sua associazione a gruppi parlamentari ispirati – come quello azionista o quello Democratico di sinistra nella prima legislatura repubblicana – a convergenti idealità laiche e progressiste.
Le conclusioni sono toccate al brillante giovane avvocato Martino Salis, pronipote del senatore Mastino e diligente curatore del fondo archivistico ancora custodito nella grande casa a un passo dai Giardinetti nuoresi che ospitò, giusto nei giorni della marcia di Roma dei fascisti, il terzo congresso regionale del PSd’A conclusosi con le dichiarazioni di assoluta lealtà democratica del partito. Salis ha bene illustrato le migliori virtù professionali di Mastino nelle aule di giustizia sarde e la sua passione letteraria (né soltanto verso gli autori isolani come Sebastiano Satta e la Deledda, ma anche nazionali come Giosuè Carducci le cui produzioni furono da lui studiate e partitamente commentate, in piccoli quaderni rinvenuti di recente).

Qui di seguito riporto il testo della mia comunicazione non letta ma riassunta in pochi minuti, come ho accennato, attraverso una certa affabulazione che, nonostante l’improvvisazione, mi è sembrato abbia comunque interessato l’uditorio che comprendeva anche molti anziani i quali conobbero e frequentarono, nella loro giovinezza, il sindaco-senatore ed ammirarono il patrono di cause spesso disperate di cui le cronache giudiziarie dei giornali erano l’eco e spunto di infiniti commenti nella cittadinanza.
*Spiace rilevare sempre che, a fronte della generosa attività della sezione nuorese dell’AMI – che nel nome di Asproni riassume le sue idealità democratiche e patriottiche e la sua laica devozione alla tradizione del risorgimento unitario – la presidenza nazionale, quando interpellata per le offese ripetutamente recate, neppure tanto tempo fa, alla memoria di Mazzini e Giovanni Bovio da un imbecillissimo Salapuzio delle spelonche nostre isolane copertosi col manto del Grande Oriente d’Italia (incapace esso stesso di bonificare il campo), abbia disertato indecorosamente. Il reato morale resterà nella storia onorevolissima di una Associazione che ha avuto fra i suoi presidenti autentici uomini d’oro come Luigi Salvatorelli, Giuseppe Chiostergi, Giuseppe Tramarollo, Michele Cifarelli e altri ancora degnissimi custodi del lascito mazziniano. Ma capita, nella storia dell’associazionismo, che la periferia riscatti talvolta gli inciampi del centro.
Una vita per la Sardegna nella civiltà italiana
È del resocontista dal Senato della Repubblica Tommaso Martella, in forza al Corriere della Sera negli anni ’40 e ’50, la qualificazione di Oggiano e Mastino come “fratelli siamesi”. Così li chiama lui, ma riferisce che così essi erano generalmente chiamati (e sentiti) a Palazzo Madama, scrivendone nel suo volume Senatori in graticola uscito dopo le elezioni politiche del 1953 – quelle dette della “legge truffa”
(che mi permetterei di dire che non era per nulla una “legge truffa”, ma una legge maggioritaria, niente rispetto al maggioritario d’oggi ed assolutamente non confrontabile con il maggioritario della Acerbo del 1924: quest’ultima e quella di oggi ingrossavano/ingrossano le minoranze, la legge del 1953 premiava la maggioranza).
1953: termina la esperienza parlamentare di cinque anni di Luigi Oggiano, e termina quella più complessa, doppia per temporalità, di Pietro Mastino:
. deputato alla Camera per cinque anni, dal 1919, più stagione aventiniana 1924-1926 – prima e al radicarsi della dittatura,
. deputato alla Costituente per quasi due altri anni, fra 1946 e 1948, senatore di diritto (premiato perché dichiarato decaduto dalla legge fascista del 9 novembre 1926) dal 1948 al 1953 appunto, nella lunga stagione dei governi De Gasperi, che avevano coperto non soltanto la prima legislatura repubblicana, ma anche – tornando all’indietro – il biennio costituente e perfino il semestre precedente, nel 1946, dopo la caduta del governo Parri che era stato di breve durata, dopo la liberazione.
Quel governo Parri alla cui presidenza Mastino con Lussu aveva accompagnato, nel luglio 1945, una delegazione sardista per discutere di interessi regionali (suscitando aspre polemiche da liberali e democristiani) e del quale Mastino fece parte come sottosegretario al Tesoro con delega ai danni di guerra (essendo stata istituita con decreto luogotenenziale dell’agosto 1945 una Direzione generale dedicata), esperienza proseguita appunto nel primo governo De Gasperi.
Inquadramento temporale delle vicende 1943-1953, fra la caduta del fascismo (1943) e la fine della esperienza politico-parlamentare di Pietro Mastino.
Debbo confessare che all’invito di Annico Pau di partecipare oggi ad una serata in onore di Pietro Mastino, nell’occasione della presentazione degli atti del convegno del 2019, e alla sua precisa richiesta di un possibile titolo del mio intervento, io avevo sparato “il sardismo dialogico di Pietro Mastino”, intendendo alludere alle esperienze parlamentari del Nostro – quelle di cento anni fa, ante-fascismo, e quelle settanta-ottanta anni fa, post-fascismo – ed alla sua prevalente collocazione in gruppi misti che però esprimevano, o ambivano esprimere, un indirizzo unitario: mi riferisco
. al gruppo “del Rinnovamento” nel 1919-20,
. a quello – subito abortito – del Partito Italiano d’Azione (d’intesa coi molisani) fra 1920 e 1921,
. a quello Autonomista, con gli azionisti e un valdostano, alla Costituente,
. a quello cosiddetto Democratico di sinistra fra 1948 e 1953.
Ciò per entrare anche nel merito di quel tabù che, in qualche modo, paralizzò il Partito Sardo d’Azione di quegli anni lontani circa i cosiddetti “apparentamenti”, che sembravano essere, nel sentire di qualcuno, una bestemmia, una autoconsegna al vassallaggio di qualche maggiore formazione nazionale.
Un tabù, quello degli “apparentamenti” o dei “collegamenti”, che naturalmente si nutrì di umori diversi a seconda della stagione politica, o storico-politica vissuta dalla patria.
Perché se oggi il sardismo si presenta alleato della Lega – quella dell’ampolla del dio Po e della tripartizione dell’Italia in megaregioni e della subcapitale a Monza, quella dei 49 milioni di euro da restituire per multa alle casse dello Stato, e in epoca recente del sovranismo iperitaliano in solidarietà con Putin – e se ieri mattina, quello stesso sardismo si proclamava nazionalitario e indipendentista nella logica del “noi sardi voi italiani”,
certamente il sardismo di Pietro Mastino e di Luigi Oggiano, di Titino Melis e Luigi Battista Puggioni, il sardismo che era stato di Camillo Bellieni era ben altra cosa se guardava alle proprie ascendenze patriottiche riferendosi alla scuola democratica del risorgimento: quella di Mazzini e Cattaneo e anche Garibaldi, di Giorgio Asproni e Giovanni Battista Tuveri. Non una melassa dai cento cuochi, ma un valore seppure filtrato dalle storiche necessità sarde.
Se noi scorriamo le pagine della “Voce dei combattenti” e del “Solco”, i giornalisti sardisti e presardisti degli anni 1919-1925, vi troveremmo cento, duecento volte riportati, a mo’ di catechismo, anche in prima pagina, estratti dalle opere di Mazzini e Cattaneo, Bovio e Asproni ecc. E il riferimento alla scuola democratica, con le sue istanze federaliste e autonomistiche miste a quelle meridionaliste, si attualizzava – era lì il primo Mastino politico – nei nessi che si stabilivano con le battaglie dell’antiproibizionismo, in difesa delle produzioni agrario-zootecniche del Mezzogiorno e delle Isole sacrificate nelle esportazioni dai prevalenti interessi dell’industria del nord, protetta insieme, per convergenza d’interessi, dal capitalismo e dal socialismo e sindacalismo operaio.
La scuola democratica rispetto al liberalismo e al socialismo: convergenze e distinzioni. Il centro della libertà nell’istituzionale non nell’economico: suffragio universale (incluso quello femminile), Repubblica, autonomie territoriali, separazione Stato-Chiesa e scuola pubblica, europeismo.
Il dramma sardista: convergenze sì, no, e con chi?
Dunque gli “apparentamenti” o i “collegamenti”.
Ho molto lavorato sul patto federativo del 1944-1946 del sardismo con il Partito d’Azione – nobilissima formazione sorta in clandestinità nel 1942 e che ebbe diverse matrici confluenti, la principale delle quali – di lato a quella primofondativa democratico-liberale, già amendoliana, di Ugo La Malfa e Adolfo Tino – sarà, a fine 1943, quella di provenienza di Giustizia e Libertà ormai a prevalenza socialista, e con Emilio Lussu leader trainante.
Ma se certo il rapporto con il Partito d’Azione ha un suo fascino speciale perché coinvolge anche uomini come Cesare Pintus – cinque anni di galera fascista, una tubercolosi contratta in carcere che lo porterà a morte neppure 50enne, nel 1948 – e come Gonario Pinna, e l’uno e l’altro di formazione repubblicana (e perché prende corpo quando l’Italia si prepara a passare alla democrazia rappresentativa piena e agli statuti della Repubblica), pure non fu quello, come accennato, un caso solitario.
E dunque? Dunque volevo riferire del “sardismo dialogico” di Pietro Mastino dal 1919 al 1953, ma direi fino al 1968-69, arrivando all’esplicito e documentato invito rivolto dal senatore a sostenere, alle elezioni politiche, i sardisti che si presentavano nella lista dell’Edera – l’edera di Mazzini e della Giovane Europa –, replicando l’esperienza del 1963, che aveva propiziato l’elezione parlamentare di Giovanni Battista Melis nel gruppo repubblicano.
Per questo avevo dedicato qualche giorno a recuperare notizie da portare oggi qui a Nuoro per riferirne con qualche nuovo dettaglio, ma poi – leggendo proprio nel volume sugli atti del convegno del 2019, il bel testo del contributo fornito allora e forse adesso integrato di Aldo Borghesi, che proprio sulla materia rendicontava utilmente, mi sono trovato a dover fare macchina indietro e a trattare adesso la materia sotto altri riflettori.
Intanto dirò che i miei riflettori nuoresi illuminano una realtà sociale che se è stata il “nido di corvi” di cui scrive Salvatore Satta, è stata ed è anche tanto altro e il contrario anche del “nido di corvi”, né soltanto, per facile ricorso alle retoriche mitologiche, è ascrivibile al cielo della universalità proprio dell’ “Atene sarda”, e dunque della relazione con i meridiani e paralleli del vasto mondo: come nella letteratura con la Deledda e anche la Giacobbe e lo stesso Satta, come nell’arte eminentemente con Ciusa (e perché no con Palazzi e Ballero e Delitala), dico nella politica con Pietro Mastino portatore di un “sardismo dialogico”, non dottrinario e chiuso, ma volto alla storia, sia pure diversamente da come volto alla storia l’aveva inteso Lussu, che il sardismo delle origini l’aveva assorbito in un socialismo infine dogmatico, suggestivo ma dogmatico.
Certo si trattò, da parte di Mastino, di un sardismo intimamente connesso con l’idea di patria – patria italiana – com’era stata celebrata nel primo dopoguerra anche da coloro che contestavano il governo accentratore di Roma, e com’era rilanciata nel secondo dopoguerra, all’interno della missione repubblicana, del cambio del regime costituzionale che avrebbe anche portato ad un assetto regionalista.
Anni 1919-1925
Dovendo andare in velocità ricorderò, negli anni del prefascismo, la partecipazione al gruppo salveminiano, chiamiamolo meridionalista o del “socialismo rurale”, detto “del Rinnovamento”. Si era nel 1920, nei primi mesi della esperienza parlamentare allora compiuta con Maurino Angioni e con Paolo Orano, il contestatissimo e ambiguo Orano che fu il primo, nel 1922, a passare dal sardismo al fascismo, come fece poi anche Angioni.
Quel gruppo, che aveva relazioni non sempre lineari con l’Associazione Nazionale Combattenti e con le riviste politiche democratiche del tempo e in special modo con “Volontà”, cui collaboravano Camillo Bellieni, Francesco Fancello e altri sardi, si sfaldò all’indomani della sua stessa costituzione e il “ponte” che soprattutto Bellieni aveva cercato di realizzare con forze politiche presenti nel continente egualmente impegnate nella battaglia meridionalista e autonomista crollò lasciando qualche residua eredità di speranza in un ipotetico Partito Italiano d’Azione.
Un primo nucleo del Partito Italiano d’Azione – che niente aveva a che fare naturalmente con quello degli anni della Resistenza – si materializzò in certe intese che Bellieni soprattutto ebbe la capacità di allacciare con il Partito Molisano d’Azione, come anche con altri gruppi lucani, liguri e d’altra parte d’Italia.
Si era nel 1921-22. Le elezioni della primavera 1921 – svoltesi un mese dopo la fondazione formale, ad Oristano, del Partito Sardo d’Azione – avevano portato alla rielezione di Mastino e Orano, ed alla elezione di Umberto Cao e finalmente di Lussu ormai trentenne.
Il passaggio al fascismo, neppure così sorprendente, nel corso del 1922, dei due deputati molisani con i quali si era in contatto, rovinò anche questo disegno; e peraltro anche in campo sardista cominciarono, dopo la fuga di Orano, le defezioni e gli abbandoni, implementatisi nei primi mesi del 1923.
Si ricordi che il 28 ottobre 1922, lo stesso giorno della marcia fascista su Roma e vigilia del conferimento a Mussolini dell’incarico di presidente del Consiglio da parte di Vittorio Emanuele III, i sardisti tennero a Nuoro, proprio a casa Mastino, il loro III congresso, preceduto dal IV dell’Associazione Combattenti: e tutto fu all’insegna dell’avversione al nuovo regime che si profilava, così anche da parte di chi, pochi mesi dopo, avrebbe fatto il gran passaggio al PNF, fra cui il nuovo direttore regionale Paolo Pili.
Mi permetto di segnalare qui il prezioso volume curato da Luigi Nieddu per Gallizzi ora sono già quarant’anni Camillo Bellieni. Partito Sardo d’Azione e Repubblica federale. Scritti 1919-1925. Tanto della geografia interna del partito dei Quattro Mori – e dei due prevalenti orientamenti, quello dei salveminiani sassaresi, dunque di Bellieni e Puggioni ecc., e quello cosiddetto sindacalista rivoluzionario dei cagliaritani lussiani – quanto dei tentativi, soprattutto bellieniani, di collegare il Partito Sardo a un più generale movimento riformatore e meridionalista le cui tracce potevano cogliersi qua e là nella penisola, tratta la lunga introduzione al libro. Da essa anche emerge – e Mastino ne sarà una delle prove viventi – il proposito del primo sardismo di non limitare la propria battaglia politica al rivendicazionismo isolano verso il governo centrale (e tanto meno limitarla nel senso di una specie di patronato alle ragioni dei reduci) ma di allargare alle necessità di una più complessiva riorganizzazione dello Stato, come anche s’era già espresso il famoso congresso di Macomer del 1920.
Le elezioni del 1924, condizionate dall’applicazione della legge Acerbo, videro il dimezzamento della rappresentanza sardista, seppure la vicinanza ai repubblicani parve dimostrata non soltanto dalla testata quotidiana “Sardegna” che uscì, a firma abbinata sardista-repubblicana, Angius-Mastio, in tempo di campagna elettorale, ma anche da una intervista di grosso impatto di Emilio Lussu a “La Voce Repubblicana”.
Fu questione di settimane. L’assassinio di Giacomo Matteotti portò l’opposizione sull’Aventino, nella speranza che questa protesta di massa da parte dei parlamentari inducesse il re Savoia ad un intervento che invece non ci fu. E anzi da lì si accelerarono i tempi del regime che con la legge del novembre 1926 dichiarò la decadenza di ben 123 deputati.
Fu una battaglia nata nobile e nobilissima quella dell’Aventino, che però si isterilì cammin facendo, come anche Lussu e Mastino sostennero. Gli storici ancora dibattono sulla possibile o impossibile efficacia di quella mossa che coinvolse uomini e partiti.
Anche Pietro Mastino cadde nella trappola e un ristoro l’ebbe soltanto nel 1948, dal III articolo delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione, divenendo senatore di diritto nella prima legislatura repubblicana.
Contro il regime
Sono note le modalità, tutte morali, dell’antifascismo di Pietro Mastino che a Nuoro trovò sponda in consentaneità non soltanto nei suoi, da Luigi Oggiano ai Melis a Gonario Pinna repubblicano – per dirne di qualcuno soltanto – ma anche in socialisti come Filippo Satta Galfrè – fratello maggiore di Salvatore Satta – e cattolici come Salvatore Mannironi, tutti sempre spiati dall’OVRA. Rimando qui alla vasta pubblicistica e saggistica presente nelle nostre biblioteche, ma in particolare – per essere essi apripista – i contributi accolti da Manlio Brigaglia con i colleghi Francesco Manconi, Antonello Mattone e Guido Melis nei due volumi L’antifascismo in Sardegna, che le edizioni Della Torre ci presentarono anch’esse quasi quarant’anni fa, nel 1986.
L’incontro-scontro con Lussu, gli azionisti
Dopo l’armistizio dell’8 settembre e la ripresa di vitalità della democrazia italiana, e anche sarda, Mastino riconquistò una sua netta e chiara leadership favorita da alcuni elementi che mi paiono decisivi:
. intanto dalla sua figura patriarcale, veneranda per la statura professionale più ancora che per l’anagrafe (60 anni nel 1943);
. per il suo passato parlamentare e la qualificazione democratica ben noti alla militanza in risveglio;
. per l’alterità che, pur con tutte le cortesie non soltanto formali ma certamente sentite nell’umano, egli rappresentò nei confronti di un Lussu rivelatosi dottrinario: il quale Lussu, rientrando in Sardegna nel luglio 1944, e dopo dieci mesi dal suo rientro dall’estero (per la sosta partigiana a Roma e sul continente, con Joyce), aveva portato fra la militanza sardista la sua nuova identità maturata nei tre lustri e passa di fuoriuscitismo, a contatto con l’antifascismo di mezzo mondo; e quella sua nuova identità era una identità socialista, assolutamente non apprezzata, pur con tutta l’ammirazione per il combattente e anche per l’eroe della grande guerra, da una base moderata, di pianta rurale (e anche cattolica) in prevalenza.
La questione che si pose allora fu l’alleanza sardista con gli azionisti, dei quali Lussu era allora uno degli esponenti più in vista e capo addirittura della corrente socialista. A lui, cui era concessa la possibilità della doppia tessera, interessava – e fu illusione – conglobare il Partito Sardo d’Azione nel Partito d’Azione, facendosi egli garante della piena compatibilità ideale e programmatica della nuova formazione attiva tanto nella guerra partigiana del centro-nord quanto nelle nuove intese del CLN che avevano portato, dopo la liberazione di Roma – il 4 giugno 1944 –, al primo governo Bonomi. Quel governo (allora con sede a Salerno) che vedeva il sassarese Stefano Siglienti sardista-giellista-azionista ministro delle Finanze, dopo esser stato per cinque mesi a rischio di deportazione in Germania, detenuto in un campo di prigionia nazista ai confini della capitale, da cui riuscì ad evadere grazie alle arti della moglie repubblicana Ines Berlinguer. (Ma davvero non si trattò di un passaggio… dalle stalle alle stelle!! Il ministro delle Finanze doveva amministrare una Italia semidistrutta dalla guerra e ancora per un anno divisa fra nord e sud per l’occupazione nazista).
A Lussu interessava affermare a Roma la maggioranza della sua corrente giellista-socialista all’interno del Partito d’Azione, contro l’area democratico-liberale, riformatrice, di Ugo La Malfa (e un domani anche di Ferruccio Parri). E per questo intendeva accreditarsi anche come leader del Partito Sardo d’Azione sostenendo che da quel partito sarebbero giunti all’azionismo, per il suo “ponte”, ben 50mila militanti isolani (che peraltro, più realisticamente, erano quantificati allora in 37mila).
Comunque sia, dopo aver giocato la carta della unificazione, mandando al VI congresso sardista del luglio 1944, presieduto da Mastino a Macomer, Fancello e Siglienti, che sostennero quella posizione, si adattò pragmaticamente alla formula della federazione: confluenza nelle sezioni sardiste degli azionisti isolani (che poi, da lussiani, erano di matrice sardista anch’essi), e patto federativo per cui il PSd’A conservava la sua autonomia organizzativa riconoscendosi, circa la politica nazionale e internazionale, nelle scelte del Partito d’Azione (ove non confliggenti con l’interesse della Sardegna).
Il dibattito fu impegnativo per tutti e Mastino – summa e mediazione – seppe tenerne i fili, fino a firmare, con altri, il documento finale votato a grande maggioranza dai partecipanti, ed anche firmando un articolo editoriale per il numero unico “Forza Paris” uscito all’indomani del congresso: “Noi continueremo la nostra strada; la continueremo in cordiale accordo con i nuovi amici politici che lealmente verranno e lealmente accoglieremo nelle nostre file, animati tutti dalla speranza che la Sardegna, con tutte le altre regioni italiane – e cioè la patria – sorga, dopo tanto sangue, ad una vita che sia veramente di libertà e di giustizia sociale per tutti”.
Tutto questo dopo aver, in sede di apertura del congresso, rilevato “con compiacimento” la presenza del fervente repubblicano nuorese Peppino Fantoni e sottolineato la pregiudiziale repubblicana del Partito Sardo, ricordando, testualmente: “Lussu, Siglienti e Fantoni scrissero durante l’anno di dominazione tedesca in Roma, pagine di sacrifizio e di eroismo non inferiori a quelle più fulgide del Risorgimento”.
Fu questo il patto del settembre 1944 e sarà interessante ricordare – pensando anche a Nuoro – che Gonario Pinna, repubblicano confluito nel Partito d’Azione dopo il congresso dei CLN in Bari, del gennaio 1944, sulla errata convinzione che l’intero PRI, esterno al CLN, fosse confluito nell’azionismo, avvertì (lui con Cesare Pintus, e Cesare Pintus con lui)… avvertì Lussu che il passaggio al sardismo non avrebbe potuto significare mai e poi mai obiettare sull’unità della patria italiana, così a scanso di qualche pressione polemicamente secessionista che s’alzava qua e là dalle fila del Partito Sardo.
Vennero dunque in successione due governi, entrambi semestrali, di CLN fra 1944 e 1945. Il 25 aprile 1945 la liberazione di Milano e del nord Italia, da lì l’unificazione del CLN politico romano – quello ispirativo dei governi – con il CLN Alta Italia di Milano, e da lì l’affidamento a Ferruccio Parri, azionista ed uno dei capi del CLNAI, della presidenza del Consiglio dopo Bonomi.
Nel governo Parri e nel governo De Gasperi I
E qui ecco Mastino su due campi: quello governativo e quello politico-partitico.
Il patto federativo fra Partito Sardo e Partito d’Azione dovette allora tradursi anche nell’attribuzione agli uomini del Partito Sardo di incarichi all’interno sia del governo che, qualche mese dopo, della Consulta nazionale, organismo succedaneo di un parlamento che ancora non s’era eletto, e col compito di assistere il governo nella legislazione, dato che questa era allora devoluta allo stesso esecutivo.
Sicché nella Consulta nazionale, in quota di Partito d’Azione entrò anche il sardista sassarese Luigi Battista Puggioni, e nel governo – il governo Parri – , sempre in quota del Partito d’Azione entrò anche il nostro Pietro Mastino. In quel governo – che vedeva Lussu ministro per l’assistenza post-bellica – Mastino ebbe l’incarico di sottosegretario al Tesoro con la delega per i danni di guerra.
Tale incarico egli mantenne anche nel governo successivo, del quale fu parte ma solo per qualche mese anche Lussu come ministro senza portafoglio per la Consulta, – il De Gasperi I che dalla fine del 1945 arrivò al giugno 1946, e cioè al referendum istituzionale e all’elezione della Assemblea Costituente. Nella quale Assemblea Costituente ebbe, Mastino insieme con Lussu, posto e spazio per diversi interventi.
Dovrei aggiungere altro: che nella mediazione dialogica, non soltanto con verso l’azionismo radicale di Lussu e dei lussiani spese energie Pietro Mastino, ma anche verso il socialismo radicale ancora di Lussu e dei lussiani egli spese le sue energie. Perché al VII congresso sardista della primavera 1945 (quello che, convocato ad Oristano, seguiva di appena otto-nove mesi l’assemblea di Macomer e il dibattito sul rapporto con il Partito d’Azione) Lussu sfidò tutti chiedendo una pronuncia chiara sulla sua posizione socialista, che fu bocciata inducendolo a lasciare polemicamente i lavori. Ebbene Mastino riassunse in sé la coralità del sentire, in esso assorbendo le distinzioni ideologiche ed affermando di non trovare elementi in assoluto divaricanti fra l’ordine del giorno maggioritario e quello socialista sconfitto dei lussiani della sezione di Cagliari.
Ma sempre nella logica del sardismo dialogico, e tornando al sardismo coinvolto con le fatiche della fabbrica della Repubblica e dell’Autonomia – va ricordato che Mastino, giusto nelle more della presa di possesso del suo sottosegretariato al Tesoro, fu assunto nell’affollato Comitato Esecutivo Nazionale del Partito d’Azione, insieme con amici e compagni con cui avrebbe condiviso tante esperienze, sia alla Costituente che nel governo.
Non ebbe, né la poteva avere, la tessera azionista – come invece Lussu – ma manifestò la sua lealtà verso una sistemazione delle cose, fra sardisti e azionisti, che non aveva forse bisogno di speciali formalizzazioni.
Alle elezioni del 1946
E fu qui la stagione delle elezioni per la Costituente, che furono rovinose per le fortune del Partito d’Azione che pure era stato quello che, dopo il Partito Comunista, più sangue aveva donato alla patria sui campi della resistenza. Un partito di generali senza truppa, si sarebbe detto, ben sapendo che pressoché tutti i suoi capi – da Lussu a La Malfa, da Leo Valiani a Francesco Fancello – s’erano impegnati in prima persona nei pericolosi contrasti di guerra.
In Sardegna ci si pose il problema: quel Lussu azionista che aveva sposato, certo non in chiesa, la sua Joyce, che non aveva battezzato il suo Giovanni, che s’era detto favorevole al divorzio, che s’era detto favorevole all’abrogazione del Concordato con la Chiesa, poteva essere una carta da giocare elettoralmente con un elettorato che invece era, nei paesi più che in città, ossequiente agli indirizzi della Chiesa ed esposto alla pressione della concorrenza democristiana (interessata a confondere, nel negativo, sardismo e azionismo anticlericale)?
Lettera di Marianna Bussalai a Pietro Mastino, da Orani nel giugno 1946, sull’indegno comportamento tenuto da certo clero barbaricino nella campagna elettorale (e referendaria) a pro dei democristiani e contro i sardisti accusati di compromissione con gli “anticlericali” azionisti
Si decise fosse utile distinguere le strade, e Lussu stesso rinunciò a una candidatura azionista per rifugiarsi, con Mastino (e Gonario Pinna e Titino Melis ecc.) nella scheda dei Quattro Mori.
Conclusione due eletti in Sardegna, i sardisti Lussu e Mastino; sette eletti azionisti in continente.
E a Montecitorio, ai fini anche di costituire un gruppo per cui si richiedeva la partecipazione minima di dieci deputati, ecco associarsi – nel gruppo detto “Autonomista” – i sette azionisti, i due sardisti e un valdostano.
Con essi Pietro Mastino svolgerà il suo mandato.
Nella Consulta regionale
Andrebbe forse ricordato che mentre si sviluppavano tali vicende macropolitiche nella capitale, a Cagliari s’era insediata e svolgeva i suoi lavori la Consulta regionale che aveva il compito di assistere democraticamente l’Alto Commissario gen. Pietro Pinna Parpaglia e stendere una proposta di statuto d’autonomia per la Sardegna.
Costituì motivo di discussione e polemica, interna allo stesso Partito Sardo tanto più dopo l’uscita di Lussu nel 1948, la questione se davvero, nel 1944, a Pietro Mastino fosse stato offerto l’ufficio di Alto Commissario e se davvero lui avesse rinunciato a favore poi del gen. Pinna Parpaglia proposto da Carlo Sforza e nominato dal II governo Badoglio. Gli è che sarebbe stato chiesto a Mastino – già presente nel CLN/Comitato di concentrazione antifascista regionale – di rinunciare alla sua tessera sardista in cambio di quell’incarico e che né lui né i suoi sodali avrebbero accettato. Chissà.
In quanto riconosciuto decano, per autorevolezza, del ceto politico isolano, a lui toccò di aprire, il 29 aprile 1945, la prima seduta della Consulta regionale (nel palazzo Viceregio di Cagliari) cui assicurò la propria presenza fino a settembre, quando (sostituito da Anselmo Contu) fu assunto nel governo Parri.
Ai lavori della Consulta regionale, peraltro, ebbe modo di intervenire successivamente, e in più tornate tra fine 1946 e primi del 1947, in quanto invitato dall’Alto Commissario, con gli altri deputati costituenti (fra cui Lussu), al fine di stabilire alcune linee di fondo nella elaborazione della carta statutaria della Sardegna. Alcuni suoi interventi riguardarono il mantenimento o meno di un organismo intermedio fra Regione e Comuni. E comunque la materia fu oggetto di confronto ripetutamente a cavallo fra Consulta regionale e Assemblea Costituente o, all’interno di questa, nella rappresentanza sarda: molto ballava sulle competenze esclusive e competenze concorrenti da meglio precisare nello Statuto che avrebbe avuto rigore costituzionale.
Un bellissimo studio di Mariarosa Cardia – La nascita della Regione Autonoma della Sardegna 1943-1948 – dettaglia perfettamente lo sviluppo del confronto interpartito e, in esso, le posizioni di Mastino. (V’è letteratura sufficiente per dedicare un focus a Mastino costituente e/o a Mastino babbo, con altri babbi, dello Statuto infine approvato dalla Costituente, anche con il suo voto, che fu – ancorché con convintissimo – anche quello di Lussu).
Alla Costituente
Il gruppo dei deputati costituenti cui aderì Mastino prese il nome, forse su proposta di Lussu, di Autonomista. Fu presieduto dal romano Alberto Cianca, che prima della dittatura e della sua militanza in Giustizia e Libertà, aveva militato fra gli amendoliani e per qualche mese nel 1946 aveva fatto parte del primo governo De Gasperi di composizione ciellenista (con la delega ai rapporti con la Consulta, e ciò proprio in sostituzione di Emilio Lussu, dimissionario dopo l’abbandono del partito da parte di La Malfa e Parri e Siglienti e tanti altri contrari alla versione socialista dell’azionismo); gli altri azionisti del gruppo Autonomista furono il fiorentino Piero Calamandrei, il perugino Tristano Codignola, il torinese Vittorio Foa, il siculo di Regalbuto milanesizzato Riccardo Lombardi, il romano Fernando Schiavetti e il fiumano Leo Valiani; il valdostano (candidato nel Fronte Democratico Progressista Repubblicano) era Giulio Bordon.
Lussu, insieme con Bordon e Calamandrei, venne chiamato a partecipare alla commissione per la costituente, quella nota come “dei settantacinque” a presidenza Ruini. Pietro Mastino – uscente dall’ufficio di sottosegretario di Stato al Tesoro – libero di intervenire nelle discussioni generali, fu invece chiamato a rappresentare il suo gruppo in due commissioni: quella per l’esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio (presieduta dal socialista Di Giovanni) e – per due mesi, dicembre ’47-gennaio ’48 – quella speciale per l’esame del disegno di legge recante “norme per l’elezione del Senato della Repubblica” (presieduta dal democristiano Micheli).
Di Mastino costituente non tratto perché oggetto di altra relazione e comunque rimando sempre alla bella sintesi offertaci da Aldo Borghesi.
Alle elezioni parlamentari del 1948
Siamo al 1948 e alle elezioni parlamentari del 18 aprile. Mastino e Lussu, in quanto deputati dichiarati decaduti dalla legge fascista del 1926, hanno il privilegio compensativo di essere senatori di diritto, mentre in campo sardista il senatore eletto è il “siamese” Luigi Oggiano. A Palazzo Madama sono 148 i democristiani, 66 i comunisti, 41 i socialisti (fra i quali, a fine 1948, si aggiunge Lussu che nello stesso Partito Socialista, l’anno successivo trascinerà il suo Partito Sardo d’Azione socialista, sorto dalla scissione del luglio precedente consumatasi al congresso regionale sardista), e ancora 23 unitari socialisti (i futuri socialdemocratici di Saragat), 11 repubblicani e 10 liberali, nonché 33 iscritti al gruppo misto (in parte costituito anche dai senatori a vita – perché ex presidenti della Repubblica, come fu Enrico De Nicola o perché di nomina presidenziale quali saranno, fra gli altri, Gaetano De Sanctis, Luigi Sturzo, Umberto Zanotti Bianco ecc., oltreché ex presidenti del Consiglio come Nitti, Bonomi e Orlando e il presidente della commissione dei 75 Meuccio Ruini). Un gruppo di monadi per statuto, si direbbe.
Nel gruppo Democratico di sinistra
Sembra, questa rappresentazione numerica, un quadro che non rivela subito un contenuto sottostante: perché al gruppo Democratico di sinistra e non al gruppo Misto, seppure anch’esso – il gruppo Democratico di sinistra – possa avere i tratti del Misto? E io lo trovo, questo perché – affidandone gli approfondimenti di documentazione agli studiosi di maggior vaglia – proprio nella tensione relazionale di Pietro Mastino sardista nuorese, nella sua permanente ricerca di altri consentanei politici del continente, portatori di un interesse speculare con i quali intessere una qualità associativa e sviluppare il nesso che non potrà mancare fra il bene della sua regione e quello della sua nazione.
Il gruppo Democratico di sinistra, che pure non manca di fragilità anche nei suoi assi portanti – fra politica e ideologia – corrisponde meglio ad una intenzione che sembra prevalere nella vacanza di appartenenza politico-partitica dei più:
il calabrese presidente Enrico Molè – poi eletto vicepresidente del Senato – fu riformista e amendoliano prima del fascismo, aventiniano dichiarato decaduto dal fascismo, costituente con i demolaburisti, ministro dell’Alimentazione nel governo Parri e dell’Istruzione nel I De Gasperi (quando Mastino fu sottosegretario al Tesoro);
il laziale vicepresidente Dante Veroni, radicale nel prefascismo e anche lui demolaburista nel postfascismo e collega sottosegretario di Mastino nei governi Parri e De Gasperi;
l’abruzzese Giacomo Attilio Cermenati,
il lucano Floriano Del Secolo, storico della letteratura e giornalista d’imprinting carducciano e d’impegno liberaldemocratico durante la seconda guerra mondiale accettò la candidatura frontista nel 1948 scegliendo però il gruppo Democratico e non quello né Comunista né Socialista;
il ligure Ezio Pontremoli, abile amministratore locale e uomo di banca, veniva da famiglia mazziniana che cercò di onorare anche negli anni del regime;
il lucano Luigi Rocco, magistrato, giunse al gruppo passando per un’esperienza socialdemocratica;
il senese Armando Sapori, economista e storico dell’economia bocconiano, affrontò le elezioni del 1948,
come Floriano Del Secolo, in una lista del Fronte Popolare , optando infine per il gruppo Democratico che meglio gli garantiva libertà di gestione del suo mandato;
l’avvocato lombardo Italo Sinforiani viene dall’esperienza di commissario CLN del comune di Pavia. Massimo Bontempelli, il famoso scrittore comacino che negli anni ’50 fu anche collaboratore fisso alla terza pagina de L’Unione Sarda, stette pochi mesi nel gruppo aderendo poi al PCI per vedersi poi annullata l’elezione e sostituito da Felice Platone, intellettuale comunista astigiano.
Con quest’ultima eccezione, potrebbe dirsi che pressoché tutti i membri del gruppo Democratico di sinistra venivano da esperienze politiche anche prefasciste nello schieramento progressista, con una militanza relativamente debole ma con idealità forti.
Meriterà ricordare che del gruppo Democratico di sinistra Mastino fu il segretario e che, pertanto, ebbe un ruolo di coordinamento interno forse ancor più rilevante una volta allorché Molè, presidente del gruppo, fu chiamato alla vice presidenza del Senato e che morì il sen. Veroni che del gruppo era il vice presidente.
Di Mastino senatore nell’arco complessivo del quinquennio 1948-1953 varrà ricordare la sua assegnazione alle seguenti commissioni:
. alla 1.a permanente (affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno);
. alla 2.a permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere);
. alla 7. permanente (Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telegrafi, Marina mercantile);
. alla speciale sui disegni di legge delle opere pubbliche;
. alla speciale di ratifica dei decreti legislativi;
. alla speciale per le locazioni;
. alla di vigilanza sulle condizioni dei detenuti negli stabilimenti carcerari;
. alla giunta delle elezioni (di cui fu segretario).
Nei cinque anni di partecipazione ai lavori del Senato numerosi sono stati gli interventi in aula – 33 – oltreché nelle singole commissioni ovviamente, di Pietro Mastino. Rimando anche qui all’utile riepilogo fornitoci da Aldo Borghesi che ha attinto al sito internet del Senato a disposizione di tutti.
Dato questo, evito duplicazioni e semmai invito tutti ad accessi diretti a quei notiziari in capo alle schede personali dei parlamentari.
I contrasti interni al PSd’A nel 1967-1968
Dovrei a questo punto dar spazio all’ultima stagione politica di Pietro Mastino, e all’ultima sua battaglia. Mi riferisco al severo contrasto suo e dei suoi amici più vicini, a partire da Luigi Oggiano, al verbo terzomondista inoculato nelle vene della militanza e anche di certa dirigenza sardista dal geniale architetto Simon Mossa. Il che, fenomeno iniziato verso il 1965 e con risultati importanti già allora al congresso provinciale di Sassari, che costò la segreteria politica a Nino Ruiu, al tempo consigliere regionale insieme con Peppino Puligheddu e altri, scombinò gli equilibri interni al partito ma soprattutto alterò la visione e la missione politica dei Quattro Mori alleati dei repubblicani e con Titino Melis attivamente presente nel gruppo repubblicano della Camera nella logica sempre della unità della patria.
Ho dettagliato quella storia numerose volte in scritti e convegni, non vale dunque adesso ripetermi, e peraltro anche i saggi di Salvatore Cubeddu (Sardisti in tre volumi fra il 1993 e il 2021 dalla Edes di Sassari) aiutano a conoscere e comprendere quel che avvenne anche per il determinante e qualificato peso che ebbero i nuoresi sodali di Pietro Mastino. Importa qui andare alla conclusione: Mastino non rinnovò la sua iscrizione, ritenendo che quel PSd’A fattosi tendenzialmente separatista, nazionalitario ed etnocentrista, invece che tessera viva della democrazia italiana, secondo la migliore ispirazione risorgimentale ed antifascista, non fosse più il partito della sua vita, del suo sentimento civile, del suo impegno pubblico. E diffuse allora una lettera con cui invitò la militanza a sostenere, nella campagna parlamentare del maggio 1968, non i sardisti presenti nella lista dei Quattro Mori a condizionamento castrista, ma quelli candidati nella lista dell’Edera, come nella lista dell’Edera era stato cinque anni prima Titino Melis, infine eletto alla Camera.
Furono tutti espulsi dal Partito Sardo quei dirigenti divenuti poi militanti e dirigenti del PRI di Ugo La Malfa – che era stato un resistente antifascista (in galera a 25 anni) ed uno dei padri della patria – e quindi di Giovanni Spadolini (uno degli intellettuali di maggior livello nell’accademia storica come anche nella direzione dei giornali più prestigiosi del paese, eletto parlamentare e, fra l’altro, ministro fondatore del dicastero dei Beni culturali, ed infine presidente del Consiglio dei ministri e presidente del Senato): tutti espulsi dai ranghi del PSd’A nella coerenza da essi rivendicata – e si torna qui al sardismo dialogico mastiniano – della appartenenza ad una corrente ideale che da Mazzini e Cattaneo arrivava a Giorgio Asproni: Bustiano Maccioni, Luigino Marcello, Athos Marletta, l’ogliastrino Vincenzo Racugno, ecc.
Posso ricordare quel documento, datato 28 aprile 1968, che fu poi il testamento politico di Pietro Mastino. Eccolo:
«Caro Amico, come saprai le elezioni politiche, relative tanto all’elezione dei deputati, quanto a quella dei senatori, avranno luogo il 19 Maggio prossimo.
«A questo proposito, devo spiegarti una situazione, che si è creata e che potrebbe portare ad errori, che è necessario evitare e, perciò, ti scrivo.
«Il nostro simbolo, quello che bisogna segnare, votando per i Sardisti è quello dell’Edera. Ciò perché, nel Congresso recente di Cagliari, è stato cambiato il vecchio programma; prima eravamo solo autonomisti, adesso, secondo il cosiddetto congresso, dovremmo diventare separatisti. Noi siamo quello che eravamo, sardisti autonomisti ma non separatisti, sia perché italiani, sia perché la Sardegna, separata dal continente italiano, non potrebbe vivere.
«I nuovi sardisti, che hanno modificato il vecchio statuto e che hanno, così, creato un nuovo partito, hanno mantenuto il vecchio simbolo dei quattro mori, per quanto abbiano cambiato le idee.
«I nostri amici, così come cinque anni fa, sono candidati nelle liste dell’Edera, alleati con il Partito Repubblicano Italiano che da decenni conduce al nostro fianco la battaglia per l’affermazione delle idee Autonomiste.
«È perciò che mi permetto di invitarti a votare e far votare sardista segnando il simbolo dell’Edera, e per la Camera dei Deputati e per il Senato. Ti unisco i fac-simili della scheda con il nostro simbolo già segnato.
«Saluti sardisti, Pietro Mastino».
09 Ott 2025
Prestito veloce in 48 ore Buongiorno Prestito è disponibile per chiunque sia in grado di rimborsarlo. Ti offro da 10.000.000€ ha 5.000€ con un tasso di interesse del 3%. Puoi rimborsare il prestito in modo sicuro entro 1-25 anni. Chiunque ne abbia bisogno, mi contatti via email. boschettiemilia74@gmail.com
Devi accedere per poter commentare.