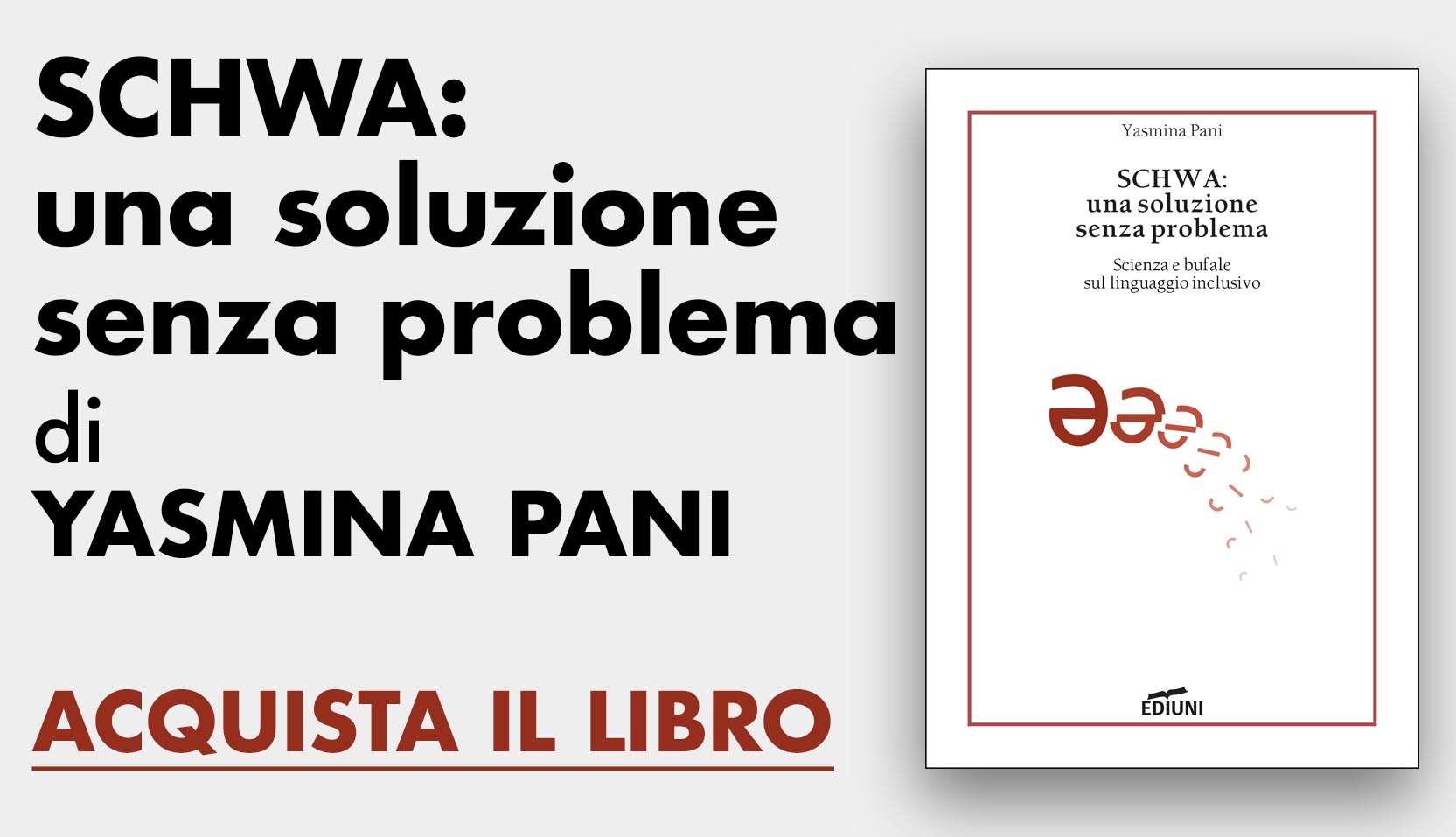Prete operaio, il diario ritrovato di don Angelo Pittau
di Gianfranco Murtas

Sono passati ormai svariati mesi dacché don Angelo Pittau, nella montagna di carte che ha depositato nel tempo a documento della sua esperienza di vita sia ecclesiale che sociale (e qui mettici anche il giornalismo e la poesia), ha ritrovato il diario che scrisse negli anni in cui, allora trentenne, fu prete operaio, od operaio prete, a Lione, nel sud della Francia. Alla fine dei mille giorni trascorsi nel Vietnam in guerra e prima dei duemila passati a Torino, prete di periferia e ancora operaio stavolta nell’industria.
Quando fra il 2018 e il 2019, insieme con Andrea Giulio Pirastu – promotore della EDIUNI (l’editrice) e del sito internet Giornalia – lavorai a Viaggiando Chiesa, il libro-intervista nel quale l’anziano presbitero della diocesi di Ales-Terralba (e cento cose diverse tutte collegate nel servizio alla sua comunità) mise a nudo la sua complessa e carismatica personalità, ci mettemmo a scavare tutti quanti insieme fra fotografie d’epoca ed appunti, libri, riviste, materiali scritti in tempi diversi. Fu fortunato don Angelo a ritrovare quella cinquantina di pagine che documentavano il suo travaglio umano e spirituale a conclusione della esperienza vietnamita.
Mise allora – mezzo secolo fa! - in discussione non soltanto il suo sacerdozio cattolico, ma se stesso. Fu sofferenza vera e dura, superata progressivamente, con contraddizioni certamente, ma anche con avanzamenti e inoltri decisivi. I pilastri portanti del suo ministero, e pilastri della sua umanità, li piantò allora benché nulla si presentasse senza segnali anticipatori, senza avvisaglie. Già si pensi alle giovanili esperienze ecumeniche e internazionali: in una fattoria provenzale ed al porto di Marsiglia, con trenta coetanei ventenni provenienti da 26 paesi diversi, nel circuito dei Piccoli Fratelli del Vangelo. Si pensi alle estati “di vacanza” (da Cuglieri) trascorse “a lavorare” a Bindua, ancora con i Piccoli Fratelli. Si pensi al messaggio che affidava alla casula, da lui preferita alla pianeta per la celebrazione della sua prima messa, in intima adesione al soffio conciliare che riformava tutto, ingoiando secoli di ingessature dottrinarie e formali, per tornare alle fonti. Si pensi alle sperimentazioni pedagogiche portate ai giovani di Tuili, prezioso francobollo storico e sociale della Giara di Gesturi. Si pensi alle letture critiche del vissuto secolare del suo paese così come anche elaborate nella letteratura di Giuseppe Dessì. Si pensi all’opzione evangelicamente avventurosa nel Vietnam, in rimpiazzo di un gesuita allontanato dal governo per troppa libertà di giudizio, ma infine… per raccogliere e sviluppare quella libertà di giudizio e pagarne di conseguenza altrettanta punizione.
Fu, quella revisione impegnativa e dolorosa, faticosissima, della sua vocazione umana e religiosa premessa ad altre avventure, sul continente e in Sardegna, dopo il 1974: tanto più nel sistema Caritas, nella rete dei centri d’ascolto e delle comunità promosse con ardimento evangelico e abilità pragmatica. Per le collaborazioni instaurate, richiamerei in particolare le imprese di Is Benas e di San Michele che potei raccontare, ora sono più di vent’anni, nel quaderno speciale di Partenia in Norbio.

Prefato da Arrigo Miglio, arcivescovo (oggi emerito) di Cagliari (e già di Iglesias ed Ivrea), don Angelo ha ripubblicato quella cinquantina di cartelle dattiloscritte e sottoposte a correzioni e ritocchi a penna. Le ha intitolate Un diario ritrovato: prete operaio in Francia (104 pagine per i tipi della Pubblicart villacidrese ed a cura del Centro Culturale di Alta Formazione), donando il libretto ai partecipanti alla manifestazione di chiusura, nello scorso gennaio, della mostra Dessì-Pittau allestita nel salone d’ingresso di palazzo Brondo (divenuto nel tempo palazzo vescovile e seminario diocesano), a Seddanus in Villacidro.
Un diario dell’anima, questo della fine del 1969, che potrebbe essere adottato come testo di studio al seminario regionale della Sardegna: lo propongo formalmente al rettore.
Così la sequenza dei paragrafi tematici: Desiderio di pace, In Francia per ricominciare, Concepiti alla vigilia della guerra, Manovale immigrato, Manuel e Abilio, Dio mi mette in ginocchio, Volti, Il mistero della mia vita, Celibato, Mistero dell'incontro.
Ecco qui il testo completo, a parte l’ultimo capitolo – arricchito di versi poetici d’impressionante efficacia – che invece pubblicherò domani. Il neretto è una mia personale sottolineatura di passaggi ritenuti particolarmente significativi.
Come Giobbe: O Dio, perché?
Circa un anno fa, per gli amici, mi misi a scrivere quasi al termine della mia vita in Vietnam. Le mie parole suonarono dure, scrivevo da un mondo rifiutato, con verità così amare che alla fine un po' tutti rifiutarono me e ciò che scrivevo. Solo la realtà amara del Vietnam mi dava ragione e le lettere, le numerose lettere che ricevevo dal Vietnam, mi dicevano che tutto continuava e continua come prima e che della verità avevo solo iniziato a sollevare il velo.
Sollevarne il velo bastò per farmi buttare fuori, fare di me una vittima. E fu il pericolo di fare la vittima, di essere strumentalizzato e usato che mi portò nuovamente al silenzio; e fu la nausea, la noia, l'amarezza di ritrovare l'Italia e l'Europa uguale e peggiore, fu l'intuizione profonda che l'inserirmi subito, (diritto canonico alla mano) in diocesi, nel sistema, era impossibile senza una involuzione del mio ricercare come uomo e come sacerdote. Tutto questo rese la necessità di ritirarmi, di sparire almeno per un certo tempo: ritirarmi e sparire dinanzi agli altri e a me stesso. Fu la necessità, (ero ferito non fisicamente ma nelle mie possibilità di sopportare, di credere, di sperare come del resto ogni vietnamita), di mettermi dinnanzi a Dio e di gridargli il perché. Magari come Giobbe, di rimproverarlo. Era anche la tentazione (o il sogno, non lo so) di un deserto fisico e mentale dove l'alternarsi delle onde del mare si trasformava in risacca, in desiderio di pace, di sogno, di rifugio.
Non era l'atteggiamento della formula di prete-operaio a chiamarmi. Io non credo alle formule, era essere come "loro", un desiderio di perdermi.
Dopo l'esperienza vietnamita, mi ritirai a fare l'operaio, il manovale muratore in un ambiente forse così violento ed ingiusto come la guerra del Vietnam stessa: la mia possibilità di scoprire e di partecipare alla sofferenza e alla miseria dell'uomo acquistava dimensione mistica, di preghiera, di contemplazione.
Fare il manovale muratore in mezzo agli emigrati italiani, spagnoli, portoghesi, algerini, marocchini, tunisini, negri, jugoslavi in un periodo di crisi economica, nella periferia di una grande città come Lione. E non tanto fare il manovale ma essere manovale: c’è differenza. Essere manovale, un manovale sacerdote, certo, perché il sacerdozio resta. Sembra una distinzione stupida ed invece è necessaria ed è la vera. È necessario che il prete di oggi, soprattutto se è stato formato in seminario, riacquisti la sua dignità di uomo. Essere preti con la formazione che ci hanno dato vuoi dire essere uomini speciali; diversi dagli altri, in una dimensione ed in un piano falso, sbagliato. Bisogna sapere rientrare nel piano umano. Solo nel piano umano (il reale) posso vivere la dimensione soprannaturale del dono del sacerdozio, solo così io sarò convergenza dell'uomo e del divino, sarò lievito al mondo. Questo prima di ogni altra giustificazione ecclesiale, d'evangelizzazione, o mistica della mia scelta. Non era una fuga, era esserci, da sain.
Adesso scrivo nei silenzio di un albergo della Genova bene, conservatrice, forse un po' reazionaria ma allo stesso tempo vivificata da gruppi pieni di realismo nel presente e nel futuro, duri continuatori di intuizioni che credono e credevano ieri giuste ed anche, perché no?, realizzatori di esse. Parlo degli amici del Gallo che sembra siano diventati i miei samaritani nei miei vari incontri non fortunati nella strada che da Gerusalemme porta a Gerico: era necessario che io discendessi questa strada. Miei samaritani che mi ungono con l'olio dell'amicizia, mi purificano con l'aceto della verità.
Non è difficile raccontare, cerco di prendere gli appunti dalla mia agenda anche se non sono molto ordinati. Vorrei che mi leggessero soprattutto i giovani, i preti della mia età perché è con loro che vorrei avere dialogo e da loro trovare una risposta ai miei perché.
Ricomincio il diario come l'ho ricominciato tante volte dopo una svolta, qualcosa d'importante, dopo un rovesciamento nella mia vita.
Sono in Francia, ho quasi trent'anni e mi trovo a ricominciare. Questo inizio è stato sognato, meditato e sofferto, visto quasi come ulteriore tappa del mio incontrare il Cristo: un ritornare all'infanzia per divenire veramente uomo. Sono cresciuto per essere "prete" non per essere uomo, anche se io cercavo di ribellarmi (ma avevo la coscienza tranquilla) a questo processo.
Curioso processo di idee e di fatti che mi ha portato qui dopo un errare per terre e per vocazioni. Qui luogo senza terra, senza fatti e senza vocazione, luogo di vita e di esseri che soffrono e lavorano mai coscienti.
Il salmo di compieta del mercoledì dice «dai confini della terra ti chiamo Signore… nell'annientamento del mio cuore». Il mio cuore è stato schiacciato dalla vita, ma è a questo confine che il Signore mi ha portato.
Sono al confine dell'Isère, vicino a Lione in un piccolo villaggio di pendolari, di turisti ed operai, di antichi proprietari agricoli che cercano di difendere una dignità impossibile a tenere perché non hanno più soldi: adesso sono i soldi che danno dignità. Le mie giornate passano e non le ricordo perché fatte dallo stesso ritmo e dagli stessi fatti.
Un levarsi svelto, un'adorazione e un salmodiare avvolti in una luce o un chiaroscuro che io stesso non riesco a definire, fatti per sedimentare la mia atmosfera interiore, pulviscolo di pensieri, desideri, sogni che cadono, pulviscoli di idee evanescenti, di fremiti mai completamente repressi.
Un lavoro anch'esso indefinibile perché completamente nuovo per me dove piuttosto è un fremito d'aria, d'idee, di sogni che si leva, di preghiera. E le ore passano e di tutto questo pulviscolo niente resta, troppo vano e forse sedimentato troppo presto, non so dove, perché io non sento niente di nuovo dentro di me, mentre invece sento molto il passato. La superficie che ho creato in me dopo la distruzione vera o fittizia del castello vero o fittizio dell'io, è ancora passato. Forse è la superficie stessa che bisogna annientare, sfondare: rendermi vuoto, spazio totale, assoluto del niente e dell'infinito in una disponibilità assoluta ai progetti dell'architetto.
Piccole cose. Un partire svelto in bicicletta nel giorno che si fa nella nebbia della notte, nella rugiada ghiacciata. Una strada ormai percorsa a tappe mentali. I campi sembrano sempre uguali ma anch'essi lentamente si adattano all'autunno, all'inverno; io so leggere i campi. I grandi pioppi, fremito di giallo e di verde, fremito di colori che vibrano al vento, al freddo e pian piano si spogliano. E la gente che incontro anch'essa sempre la stessa. Una nord africana dalla grande sciarpa rossa, i grandi orecchini; le ragazze assonnate della cartiera, i due bambini del casello ferroviario che vanno a scuola, la commessa dal giacchettone di pelle, la ragazza della discesa di Valencin quando sono in orario, Chamallal in piazza del municipio…
Gente che non conosco e che vorrei conoscere, persone con le quali forse non scambierò una parola, ma che ho guardato e mi hanno guardato, che vorrei magari invitare ad una grande festa per rivelarci, guardarci negli occhi, sentirci amici e felici.
I compagni di lavoro che pian piano si aprono e mi introducono nel loro io, nei loro pensieri e preoccupazioni.
Nel lavoro poi è l'ubbidire ad ordini semplici che mi mettono a servizio totale di altri uomini.
Preparare l'impasto diventa un calcolo che alla fine anch'esso è alienante: 18 pale di sabbia, un sacco di cemento, tre secchi d'acqua, e mescolare un paio di volte. Sempre la stessa tecnica, sempre così. Oppure seguire l'impastatrice nella sua fame di cemento, di sabbia, e d'acqua. E il processo continuo, il montacarichi che sale, lo stesso mio affannare sudato: tutto mi fa partecipare ad una situazione tragica della vita dell'uomo di oggi. Forse è qui la vera scoperta che sto facendo: come alla Messa partecipo con spasimo alla dimensione divina del Cristo, qui partecipo alla sua dimensione umana e la mia "religio" così diventa totale. Tutto questo scoperto è conosciuto, accettato, voluto ed adorato.
Forse è qui l'adorazione e la vocazione del contemplativo nel mondo di oggi.
È più di un anno che sogno di scrivere una novella tra l'autobiografia e la meditazione: Dalat - Saigon. A Dalat era la struttura, il vivere con qualcosa dei secoli mai accettato, vecchio, superficiale: prete professore in facoltà di teologia, un camminare a numeri di diritto canonico, di Denziger, di date di storia, di Enchyridin. A Saigon, dopo un salto in aereo, nell'anonimato delle masse asiatiche senza altro volto e abito che quello di mille altri uomini, sentirmi a gomito a gomito con gli altri, sentirmi uomo anch'io prigioniero di una guerra, nella paura del domani e nella bramosia di vivere e in questo essere, vedere negli altri veramente il Figlio di Dio incarnato, i "beati".
I tramonti che seguivo a Saigon quando in barca nel fiume mi calava la sera improvvisamente e il quartiere europeo era nel trionfo delle luci elettriche e dietro era il rosso del tramonto e nel quartiere popolare, isolato dal fiume, era un buio assoluto privo di luci e di orizzonte, già preda della paura e della morte. Ed io ero nel fiume, nel mezzo e il ragazzo della barca prendeva paura e mi riportava al quartiere europeo senza che gli dicessi niente, non potevo che essere lì! Era il mio modo di vivere il sacerdozio e essere uno dei "beati" un povero, un operaio.
Anche adesso è un tramonto, alle mie spalle è il rosso che scompare, dinanzi a me e il villaggio già al buio: al buio sono partito e al buio ritorno, non c'è più un ragazzo che mi porta al quartiere dei ricchi, pedalo faticosamente verso il buio. Crepuscolo della sera, crepuscolo al mattino, un giorno che si faceva, uno che se ne va.
Mi chiedo cos'ho, o meglio cosa abbiamo noi generazione di uomini concepiti alla vigilia della seconda guerra mondiale o nati durante essa. Siamo quasi figli dell'incertezza, dell'irrequietudine, del vuoto e dell'angoscia. Non ci manca niente, abbiamo forse anche troppo eppure non si è mai contenti, si è sempre più in ricerca: si trova spesso e spesso si ricambia. Sono fatto per errare, in ogni posto mi trovo bene. Ma prima stesso di occuparlo, di possederlo, di vederlo e gustarlo, l'ho già abbandonato mentalmente perché magari ci ho vissuto ancora mentalmente e quando incomincio a viverlo veramente niente mi sembra nuovo al di là delle disillusioni. Mi sembra, e con una certezza paura, che ho sognato perfettamente tutto e l'incominciare così diventa un illuminare aspetti del passato. E se questo è per i posti fisici, per le azioni ancora più pauroso è Il problema delle scelte decisive, della nostra azione ideologica per costruire il mondo, per giudicarlo e per determinarlo.
Ci hanno educato per il passato: i lunghi anni di scuola e di seminario, testi pesanti di filosofia e di politica, di educazione e di comportamento, lezioni a tutti i livelli per essere bene, borghesi, a modo, gente che riesce e si afferma, gente per mantenere il nome della famiglia, accrescerlo, per avere successo. Ed ecco che ci accorgiamo che tutto questo ci è chiesto per l'egoismo di una generazione che deve scomparire, segretamente ci accorgiamo che tutto è da distruggere, da rifare secondo la nostra coscienza.
Questi pensieri, queste azioni ci sembrano "peccato", disordine perché così ci hanno inconsciamente ma in modo irreversibile condizionato. In fondo anche noi siamo portati subdolamente a pensare che un mondo simile può fare comodo anche alla nostra età: affiora in noi l'egoismo dei nostri padri. E il conflitto è duro ed amaro. Questo, penso, un po' è il mio errare ... sfuggire un condizionamento d'un passato per incarnare una coerenza.
Cosa ho io prete ordinato nel 1965 con una formazione preconciliare in piena ventata di Concilio e di chiacchiere vere o false sul Concilio? I superiori dovevano obbedire alla Congregazione (il Papa, dicevano) governata allora da uomini rimbambiti come Pizzardo o arrivisti come Staffa; obbedivano da buoni gesuiti e le lettere della Congregazione per questo fioccavano: ordini assurdi su tutto, sul calcio, sull'andare in corriera, sullo studio del latino, sulla berretta alla Messa cantata, sulla sacralità della sottana, sul cappello e pastrano da portare in estate all'ora di passeggio, sulle file e sul silenzio in fila, sulle letture stesse, sul proibire di fumare, sul pigiama. E fossero state solo queste cose: Theillard de Chardin escluso dalla biblioteca e ridicolizzato da un professore aborto, tesi sull'evoluzionismo bandite e condannate, Sacra Scrittura ignorata totalmente in lunghissime ore di scuola inutili, un metterci in guardia sulle cose che dicevano certi vescovi al Concilio e una censura al Concilio stesso. I superiori divisi: chi ci credeva e chi non ci credeva affatto a questa linea di Roma; vescovi che dicevano che bisognava attendere anche il permesso di soffiarsi il naso, ... e noi in una voglia di sbarcare il lunario presi dalla faciloneria di tesi studiate a memoria e presi anche dall'angoscia di problemi che ci mettevamo, in una corsa alle informazioni, al nuovo senza sapere scegliere, in una paura anche di essere scoperti e stroncati per queste spinte nuove.
Si leggeva, si stringevano amicizie, si desiderava e ci si proiettava verso un futuro intuito valido ma che per noi non aveva voci di giustificazione, solidarietà di difesa, ricchi solo dalla convinzione che il presente era sbagliato: e lo era.
E le contraddizioni non erano solo in me ma nel mondo. Che schifo di esempi ci veniva dall'alto. Lotte tra i vescovi in curia, nelle diocesi e le lotte non erano tutte dettate dallo zelo della casa del Signore.
Formati in un clima simile oggi ne portiamo le conseguenze. Il mio vescovo mi diceva che le penne vecchie scrivono e le nuove non scrivono. Ma me chi mi ha caricato? Almeno i vecchi furono educati nella coerenza e da gente che ci credeva, educati per quello che dicevano di fare e di dire e lo facevano. Ci hanno educati per cose che sono state annullate dai tempi. Le cose che adesso ci chiedono di fare (per un falso adattamento in quanto loro non ci credono e le fanno per opportunismo) ci erano proibite quando noi ci volevano preparare ad esse intuendo che erano valide.
In fondo anche se involontariamente noi siamo condizionati dall'educazione passata, mai ci sarà possibile un inserimento nel presente e nel futuro. È per questo che il mondo ha facile gioco di noi brandelli e sia nelle nostre relazioni con l'autorità, per i soldi, per le donne e sia soprattutto per la fede.
Ormai non c’è niente da fare, noi siamo falsi anche quando "facciamo" cose moderne nel nostro ministero perché agiamo ormai nella professione, un adattamento esteriore, i sepolcri imbiancati aumentano sempre più e in un mondo puzzolente noi puzziamo anche di più.
Questo sappiamo noi, il cerchio non riusciamo a romperlo. Ai preti che contestano questo vorrei dire. Bisogna essere sinceri, mostrare e riconoscere il punto debole che abbiamo come uomini e come preti: siamo figli di una guerra e per questo traumatizzati e siamo diventati preti e viviamo in tempi sbagliati: e tutto non è colpa di quelli che ci giudicano e magari ci scomunicano. Ma al posto di prendercela con questi cerchiamo di riconoscere queste ferite in noi e cerchiamo di correre il rischio continuamente di scomuniche e di giudizi proprio per ricostruire da zero: noi e gli altri.
Ormai è una quindicina di giorni che ho ripreso il lavoro come manovale praticamente è la mia prima esperienza di lavoro manuale, il mio primo lavoro manuale da prete. Lavoro in una piccola impresa edile: siamo un trentacinque operai di una decina di nazioni, l'uno più povero dell'altro ed io forse, economicamente, sono con il più basso trattamento.
Il lavoro è duro ed io sono sempre più stanco. Sono arrivato non so come a questo fine settimana e spero di recuperare in questa domenica che mi attende. Sono stato due giorni alla impastatrice che dovevo continuamente caricare. Era una corsa incredibile, un lavoro d'automa in questo sollevare la pala continuamente, stringendo nello sforzo i denti, chiudendo gli occhi madido di sudore, assordato dal rumore. Il rumore soprattutto mi ha riportato al passato, sentivo quasi il rumore della mitragliatrice in Vietnam, quasi ho avuto paura di essere sotto un incubo.
Il padrone mi ha fatto cambiare di gruppo. Prima ero con un francese e due marocchini. Il francese è semplice e buono, non grande lavoratore comunque, i marocchini non si uccidono lavorando ed io stupidamente tiravo un po'. Chissà che non sia per questo che mi ha cambiato? È vero che i due marocchini non vanno d'accordo fra di loro anche se sono fratelli e in più i due imbestialiscono il francese: il tutto non aiuta il rendimento del gruppo. Con loro lavoravo in una vecchia casa al centro del villaggio e così ho incominciato a conoscere un po' la vita locale: il municipio, le botteghe, i bar, il mercato. Il francese un po' pettegolava con i passanti, così riuscivo a cogliere tanti piccoli fatti di vita. Non so ancora tante cose, anche un linguaggio adatto, le parole più semplici, non so i nomi degli arnesi e sono dei comici qui pro quo che sorgono spesso, faccio la figura dello stupido ma la mia volontà d'imparare divertiva il francese rendendolo in fondo importante.
Adesso lavoro con due portoghesi, fanno le facciate e rifiniscono le case. Sono cognati tra di loro e si vogliono bene. Gli approcci sono stati timidi, loro lavorano svelto ed io non ce la faccio a seguire il ritmo ... loro ridono e si chiedono che lavoro facevo prima e chi diavolo mi ha fatto piovere tra di loro, mi dicono che sono stanco dalla nascita. Ma mi accorgo che mi rispettano, mi vogliono bene, spesso mi aiutano nel mio lavoro, mi danno una mano senza troppo farlo vedere. Sono buoni in un mare di parolacce e sono io che allora rido. L'amicizia si fa pian piano, cominciamo a raccontarci qualcosa del nostro passato, sorridiamo improvvisamente delle nostre cose, non abbiamo più paura delle nostre debolezze. Lavoriamo in silenzio per ore, poi magari si incomincia a canterellare. Ancora non fa molto freddo, qualche volta piove, se c'è il sole sudo nello sforzo del lavoro.
Lavoriamo in una casa nuova, è già abitata, i padroni gestiscono un ristorante per operai: con una macchina trasportano il cibo per le mense degli operai di alcune fabbriche dei dintorni. Vendono anche il cibo per chi lo vuole comprare direttamente da loro: sono cinque franchi. Ogni giorno ho la tentazione di comprarmi la razione, ho i soldi in tasca ma ogni giorno ho una certa paura, una certa vergogna quasi. Mi porto il mangiare in una gavetta; è poco e fatto male, il pane è sempre duro ma così spendo meno. Il cibo mi resta nello stomaco, mi dà sonnolenza, non mi lascia lavorare bene ma se non mangio è peggio, verso le 15 o le 16 mi sembra di non poter finire la giornata. Poi è così duro ritornare in bicicletta dopo otto ore di lavoro, bisogna essere in tempo per dire la Messa, recitare il breviario, pulirmi. Un po' mi manca il soffio, lo sprint, sono anni che non faccio bici, in pratica non ne ho mai fatto, e le emicranie sono sempre più forti. Tuttavia dormo profondamente e la mattina mi sento fresco per ricominciare, forse tutto è questione di abitudine, bisogna farsi i muscoli e le ossa anche se le mani adesso le ho come quelle di un povero Cristo piene di calli, aperte dal cemento.
Gli operai si accorgono di queste mie difficoltà, un po' ne ridono e soprattutto cercano di aiutarmi, cercano anche di capire perché sono con loro.
Sanno che sono prete, il padrone un po' lo dice a tutti quasi fosse contento di avere un prete, «une grosse tête» nella sua impresa. Gli operai ancora non capiscono: se stavo bene perché cercare di stare male! Voler star male è c...., è la prima parolaccia che ho imparato in portoghese. Mi sono tenuto a lungo da dirla ma oggi camminando con il secchio nell'impalcatura ho dato un colpo di testa ad un tubo... A sentirmi quasi non ci credevano poi è stato uno scoppio di allegria mentre mi grattavo la testa. Mi accorgo che sto iniziando un certo "ingaglioffamento" e quasi ci provo gusto. Non sto più a ripulirmi continuamente dal cemento in faccia o negli abiti, resto sudato, con i cappelli spettinati, bevo alla bottiglia, mi ficco le mani in tasca e parlo anche di niente.
Sono ancora lucido per guardare me e gli altri con un occhio mezzo sornione, quasi da giudice. Di questo atteggiamento si è accorto il padrone non so se per paura o per stima o perché sembra lo faccia anche per gli altri operai, mi ha invitato a mangiare a casa sua e di passare l'ora d'interruzione di lavoro con lui e la sua famiglia. Ho accettato, mangiamo assieme, lui, sua moglie, il figlio e la figlia. Il figlio lavora con lui nella direzione dell'impresa, la figlia è radiologa in un ospedale, la moglie ha l'amministrazione dell'impresa. Pochi operai vengono a mangiare con il padrone, i più preferiscono ritornare a casa loro con le loro macchine o moto così certo corro il pericolo di "farmela" con il padrone a lungo andare, ma ho ancora il tabù di andare a mangiare in un bistrò, fuori poi fa troppo freddo.
L’ora passata con il padrone è un mondo di conoscenze francesi che mi si apre, discussioni di politica attuale, d'economia, di sindacato, di storia.
Comincio a pensare che il fenomeno De Gaulle in tutti i suoi aspetti, anche quelli più stupidi e più reazionari, è stato possibile proprio perché i francesi lo volevano, ci hanno creduto, perché parlava per loro, per il loro egoismo, per le loro aspirazioni borghesi. Tra gli operai francesi non c’è più estremismo, non c’è nemmeno solidarietà di classe; si stanno chiudendo quasi in difesa di privilegi dinanzi alla concorrenza, al dover dividere la torta con gli emigrati di tante nazioni, anche loro insomma come i padroni, come la società francese cercano di sfruttare, di fare eseguire i lavori più umilianti e più duri agli emigrati, sono contenti di essere pagati di più.
In questo senso la Francia mi ha lasciato deluso. Un po' per educazione, per letture, un po' perché ormai tutti lo dicono, ho creduto anch'io alla Francia come il paese dell'avanguardia per le idee in campo filosofico, culturale e religioso, nell'arte e nella giustizia sociale.
Mi sembra invece che tutto sia una montatura. Non ho trovato dialogo ma testardaggine, sono retrogradi e ricchi di una certa involuzione riguardo ad idee acquisite in altre nazioni. I partiti politici sono chiusi in posizioni superate, l'economia è in lotta serrata per restare quella di prima, le famiglie dominate da spinte medio borghesi, nelle campagne poi il più nero conservatorismo (qui le radici della lotta al Mec e non solo in De Gaulle). Nella stessa Chiesa ho trovato questo conservatorismo, anzi soprattutto nella Chiesa e a tutti i livelli.
Vivono di grandi nomi ma questi nomi o sono spariti dalla circolazione o si sono messi nel sistema perché hanno ottenuto che si parlasse di loro, che li si ascoltasse e magari sono loro stessi spesso a parlare ascoltandosi sino a cadere nel ridicolo. Del resto Parigi ha saputo accontentarli dando loro qualche carica!
Gli studenti, – non tutti, quei pochi non assorbiti –, cercano di rompere questa cappa che si sta calando nel mondo culturale, politico, religioso francese ma non ci riescono perché o si sono squalificati in posizioni troppo radicali o perché la società è riuscita a neutralizzarli facendo finta di ascoltarli, dando loro importanza.
La Francia è il paese della rivoluzione, ma fu una rivoluzione borghese, per i borghesi, per i nuovi ricchi... questo spirito non l'hanno dimenticato. In una parola c’è un processo di involuzione a lungo andare rimarcabilissimo: pensiamo a ciò che era la Francia gli anni ’50, gli anni ’60 sono stati invece quelli di De Gaulle in politica e dell'allineamento opportunista a Roma per la Chiesa incominciando con Danielou. Peccato.
Il mio padrone ha una impresa media, ben meccanizzata con abbondante materiale per il lavoro. Ha lavoro sufficiente anche per l’inverno per tutti e trentacinque operai. Sembrerebbe un padrone modello, lo è anche in confronto agli altri che falliscono continuamente, rispetto alle grandi imprese che sfruttano migliaia di operai. Non ci controlla molto, non bada alla quantità di materiale che si impiega nei lavori, i rapporti sono basati sulla fiducia, si ferma a chiacchierare mostrandosi interessato alle nostre cose e alle nostre idee, agli anziani chiede consiglio, ha una certa dialettica di onestà che lo porta ad assumere nell'impresa spesso casi pietosi di disoccupazione.
Tuttavia paga meno degli altri e in più all'assicurazione sociale dichiara meno del 25% del salario reale. È vero che gli altri padroni spesso assicurano il giorno dopo gli incidenti e per anni tengono gli operai senza assicurazione ed assistenza sociale, facendoli lavorare 12 ore al giorno, ingannandoli perché danno buste paga con conti incomprensibili, controllano continuamente gli operai con capi mastri aguzzini, buttandoli fuori per sciocchezze.
Ieri ho avuto la mia prima busta paga, anch'essa non è un esempio di chiarezza e forse di giustizia. Sono 160 ore normali a 3,40 franchi. Il salario di base è di 544 franchi, mi hanno scontato il 9%. Il totale delle ritenute è di 43,12 franchi su venti giornate lavorative. Restano 500 franchi, non sono molti per viverci 4 settimane. Ma ecco che mi dà un altro piccolo foglio, è una serie di numeri incomprensibili se non ci fosse scritto a mano delle spiegazioni ma gli altri operai non le hanno.
Per 56 ore di lavoro ho 30 franchi di premio, 21 franchi di cestino, 10 franchi di bici. Per ottanta ore di lavoro ho 50 franchi di premio, 30 di paniere, 10 di bici. In tutto per venti giorni di lavoro ho ricevuto 651,88 franchi. Il salario così non è eccessivamente basso anche se considero che lavoro cinque giorni alla settimana e per sole otto ore e non faccio mai straordinario.
Il foglio di paga degli altri operai è meno comprensibile. Sono pagati un terzo in più di me ma sono muratori da anni, hanno famiglia ed alloggio da pagare. Il dichiarato della Cassa di Previdenza sociale è di molto inferiore, così gli assegni familiari sono assai bassi e così anche i rimborsi per le malattie ma il padrone così paga meno tasse e magari la padrona offre una tovaglia all'altare della parrocchia.
Il salario sembrerebbe alto ma in Francia i prezzi sono altissimi. La casa è la spesa principale quando la si trova! Chi riesce a spedire soldi a casa o a capitalizzare è perché conduce una vita impossibile.
Ci si chiede perché allora emigrano? Certo per le condizioni di miseria in cui vivono gli algerini, i marocchini e i tunisini per non parlare di quelli dell’Africa nera: per tutti questi ancora la Francia è il paese del bianco ricco, che comanda e vive bene e permette loro di vivere di briciole. Molti portoghesi (sono 400.000 in Francia) sono spinti anch'essi dalla miseria, dalla povertà, forse spinti insieme agli spagnoli anche per trovare un po' di libertà.
Nella regione di Lione ci sono 40.000 italiani e altri 40.000 sono a Grenoble. La maggior parte di questi è emigrata da molti anni, alcuni da subito dopo la guerra mondiale. Veneti, bergamaschi, calabresi, abruzzesi, siciliani e un po' di sardi. Gli italiani ormai sono ben sistemati a parte i nuovi arrivati.
Nella scala sociale francese vengono quasi alla pari dei marsigliesi e dei corsi, sono prima degli spagnoli, dei portoghesi e quindi prima degli arabi e dei negri. Tuttavia non li si ama molto perché cominciano al pari dei francesi a prendere le distanze dagli altri operai, ad essere "affanculo" mi dice Manuel.
Ogni mese, e questo non lo si riesce a capire, arrivano nuovi italiani. I prezzi del lavoro sono gli stessi d'Italia, i prezzi delle merci sono superiori eppure continuano ad arrivare. Anzi dopo i fatti di Milano e la così detta repressione (così almeno parlano i giornali francesi), si registra un aumento assai sensibile di emigrati italiani. Un po' sono chiamati dai parenti e dagli amici, un po' per la difficoltà di trovare lavoro in patria, ma comincio a pensare che c’è qualcosa di più profondo: è la libertà che ogni uomo ha di scegliere l’angolo di mondo dove crede di poter vivere meglio, magari per ricominciare da zero, per giocare libero tutte le sue carte. L’emigrazione è un diritto naturale dell'uomo.
Io stesso mi accorgo che una simile vita In Italia non avrei potuto mai farla, e farla con questa libertà e quindi autenticità, sarei stato condizionato anche allontanandomi dai luoghi dove sono cresciuto, da tutto un ambiente sociale e religioso. In questo senso mi sento un po' emigrato, portato a condividere e a capire meglio i problemi degli emigrati piuttosto che i problemi dei francesi, di prendere parte per loro, contro i francesi, i padroni di casa. Di questo atteggiamento si accorgono un po' tutti e cominciano a chiamarmi ridendo il «comunista».
Non inizio mai il lavoro prima dell'ora, cerco di andarmene, con un certo calcolo ormai collaudato, proprio al finire dell'ultimo minuto di lavoro. E potrei continuare con simili atteggiamenti che diventano inconsci per me e gli altri però sanno interpretare. Per questi miei atteggiamenti sono delle discussioni che iniziano, loro hanno una certa paura, una certa soggezione verso il padrone come quella che avevano i lavoratori della terra verso i feudatari, un po' quella soggezione che avevano di miserabili nei loro paesi verso i ricchi. È chiaro che io non ho simile soggezione, per questo mi comporto con più libertà e questo al di là del mio essere prete. Del resto non corro rischi, per me non c’è un licenziamento e se mi licenziano non ho niente da perdere. Mi viene da pensare che non potrò mai essere un operaio come loro anche se un giorno riuscissi a lavorare come loro. Dico che lavoro perché essi prendano coscienza ma questa giustificazione non è forse un alibi per me, non è un tradire quel desiderio d'essere veramente come loro senza distinzioni? Interrogativi ancora ecco ... ma loro non hanno il tempo di mettersi interrogativi. Sto scrivendo un pomeriggio di domenica, loro la domenica lavorano a cottimo per proprio conto e non 10 ore ma 12 e anche 15 per arrotondare così lo stipendio: anche di questo cerco di farli prendere coscienza, di far capire loro che lavorando così arricchiscono e danno comodità ai francesi quando invece loro non hanno nemmeno casa.
L’avevo sentito anche dai muratori in Italia, l'amarezza che provano al costruire belle e grandi case per gli altri e poi loro dover vivere invece senza casa. Ma qui il problema si fa più amaro e la sofferenza è personale. Anch'io del resto sono in una situazione simile: abito in una camera di 16 metri quadri e siamo in quattro a dormirvi, mangiare, scrivere e riposare con tutti gli inconvenienti che comporta. Andare a letto in ore differenti, discussioni sulle finestre aperte o chiuse, pulizia irrealizzabile, rumori della flotte, letti a due piani, disordine, cose che si accumulano.
Sono stato a casa di Manuel: ha cinque figli e vive in tre stanze. Il gabinetto è rubato all'area delle stanze e quindi è senza finestra.
I bambini vanno dall'età di 2 anni a quella di nove: quello di nove è un maschio, le altre sono bambine. Cinque e due fanno sette: sette in una stanza a dormire in una stanza, per quante tende il pudore della moglie e sua abbiano potuto mettere. Manuel ormai non pensa ad altro. Pagherebbe anche caro pur di avere qualche stanza in più, un piccolo cortile, magari un pezzo di terra per coltivare un po' di legumi, un fiore. Ma casa non ne trova.
Ne ho cercato una per lui, una bella casa con un piccolo giardino: 45 mila franchi chiedevano. Manuel li avrebbe pagati pur di averla avevamo già parlato a lungo durante le ore di lavoro della gioia di questa casa. Siamo andati dal notaio gerente gli interessi del padrone, ha chiesto quanti figli aveva Manuel e poi improvvisamente ha detto che sarebbe stato molto difficile ottenerla. La delusione di Manuel e mia è terribile: è chiaro che non vuol dare la casa a famiglie di stranieri che hanno bambini. Ho promesso a Manuel di continuare ad interessarmi del problema, ho cercato di dargli speranza. Una sera ha parlato al proprietario stesso ma non c’è niente da fare, il notaio non cambia idea. Dirlo a Manuel non è stato facile. I bambini suoi sono sempre più irrequieti, rompono e rovesciano tutto e lui li lascia fare perché hanno ragione di muoversi ma ieri Francoise è restata sotto un armadio che i fratelli avevano rovesciato. Abilio non si trova in migliore situazione ma almeno il caso di Abilio sono riuscito a risolverlo.
Abilio è sposato con la sorella di Manuel. È entrato clandestinamente in Francia ma non per motivi politici, in un certo modo è anche troppo di destra: ha fatto la guerra In Angola e la giustifica. È in Francia da sei anni: la moglie è in Portogallo e non riusciva a farla venire perché non trovava alloggio. È la prefettura che dà il permesso per la venuta del coniuge e lo dà solo se l'assistente sociale dichiara che l'alloggio è adatto al nucleo familiare. Legge che potrebbe essere giusta se non fosse il mezzo del controllo politico sull'emigrazione, la collaborazione tra i consolati portoghesi e la polizia francese non è certo per la difesa dei diritti dei lavoratori e per la difesa della libertà.
Adesso Abilio abita in un appartamento sufficiente appena per un solo uomo. Gli ho cercato una casa: quattro grandi stanze, un po' di cortile, i servizi, l'acqua e la luce elettrica. È una casa fatta per fare soldi essendo l'adattamento di un fienile ma con una buona ripulitura può andare. Abbiamo fatto la domanda in prefettura per fare arrivare la moglie e i bambini, ho parlato all'assistente sociale per presentarle il caso. La visita alla casa è stata positiva: mi sono fatto trovare con Abilio nella casa per "caso". Sono stati tre mesi di pratiche, di burocrazia, di amarezza anche ma fra poco la moglie sarà in Francia e Abilio lavora più sereno.
La situazione di Abilio e di Manuel stesso in fondo è migliore rispetto a quella di decine di migliaia d'altri operai soprattutto stranieri.
Sempre con Abilio e Manuel sono stato a Lione alcune volte la domenica sera. Andiamo un po' a bere nei posti di raduno degli operai: ci sono i bar per nazionalità, per regione, c’è un bar dove si riuniscono anche i sardi. Domenica scorsa, ormai era quasi mezzanotte, siamo andati in alcune baracche dove alloggiano moltissimi operai. Qualcosa di mai visto se non le baracche delle prostitute, dei mille ruffiani e ladri attorno ai campi militari di Saigon, Na Trang e Danan in Vietnam.
Quartieri bui, montagne di immondizie, strade appena tracciate, qualche raro passante dall'aria losca. Non ho avuto paura ma se ne poteva avere. Le baracche sono di legno: lunghissime mal riscaldate, ad un lato hanno un lungo corridoio strettissimo dove si aprono le porte delle camere. In ogni carnera almeno sei operai: le camere sono sporche, dappertutto gli abiti e le povere cose degli operai, bottiglie semi vuote, catini per pisciare.
Le camere, un pochino meno tristi, sono quelle ornate da grandi cartelloni di donne nude o quasi: almeno c’è un po' di colore.
Da una camera all'altra si sente tutto, è una babele di lingue, portoghese, spagnolo, dialetti italiani. Questi operai sono arrivati perché un filibustiere è andato a comprarli nelle loro nazioni promettendo loro un lavoro, alloggio e viaggio gratis.
Le camere, un pochino meno tristi, sono quelle ornate da grandi cartelloni di donne nude o quasi: almeno c’è un po' di colore.
La situazione degli alloggi non è solo questa: è anche quella degli operai che abitano le soffitte o le cantine spesso in promiscuità al centro di Lione, coi letti occupati a turno; con quelli che muoiono ogni tanto per asfissia per le stufe che non funzionano. I giornali ne parlano raramente e quando proprio non ne possono fare a meno mettono una foto della bara che viene caricata nel furgone.
Abilio e Manuel che adesso sono qui con me ci hanno vissuto tre lunghi anni e non sanno nemmeno loro come abbiano potuto rompere il cerchio e sfuggire.
Abilio aveva una bicicletta, Manuel un motorino, la domenica uscivano: hanno visto così Lione, il cielo, gli altri ed oggi parlano il francese, mettono la camicia bianca, si sentono arrivati quasi. Ma ci sono operai in questi alloggi da quattro, sei anni che non dicono bene in francese nemmeno una parola, non conoscono una strada. Conoscono il cantiere, la macchina che li prende la mattina per il lavoro e li riporta la sera, alcuni conoscono la bagassa dell'angolo della baracca ed è tutto. Forse conoscono anche un ufficio postale per spedire i soldi in patria quando non si sono fidati di un altro che li spedisce al loro posto, se li spedisce.
I problemi si sommano ai problemi e i problemi della vita quotidiana, di questa vita di lavoro sono proprio all'origine dell'intorbidamento dell'acqua del mio stagno, sono (forse fortunatamente) per fare emergere i grandi problemi che opprimono il mio essere, insoluti mi hanno scheggiato, distrutto. Sarà il lavoro, un lavoro duro e una paga ridicola che mi offende, saranno gli uomini che mi circondano, nella loro gamma che va dalla diversità di costumi, di età, di nazionalità, di formazione. Saranno le mie considerazioni personali su questa mia vita di oggi, attimo di attesa tra il passato e il futuro, nella necessità di quest'attimo e nella difficoltà fatta impazienza dell'accettarla anche perché è dura.
Sono giorni che mi sono dati per un riconsiderare un passato, per accettarmi in ogni istante e in tutte le mie relazioni con gli altri.
Penso a me (e con me a Manuel, Abilio e tutti gli altri operai che vivono con me questa avventura), al mio essere vivente in una tensione eterna, in una dimensione teologica, in relazione con un mondo d'essere materia, viventi, d'essere spirito in relazione con l’Essere. E in questa dimensione il mio essere, il mio esistere. La vita che si fa, la mia vita ed io che passo cambiando in forze e pensieri lentamente ma ineluttabilmente arrivando alla morte. Come accettarmi in questo tempo, come accettarmi nella morte, ecco la tensione. Questo mio lavoro, anonimo e duro è per arrivare ad accettarmi, per arrivare a questa pace e serenità, almeno a sperare che potrò in giorno farlo. Mi sembra che sia Dio che mi metta in ginocchio, gli uomini che mi mettono in ginocchio, io stesso ma in una repulsione, in un attaccarmi alle piccole cose, in un modo da disperato, da naufrago. Il vento che soffia e spazza le nuvole, in nuvole di foglie dai mille colori, gli orizzonti si scoprono sempre più lontani, le cime si rivelano sempre più alte e lo stare qui in questa casupola isolata mi intirizzisce fisicamente e moralmente. La solitudine che aumenta, solo dinanzi al mondo, ai problemi di esso, problemi da risolvere imperiosamente perché sono dolore degli altri e mio. Solo dinanzi a me nelle folle del mondo, nelle masse del presente. Solo al punto che a volte cerco di sedermi vicino a qualcuno che credo meno nemico degli altri.
Sapevo che sarebbe stato duro ma non sapevo i limiti di sofferenza che avrei dovuto toccare.
Siamo alla fine dell'anno, mi sento alla fine del mio cammino, almeno di quello che ho la forza di percorrere. I fatti della vita, il martellare di questi mesi non hanno salvato niente in me, nessuna struttura è restata almeno senza essere ridicolizzata nell'intimo di me stesso: ogni cosa che aveva apparenza di possesso è stata perduta. So che deve essere così, sono venuto per questo, per essere povero, umile come il Cristo a Nazareth.
Sono in una piccola casetta in cima ad una collina, in mezzo ad un bosco, un piccolo bosco su cui è difficile trovare dei sentieri, bisogna aggirarlo o, come ho fatto io, passarvi come i cinghiali quasi. Dopo il bosco sono campi, vasti campi arati per la prossima primavera, altri di foraggio, altri con le secche canne di mais. I villaggi non sono lontani ma è quanto di più si può trovare di solitudine in questa regione: il fischio del treno, il rumore di qualche vettura, degli aerei non disturba. Sono arrivato che nevicava. Una neve finissima fatta quasi di ghiaccioli che ha dato una tinta di bianco alla campagna ma non ha continuato. La notte ha fatto freddo, la luna e le stelle hanno illuminato tutto. Questa mattina tutto era sotto un leggero strato di gelo bianco.
Ho passato la giornata di ieri qui, poi, la notte, resterò oggi e domani mattina ritornerò al villaggio, a piedi come sono venuto e spero che anche domani nevichi: mi piace camminare sulle strade mentre nevica, nella bufera. Adesso è sole magnifico anche se fa freddo e pesti il ghiaccio per i sentieri del bosco da me percorsi. Non faccio molte cose. Dico l'Ufficio, leggo la Bibbia (Isaia, Salmi, il Cantico dei Cantici, la Sapienza, Geremia soprattutto la storia di Abramo) e poi penso.
Tante cose ritornano come è ritornato il gusto del fuoco che brucia, del pane tagliato col coltello e portato alla bocca a fette, del pane e delle salsicce.
Ritornano volti: babbo, i fratelli, gli amici. La mia vita a casa e in seminario, il mio errare per il mondo. Ritorna il ricordo del mio continuo cercare Dio, un equilibrio spesso ritrovato e subito perso per qualcosa che non durava all'interno di me e anche all'esterno. E quindi un altro cercare spesso in luoghi e persone diversi.
Anche qui è un posto, uno di quei posti che penso definitivi almeno come acquisizione perché li credo categoria della mia esistenza, del mio modo d'essere sacerdote. La mia vita di lavoro manuale mi porta pian piano all'essenziale, ad essere uomo e prete senza sovrastrutture. Qui mi sento dinanzi a me, a Dio, agli uomini uomo chiamato a Consacrare presente il Cristo, a dare questo Cristo e a realizzarlo, mi sento sacrificatore, l'uomo del sacrificio e mi sento sacrificio stesso: e tutto per rendere un servizio all'umanità perché chiamato a questo servizio.
Ieri sera, – era già buio, notte, e fuori era il ghiaccio e nel mio tavolo bruciava una candela ed io meditavo, guardavo la fiamma e curavo la stufa –, ho pensato a Pasternak nel bosco anche lui:
Una candela bruciava nella notte. Una candela bruciava.
Sonia è diventata la mia solitudine ed io mi sono sentito un po' come il dottor Zivago errante di luogo in luogo, sempre incerto, vinto dai fatti della vita in contraddizione con il suo pensiero, lui vinto poi sulla strada per il credere ad una immagine. Ho pensato anche:
Alle chiatte che scendono nei fiumi / che sgelano a primavera.
Questo mio scendere inesorabile verso la morte, verso il giudizio, il mio destino, verso il grande oceano di Dio pace.
La notte scorsa ho ritrovato il gusto delle notti passate in Sardegna a casa o in campagna anche se mancavano i rumori dell'infanzia, il campano dei buoi, gli zoccoli delle bestie nel selciato delle strade, il richiamo dei cani e magari il piffero dei pastori e le stelle. Nelle notti sarde tutto trema, vibra, titilla quasi... questa notte tutto era fermo, stabile, testimone. Sono contento di essere venuto qui anche se capisco che sta per venire di nuovo un rovesciamento della mia esistenza.
Mi vedo come un bonzo Zen nella veranda di un convento, nella contemplazione di un giardino simbolo, segno. Il bonzo ha il pericolo di credere che la vita sia quell'immagine, quel giardino, quel simbolo. C’è la vita, c’è il male, c’è l'instabilità, il dolore, il mistero dell'intervento rivoltante di Dio e lui guarda il simbolo e dal simbolo passa a Dio, a se stesso, alla pace... una soluzione di comodo (se non è vocazione personale) per non essere nella vita vera, per non essere rivoltati dalle onde del mare – male, per non restare disperati e nel buio della ricerca di Dio e del suo intervento dove non siamo capaci di vederlo, di contemplarlo anche se ci sentiamo chiamati a questo.
Non sono in una veranda a contemplare, sono dinnanzi ad un muro, spalle al muro respinto dalle onde. La salvezza è il togliermi dalla tempesta o invece forse è esserci, restare, accettare di essere relitto, sballottato senza spiaggia.
Penso a chi lavora con me, un siciliano quando lavora sul ponteggio ci dice spesso «Lu padri e la madri, lu flgliu e la figlia lavuravanu tuttu u jornu per guadagnari a stentu na pastasciutta». Spesso quando siamo a corto di argomento, gli chiediamo perché è venuto a lavorare in Francia e lui ricomincia con il ritornello, cinque, dieci volte al giorno. Non dice altro, qualche volta intona altissima una canzone. Adesso guadagna un pastasciutta per lui e la famiglia e gli basta. La miseria gli ha dato alla testa... si crede nel paradiso.
Franz invece è più enigmatico. Era soldato dell'esercito tedesco durante l'occupazione della Francia. Ritiratesi le truppe lui restò nascondendosi. Incominciò a fare il manovale e lo è ancora. Tutti i suoi sono morti, il suo villaggio natale adesso si trova nella zona polacca. Si fa conoscere per la sua bontà e il suo aiutare un po' tutti. Ma adesso è all'ospedale. Per un piccolo incidente di lavoro. Era in cassa mutua ma potendo lavorare ancora era andato ad aiutare una vecchia a portare giù il fieno per le capre. Forse per il buio, forse per la debolezza è caduto dal fienile rompendosi la spina dorsale, resterà tutta la vita in un letto, adesso sta perdendo anche la parola. Secondo le leggi sociali non ha diritto a nessuna assistenza perché "lavorava" durante il periodo di malattia. È un povero relitto eppure Franz ha cercato di dichiarare di essere caduto a casa sua per non creare problemi alla povera vecchia. La vecchia piange seduta vicino al suo letto e gli porta piccoli formaggi di capra: di più non può fare.
Lo chiamano lo "jugoslavo". Di lui sappiamo quasi niente. Un giorno il padrone l'ha portato nella nostra équipe e così lavoriamo assieme. Pallido, dai capelli rossicci, alto, è il classico tipo slavo, il padrone poi me ne ha parlato: è stato trovato dalla polizia a Lione svenuto per la fame. Ricoverato in ospedale alla fine della degenza la polizia voleva rispedirlo in Jugoslavia. Per una coincidenza l’assistente sociale del padiglione era la nuora del mio padrone e quindi l'ha assunto a nome suo e la polizia non l'ha più potuto rimpatriare. Adesso è manovale con me dell'équipe nostra. Fa freddo e lui è vestito di stracci con un paio di scarpe da tennis vecchissime. Gli chiediamo come sta, se ha freddo, se ha mangiato, se è stanco, se vuole riposarsi e lui ha una sola risposta: «ça va, merci».
Questo «ça va» è ossessionante. Pian piano con i nostri vecchi abiti e con le scarpe vecchie l'abbiamo vestito e calzato, adesso che è al caldo i «ça va» si moltiplicano. Lavora come un dannato anche se non ha resa. Cerco di fargli capire di non uccidersi e di non ucciderci (!) prendendo un ritmo troppo svelto. Mi capisce benissimo, parla l'italiano, il tedesco, non so quali altre lingue slave, capisce lo spagnolo e capisce e parla un po' di francese. Ieri il figlio del padrone è venuto con i fogli del progetto per vedere i lavori: lui ci ha dato uno sguardo, poi mi ha detto: «Gianni è bravo ma io so fare lo stesso e in fretta», comincio a pensare che sia un intellettuale, un politico che cerca di nascondersi, di farsi una nuova vita, sorride sempre, saluta per primo. È contento di lavorare con noi, nella nostra équipe di stranieri anche se non ha molta simpatia per gli arabi, ad ogni modo «ça va», «ça va». Per Schamalal invece a va pas in Francia.
Tutto è incominciato che «ça va pas». In Tunisia c'era la guerra e gli aerei distrussero il suo villaggio, uccisero i suoi genitori, bruciarono la sua casa: ça va pas la guerre. Venne portato in collegio, ma nel collegio c'erano i militari che lo picchiavano: ça va pas i militari. Scappò in montagna con i ribelli ma non c'era da mangiare: ça va pas la fame. Si arrese, fu messo in prigione ma lì lo torturavano: ça va pas la prigione. Uscito partì in Francia: ça va pas la Francia. Il lavoro è pagato poco, giusto per mangiare, le donne chiedono molto, sono sbrigative, fa freddo e la stufa non tira, lui tossisce continuamente: ça va pas.
Dice che ritornerà in Africa fra sette mesi: chissà perché sette mesi? Ieri però l’hanno preso per il sanatorio: chissà se ritornerà in Africa? ... ça va pas proprio.
Questa mattina appena iniziato il lavoro ci è caduto il ponteggio. Avevo preparato l'impasto come al solito. Abilio mi dava una mano e Manuel era già sopra. Portato l'impasto alla carrucola ho incominciato a tirare, forse la carrucola era troppo all'esterno dell'asta di sostegno o forse il sostegno stesso era troppo lungo e così lentamente tutto il complesso del montaggio si è inclinato all'esterno e con i tavoloni ha incominciato a cadere.
Abilio si è messo in salvo per primo, scappando ci ha avvertiti del pericolo, Manuel si è aggrappato ad un davanzale di finestra ed io mi sono infilato con un balzo nell'apertura del garage. Il montaggio è venuto giù lentamente appesantito dalle tavole e soprattutto perché trattenuto da un tavolone che ieri avevo messo nonostante lo sghignazzare di Manuel. Ieri ridevano perché lo credevano inutile e giocavano sul fatto che dimostravo di non aver voglia di morire presto. Senza il tavolone il montaggio sarebbe venuto giù più in fretta, Manuel non avrebbe avuto il tempo di aggrapparsi al davanzale ed Abilio ed io saremmo restati molto probabilmente sotto il ponteggio o ci avrebbe colpiti qualche tavola, del resto il secchio cadendo con la carrucola e l'impasto mi sono passati a meno di dieci centimetri.
Caduto il ponteggio non abbiamo detto nemmeno una parola. Manuel mi ha messo in mano un puntarello per svitare gli elementi di ferro e per rimontarlo. In due avevamo smontato e rimontato il ponteggio: ieri avevo impiegato una mezza giornata a piazzarlo. Ma Abilio e Manuel erano nervosissimi, capivo che avrebbero bisticciato e non tanto per il ponteggio (nessuno ne aveva colpa, nemmeno io con il secchio), quanto per sfogarsi.
Al pomeriggio alla ripresa del lavoro la tensione non si era ancora scaricata. Io stesso ero ancora teso, al pranzo non ne avevo fatto cenno, non avevo detto niente nemmeno al padrone anche se io fossi arrabbiato proprio con lui. Pensandoci su, mi sono accorto che l'impalcatura era troppo lunga e troppo alta in proporzione agli elementi di sostegno e di rinforzo ed il padrone che è avaro nel darci gli elementi, lui pensa ad aprire il più possibile dei cantieri.
Abilio e Manuel lavorando vicini e in fretta senza parlare si sono schizzati dell'impasto: è stato l'inizio del bisticcio. Una discussione stupida, un bisticcio amaro perché tutti e due non avevano niente da dirsi e perciò sono ricorsi a parole sempre più forti rivangando il passato, le loro capacità di lavoro, la loro infanzia, persino le loro idee politiche.
Il bisticcio è andato per le lunghe, stavo zitto portando sempre più impasto perché lavoravano sempre più in fretta, non riuscivo ad inserirmi nella conversazione non sapendo cosa fare e cosa dire anche se era chiaro che aspettavano proprio il mio intervento per smettere. Ed io ad attendere mentre la tristezza aumentava sempre più in me. Ad un dato punto portando il secchio sull'impalcatura (ormai non mi servivo più della carrucola per una certa prudenza) proprio quando Manuel stava allungandosi per prendere il manico del secchio l'ho lasciato cadere ostentatamente. Manuel ha incominciato ad insultarmi; Abilio voleva ridere ed io ho riso e poi improvvisamente ho minacciato di andarmene a casa. Mi sono seduto sul tavolone ed ho incominciato a parlare, a gridare in un misto di portoghese, di spagnolo e di sardo. In fondo dicevo che era troppo la miseria del lavoro, il freddo, l'incidente, la poca paga e il poco mangiare, l'essere sfruttati dai padroni. Perché voler aggiungere anche le nostre coglionate e giù una serie di parolacce. Manuel cercava d'intervenire ma io non m'interrompevo, Abilio era contento, visibilmente contento.
Pian piano hanno diminuito l'intensità di lavoro, il ritmo si è calmato, all'ultima mezz'ora non abbiamo fatto niente. Abbiamo anche scherzato ma c'era presente in noi l'immagine di Franz, lo spettro degli altri operai inabili per tutta la vita per incidenti di lavoro, con una pensione da fame e peggio con la famiglia, la moglie e figli, alla fame.
Questa sera rientrando in bicicletta ero estenuato anche psicologicamente, la strada era più lunga e più nera del solito e alla Messa ho pensato alle cadute del Cristo salendo il Calvario: incidenti di lavoro.
Non riesco proprio a trovare una via di possibile soluzione per Francisco. Tutto è incominciato la domenica sera che Abilio è venuto a trovarmi con il suo amico portoghese: Francisco. Un bell'uomo, ben vestito, cortese, anzi untuoso quasi, parla bene il francese, si dice contento, molto contento di stare in Francia, dei soldi che guadagna. Andati al bar ha voluto pagar lui, tutto lui nonostante il conto fosse un po' alto: questo mi aveva fatto pensare subito.
Dopo un po' di tempo Manuel durante il lavoro sembrava preoccupato, parlava sotto voce con Abilio e in portoghese. Poi non ha resistito, è sceso dal ponteggio e venuto ad aiutarmi a fare l'impasto: era chiaro che voleva chiacchierare anche se Abilio sembrava non molto contento. Mi ha chiesto di andare da lui a cenare per "dare una lezione" a Francisco. Il giorno prima infatti Francisco ha picchiato la moglie, sfasciato tutto a casa. Nel caseggiato è stato uno scandalo: un signore che abita nel piano di sopra è entrato nell'appartamento di Francisco e per separarlo dalla moglie, l'ha picchiato abbastanza forte aprendogli un sopracciglio. Oggi Francisco non è andato al lavoro, a casa non ha un soldo, la moglie non cammina più, il bambino invalido è malato.
Pensai di andare a casa di Manuel, per riuscire a capire cosa stava succedendo a Francisco, la moglie di Manuel sapeva tutto ma non mi aiutò a capire. Così decisi di andare a casa di Francisco per chiacchierare con lui, non feci accenno alla ferita. Ci raggiunse Manuel e Abilio e assieme siamo usciti con Francisco, volevo capire. Così abbiamo incominciato a parlare ed ascoltare. Manuel e Abilio sapevano già.
Francisco vuole liberarsi della moglie e dei figli e restarsene solo. Un figlio è invalido mentalmente ed ha quasi tre anni, l'altro più piccolo è spesso malato. I bambini mangiano regolarmente perché la moglie di Manuel ogni giorno manda a casa di Francisco qualche provvista. Manuel mi dice che il bambino piccolo di Francisco è invalido perché Francisco portò la moglie in un bosco quando era incinta e la picchiò a sangue, le saltò addosso con gli scarponi...
Francisco è pazzamente geloso della moglie. Essa non può uscire di casa quando lui è al lavoro, deve tener porte e finestre chiuse. Non può ridere, guardare in faccia un altro, ma lui è sempre fuori, sembra che non s'interessi di lei.
Abilio, ormai anche lui, mi chiede di trovare una soluzione per la moglie di Francisco e per i bambini. Francisco è sempre più senza soldi, non si sa dove li spende, non dà niente alla moglie, spende soprattutto per bere con i compagni ... Abilio dice che li spende con i compagni per certi giochetti, Francisco è capace di scomparire e lasciare moglie e figli alla fame o di farli spedire in Portogallo... sarebbe condannarli ancora alla fame ed è condannare il bambino invalido ad una vita di emarginazione.
Ho pensato di rivolgermi al sacerdote del consolato portoghese: sembra che sia uno schifoso. Per tradurre una lettera chiede 1.500 franchi, per un matrimonio 4.000, per ottenere un posto vuole una mensilità e tante altre simili cose. Manuel poi non ci andrebbe a trovarlo: il gioco della mensilità l'ha fatto anche a lui quando gli ha chiesto una sistemazione per la sorella... e i soldi li vuole anticipati.
Ne ho parlato con l'assistente sociale. Non c’è niente da fare: la moglie non può ricevere l'assistente sociale senza che ci sia presente Francisco. Non si può trattenere una parte del salario sulla busta paga perché sono sotto regime portoghese e non francese. L'unico modo sarebbe consigliare alla moglie di rivolgersi alla polizia la prossima volta che il marito la picchia: solo un processo potrebbe costringere Francisco a dividere i soldi con la moglie e i figli anche se ritornasse in Portogallo. Ma la moglie non farà mai questo, non parla una parola di francese, le sorti del processo stesso sono incerte... la famiglia poi è distrutta.
Credo non ci possa fare niente. Francisco forse incomincia a sfuggirmi, si nasconde per non incontrarmi.
Le conversazioni con Abilio e Manuel si fanno sempre più amichevoli, parlano già dei loro problemi. Ormai posso ricostruire la loro vita.
Manuel e Abilio hanno lavorato assieme dall'età di 13 anni, Abilio era più piccolo. Facevano almeno 10 km. a piedi per recarsi al lavoro, lavoravano in cantieri per aprire strade in montagna, per fare più in fretta si tagliavano gli zoccoli di legno, la sera al ritorno prendevano il sentiero più ripido, correvano per il dolore delle ossa e dei muscoli un po' con le gambe rigide. Ed avevano fame, sempre fame: un po' di pane, una patata e una cipolla. «Come era bella l'acqua» mi dice Manuel quando racconta. Gli operai un po' più anziani davano loro a volte un sorso di vino e Abilio così si ubriacò la prima volta, ma nessuno dava loro mai da mangiare e loro volevano altro pane.
Poi diventarono più grandi, guadagnarono qualche scudo in più, il tanto per avere il coraggio la domenica con la camicia bianca, bere un bicchiere di vino cattivo e cominciare a pensare a parlare di ragazze... a guardarle.
E così partirono a fare il militare. Manuel in una scuola militare, cameriere alla mensa dove forse mangiò per gli anni che non aveva mangiato. Abilio in Angola ad uccidere i negri. Li portarono a Fatima prima di imbarcarli per l'Angola... partivano per difendere la religione, uccidere comunisti e rivoluzionari. Così dicevano loro e Abilio, forse perché glielo dicevano anche i preti, ci ha creduto. Oggi quando nel conversare rivelo un po' le mie idee Abilio si chiude in un silenzio triste ma allo stesso tempo giudice: lui non mi segue con le mie teorie!
Abilio questi giorni è preoccupato ma sono sicuro che non mi parlerà mai del suo problema, forse anche perché non si fida di me, forse perché sa che non ci posso fare niente.
È stato Manuel a parlarmene. Il fratello di Abilio è ricoverato all'ospedale psichiatrico, tra poco lo spediranno in Portogallo perché è entrato clandestinamente in Francia.
Vittima di un esaurimento nervoso il fratello è spesso preso da allucinazioni, dinanzi ai suoi occhi si presentano serpenti, vipere e lui impaurito comincia a tirare sassi. Ma non è solo questo il problema, c’è anche il fatto che è innamorato della sorella di Manuel, si vedono la domenica a Lione. Manuel è contrarissimo a questa relazione. Considera il giovane come matto, incapace di lavorare, lo disprezza. Abilio capisce che Manuel non ha tutti i torti ma per orgoglio non può dargli ragione. La sorella di Manuel tuttavia continua la relazione con il giovane. Per questo lei non va più da Manuel.
Un altro problema che mi porto senza soluzione. Una volta partito in Portogallo le cose non cambieranno di certo.
Sono a casa malato ormai da una settimana, mi annoio terribilmente anche se gli operai vengono a visitarmi, a tenermi allegramente compagnia (a modo loro! ieri Manuel è venuto con un fiasco di vino nero). La febbre non tende a scomparire ed io mi sento stanco. Sto male fisicamente e spiritualmente. Dentro di me sta coagulando la vita. Un mistero che prima non avevo mai intuito: il mistero mio dinanzi al mistero degli altri. Io stesso navigo in un mistero. Dinanzi alla ributtante vita dei poveri, alle loro sofferenze, anch'io soffro. Non lo capiscono e questo sconvolge i loro piani. Credono che nasconda qualcosa. Questo mistero è solo per gli altri o è anche per me?
Sono abituato, veramente abituato, a scrutarmi, a giudicarmi. Credo di conoscermi ma qui è un'altra cosa. Sarà anche che mi solidifico ma io non mi riconosco più. In fondo devo essere un uomo vergine, niente mi ha ancora toccato e fatto suo, come del resto niente ho fatto mio ancora. La stessa fede non mi ha conquistato, lo stesso sacerdozio, gli stessi miei anni di gioventù in questo mondo d'oggi esaltante, lo stesso futuro umano e cristiano, la stessa miseria e sofferenza dell'umanità, la stessa guerra vietnamita, lo stesso mio essere venuto qui, stessi uomini.
Quasi direi anche che non ho niente, forse, per essere conquistato, l'amo che mi lanciano non può impigliarsi in me evanescente ed io non ho un amo da lanciare e non ne lancio. Certo non manco di dialettica, il voglio è profondo ma è una dialettica, è iniziale ancora tra tesi e antitesi: mai una sintesi. Direi che sono ancora allo stato di antitesi. In questo senso mi sento femminile, disposto ad essere preso, seminato, riempito, disposto ad essere dominato, usato da un altro nel desiderio di più profondo oblio di me stesso.
Ecco ho desiderio di dimenticarmi. Ma non dimenticare fatti, non ho fatti da dimenticare, dimenticare me stesso. Un po' franare lentamente nella vita che brulica in questo mondo fatto di angoscia del presente (l'angoscia ieri nella guerra del Vietnam, oggi l'angoscia della situazione degli operai e soprattutto degli emigrati). Il desiderio della goccia d'acqua nell'oceano, del granello di polvere nel deserto, del frammento di grano nella farina, dell'atomo di ossigeno nell'aria. E tanto più forte è il desiderio quanto più mi agito per "fare qualcosa" e rompere la solitudine vuota che mi pesa. Mi pesa perché ancora non è solitudine, non sono ancora atomo, goccia, molecola, frammento di farina per una pasta che può essere nel mistero del futuro, della vita infinita, del tutto. Ostia consacrata per il Pleroma e pane per un bimbo che ha fame. Allo stesso tempo tutto questo non è una speranza, non è una volontà di esserlo. È un malessere per non esserlo e nel malessere mi fermo quasi sterile.
Sto rileggendo in questo periodo il processo di Kafka: è un affondare pian piano imprevedibilmente in una situazione, in un modo d'essere, di vita che è annientamento della situazione dell'essere e della vita, mangiato pian piano dalla paura che si fa sempre più consistente.
Mi accorgo di cambiare, di maturare anche perché in me ho scoperto la paura. Non è la paura comune. Io non ho paura la notte, non ho paura di andare in aereo, ho volato sui bombardieri, sugli elicotteri in piena operazione di guerra, mi sono gettato in paracadute in pieno combattimento, prigioniero dei Viet li ho sfidati, ho viaggiato in strade minate. Rischio, questo mi aiuta a vincere la mia paura che è molto più profonda, nel mio essere stesso. Ho paura del mio esistere.
Scrivendo di mio padre, l'elegia per la sua morte, ho parlato della sua umanità semplice, umile, del suo odore di terra: la sua gloria. Non desiderava altro e la vita non gli chiedeva altro. Ma la vita cosa chiede da me, mi sembra di non saperlo o non l'accetto?
La mia vita è nel mistero del soprannaturale... Accettare questo mistero è fede. La mia realtà è qui, in questa vita. È difficile esprimere questo pensiero. Ma una cosa di quaggiù non potrà mai appagarmi perché mi credo più grande. Tutte le cose di quaggiù non mi possono appagare: mi credo più grande ancora, anche se in questo campo la mia coerenza non sia proprio esemplare. Ma sembra certo, per esempio, che ormai sono chiuso per sempre ad una famiglia, alla donna, all'intimità. Sono certo che se una donna dovesse entrare per la vita imprevedibile in me, non romperebbe se non esternamente quella rinuncia, essa sarebbe sempre valida e le altre cose sarebbero alienazione, momenti trascurabili, insignificanti al mio vero essere. La rinuncia non è per il sacerdozio, mi sembra, ma perché quasi costituzionalmente, psichicamente sono chiamato ad una mistica delle cose del mondo, ad una mistica del mio essere, dell'uomo stesso.
Nel mistero della mia vita è il sacerdozio sacramentale di cui ho il carattere. Il sentirmi legato cioè a Dio in un modo particolare per doveri verso l'umanità e all'umanità per doveri verso Dio; è questo il mio essere? E tanto più ne sono convinto quanto più assumo atteggiamenti che non mi caratterizzano "prete"; non porto abiti, distintivi ecclesiastici, lavoro da manovale o da giornalista "laico" e tanto più scompaio come "prete" più mi sento prete. Solo qui trovo giustificazione del resto al mio lavoro tra gli operai, non certo nelle giustificazioni di essere "presenti" alla classe operaia, alla sofferenza, o peggio di "convertirla". Per me è questione di "essere" in un modo piuttosto che in un altro, non di un "esserci", mi sembra del resto che si studiava come distinzione tra "da sain" "in sain". Anzi mi sembra di poter dire di essere contrario al prete che lavora se va in mezzo agli operai con diverso atteggiamento di "essere". Il prete operaio può annunciare il Vangelo raramente, compiere le azioni sacerdotali limitatamente, ogni attività è condizionata dal lavoro e dalla stanchezza. La loro efficacia evangelizzatrice quindi è quasi nulla. Per queste si ha un disgusto insuperabile. Gli operai stessi non sopportano i preti operai, non li si accetta e non si ha simpatia per loro. Si resta estranei nonostante l'"esserci" e peggio si è strumentalizzati dagli operai per tutt'altri fini che spirituali e di carità. Non parliamo poi dei frutti per i quali segretamente si è venuti. Non si raccoglie, non esistono frutti. Si è un po' travestiti, falsi, c’è un’inclinatura che mette successivamente operai e preti su due piani. Si è preti e non operai, si è preti naif, idealisti e gli idealisti spesso sono stupidi.
È vero che anch'io sono in croce perché mi accorgo sempre più che non sarò mai un operaio come loro. Non è solo il problema del lavoro o di capacità, è che gli atteggiamenti stessi della gente verso di noi sono sempre diversi. Noi abbiamo acquisito nella nostra educazione deformazioni "ecclesiastiche" ridicole, si è un po' intellettualoidi, la nostra personalità tende a schiacciare quella degli altri, una certa dialettica ci fa superiori e falsa i rapporti. L’operaio inconsciamente ha paura di noi e rischia di avvicinarsi a noi ancora una volta, non come uomini ma come "preti". In fondo però è stato utile questo "esserci" perché è servito a far avanzare molte idee sulla Chiesa, sui preti e anche sulla società. Si è scoperto la debolezza delle formule, si è cercato di battere l'unica strada seguita dal Cristo uomo-Dio, quella dell'autenticità, della violenza della realtà, della storia. Ma è un discorso difficile da fare ai preti questo. Del resto mi accorgo che spesso non è un discorso che vogliamo fare. Il malessere dei preti è piuttosto un problema di non trovare abbastanza soddisfazione nella vita, di non avere abbastanza soldi, potere, di non avere abbastanza seguaci. L’estate scorsa ritornando dopo l'esperienza in Asia e risalendo un po' tutte le città italiane cercavo di testare il polso ai preti per la scoperta del malessere di molti preti italiani. Malessere terra terra nascosto sotto motivazioni "ideali". Gente delusa perché lo stato ecclesiastico in pratica non dava loro le soddisfazioni segrete: sicurezza economica, potere, seguaci possibilmente del gentil sesso, fannulloneria. In questo senso preferisco gli spretati anche se loro spesso nascondono la loro delusione e le loro scelte sotto motivazioni "autentiche".
Ieri mentre lavoravamo, la radio ha parlato della lotta della Chiesa d'Olanda e Roma a proposito del celibato ecclesiastico. Naturalmente gli operai hanno preso al balzo il problema e mi hanno stuzzicato. Quasi tutti sono favorevoli al prete che si sposa. Solo Abilio tenta di dire che Gesù Cristo non si era sposato, che se il prete si sposa pensa alla moglie e non agli altri. Rientrato a casa ho cercato di leggere qualcosa su ciò che si sta vivendo. Il sinodo olandese, le richieste a Roma, le risposte, il discorso del Papa in Piazza S. Pietro, la lettera del cardinale Villot, l'articolo di Danielou nel «La Croix», la posizione dei vescovi francesi.
Non mi sono mai fermato troppo sul problema ma quando il Papa fece uscire l'enciclica sul celibato mi sentii amareggiato profondamente come del resto per il suo "Credo". Qui si gioca a dispetti come nella più bassa e sporca diplomazia.
L’estate scorsa con un gruppo di amici affrontammo il problema insieme a quello dei divorzio e la mia posizione li colpì profondamente anche se pure allora dichiarai di non aver studiato a fondo il problema. In pratica riconosco sacerdozio e celibato uniti quasi nella loro natura. Il sacerdozio chiede solitudine, la vita matrimoniale chiede invece partecipazione. Come si può avere la partecipazione del sacerdozio nel matrimonio? Certo se il sacerdozio è compiuto come un esercizio di una professione, di determinati atti, che per quanto sacri siano, restano distanti dalla vita e dall'essere dell'individuo. Così anch'io non vedo il perché il prete non possa essere sposato. E purtroppo l'educazione data fino ad adesso è per un e compie degli atti: quindi anche il discorso sul celibato suona falso messo com’è in una visione utilitaristica, per non parlare dell'altra castroneria che vuole conservare il celibato perché è una "ricchezza", un "vanto" della Chiesa latina... Una scelta utilitaristica ancora e quindi anti evangelica.
Certo so che per natura l'uomo è completo nell'unione dell'uomo e della donna: questa è la ragione dell'essere umano. Per dimostrarlo, a parte Freud etc., basta leggere la Genesi. Perché allora sono per il celibato dei preti? Il celibato è l'accettare di essere incompleti quasi ontologicamente e questo non per mettermi in un piano sbagliato, o in quello dei surrogati. L'incompletezza ontologica certo è una ferita, un limite, ma mi lascia aperti altri orizzonti. Troverò completezza in Dio, mi lascio aperto agli altri, a tutti gli altri. Del resto, parlando soprattutto del celibato del prete mi sembra di dover dire che l'unico e sommo sacerdote, il Cristo, doveva essere vergine per l’unzione dell'unione della natura umana con il Verbo. Certo resta il problema che il celibato è tra i consigli evangelici, che per lunghi tempi il celibato non c’è stato come regola e per lunghi tempi ancora quando la regola fu messa non è stata rispettata, resta il problema che nella Chiesa orientale si ha il doppio regime. Ma per me è così. Tuttavia non vedo chiarezza in nessuno dei comportamenti delle due parti in contesa. I preti che chiedono di sposarsi per quali motivi lo fanno? A loro giustificazione è solo il fatto che sono stati educati per compiere determinati atti e non per darsi al Cristo. Se fossero divenuti preti per darsi totalmente al Cristo in un amore assoluto e folle, certo, oggi non sarebbero così numerosi quelli che si sposano e lasciano il sacerdozio... questo amore certo si deve essere chiamati, averne avuto il dono. E qui il discorso potrebbe inserirsi su cosa è il sacramento del sacerdozio. Oggi la Chiesa ordina preti secondo canoni (codificati) d'utilità alla diocesi, alla Chiesa Universale: un vescovo può bellamente rifiutarsi di ordinare uno se non gli "serve" in diocesi. Ora mi chiedo: può essere un dono, un carisma del Cristo per il servizio al popolo di Dio, amministrato così? L’essere prete non è piuttosto un carisma che non chiede tale socializzazione, gerarchizzazione? Cosa si vede nel Vangelo, negli atti degli Apostoli, nelle epistole? Credo che sia tutt'un altro discorso che va fatto.
Noi in fondo ci trasciniamo nella Chiesa cattolica tutta una serie di legislazioni, di politicizzazione antica (greco - romana - germanica) che più o meno ha retto ed è servita nei secoli passati ma che oggi non regge più e non tanto perché il mondo si fa meno cristiano ma soprattutto perché esso diventa più cristiano cioè libero, frumento, carisma, messaggio buono. E la stessa cosa per il matrimonio? nella Bibbia, nel Vangelo, nelle epistole: matrimonio c’è se c’è amore assoluto tra i due. Ora tra questo che troviamo nella Bibbia e l'atteggiamento della Chiesa nella sua legislazione del matrimonio c’è un abisso. E in questo senso non sono affatto lontano dal Card. Pellegrino che chiede necessario uno studio attuale sul problema del divorzio: anche qui la legislazione attuale, la Bibbia e la tradizione non so proprio se vadano d'accordo. Ho incontrato un gruppo di sacerdoti del Prado, anche loro si mettono gli stessi problemi: lavoro tra gli operai e celibato. Essendo religiosi quasi è chiara la loro posizione per il celibato tuttavia mi dicono che loro sono per una libertà di scelta, una libertà individuale anche se il clero francese di una certa età si schiera per il celibato. Ho espresso le mie opinioni, mi seguivano, mi sono accorto ma ero troppo dialettico, troppo chiaro.
Mi domando che diritto ho a parlare così? Anche in me il fatto del celibato non è troppo chiaro e Dio solo sa quali lotte! C’è il fatto poi della dimensione dell'amicizia femminile nella vita. Amicizia entrata e incominciata dalla vita, mai cercata, nata perché ci si doveva incontrare. Non ho niente di più dolce nella mia vita e forse niente di più puro di queste amicizie. Nei momenti più difficili sono loro le più presenti in me anche con loro parole sapute dire, giuste: parole che so accettare.
Ero ragazzo, adolescente, poco più che adolescente e lei era donna, sempre donna: così ho incontrato la mia prima amicizia femminile. Con gli anni cambiavo: da seminarista a chierico a giovane prete. Ci si incontrava quasi una volta all'anno e l'incontro era che tutto poteva cambiare ma non la purezza dei nostri incontri. Non permettevamo mai che cambiassero ed era facile. Non sapevo niente e troppo poco di lei al di là di ciò vedevo nei suoi occhi veramente profondi: anche lucidi, velati però da una linea di tristezza. Il suo volto affilato dai zigomi marcati, i capelli tesi all'indietro e poi richiamati da una piccola frangia, il suo collo diafano, il suo corpo sottile e le mani anch'esse diafane potevano richiamare tutto ma non certo l'impurità. L'amicizia si, un'amicizia fatta di confidenze reciproche, di subitanea comprensione, di piccole delicatezze, di sacrifici accettati e di un marchio su tutti e due: Dio e il dolore nella vita di tutte e due.
Mi era superiore in età di almeno dieci anni e questo permise a me di non avvicinarmi a lei con paura e allo stesso tempo l'avermi conosciuto in età di adolescenza, solo un po' più grande dei ragazzi che le erano affidati disarmava anche lei. E in questo nostro disarmo stava la difesa. E ci fu vera amicizia come c’è ancora anche se resto anni senza vederla. Lontano da lei certo il ricordo si fa più nostalgico, più vivo ma la sua presenza diventa più profonda e le rare lettere non hanno mai una parola di più. Questa amicizia non mi ha mai impedito di vivere d'amore, d'amore universale che si personalizza per ogni individuo di questa terra, per ogni faccia d'uomo che mi rappresenta il Cristo.
Diverso è il caso con... Lei non è un momento, nemmeno un problema, è una persona che ha cercato di entrare in me, che è entrata in me ad un certo punto perché tutti i muri che cercavo erano falsi. Classicamente ho vinto, sono fuggito, non l'ho più vista, sono scappato e lei è scomparsa. Chiudevo tutte le porte ad un essere in nome di un principio, di una regola, di una legge: il mio stato di prete mi chiedeva questo, non importa se condannavo una persona all'umiliazione. E difficile credere che anche il Signore mi chiedesse questa chiusura.
Essere ad un dato punto fatto segno d'amore, essere desiderato spiritualmente, volersi donare a me per farmi contento è una specie di ebbrezza e sapere di negarsi questo e negarselo non toglie niente a questa ebbrezza e a questa confusione. Ed in questa confusione lei è scomparsa. Adesso ho il sollievo di pensare che trovò una via di uscita. Ma chi dimentica il dolore che avevo e che diedi anche se involontariamente?!
Ecco perché il problema si fa mistero in me, un fatto personale che chiede però rovesciamento di posizioni nella Chiesa. Perché quel mio dramma è dramma di migliaia di altri.
Io non potrò mai giudicare un prete che lascia.
Devi accedere per poter commentare.