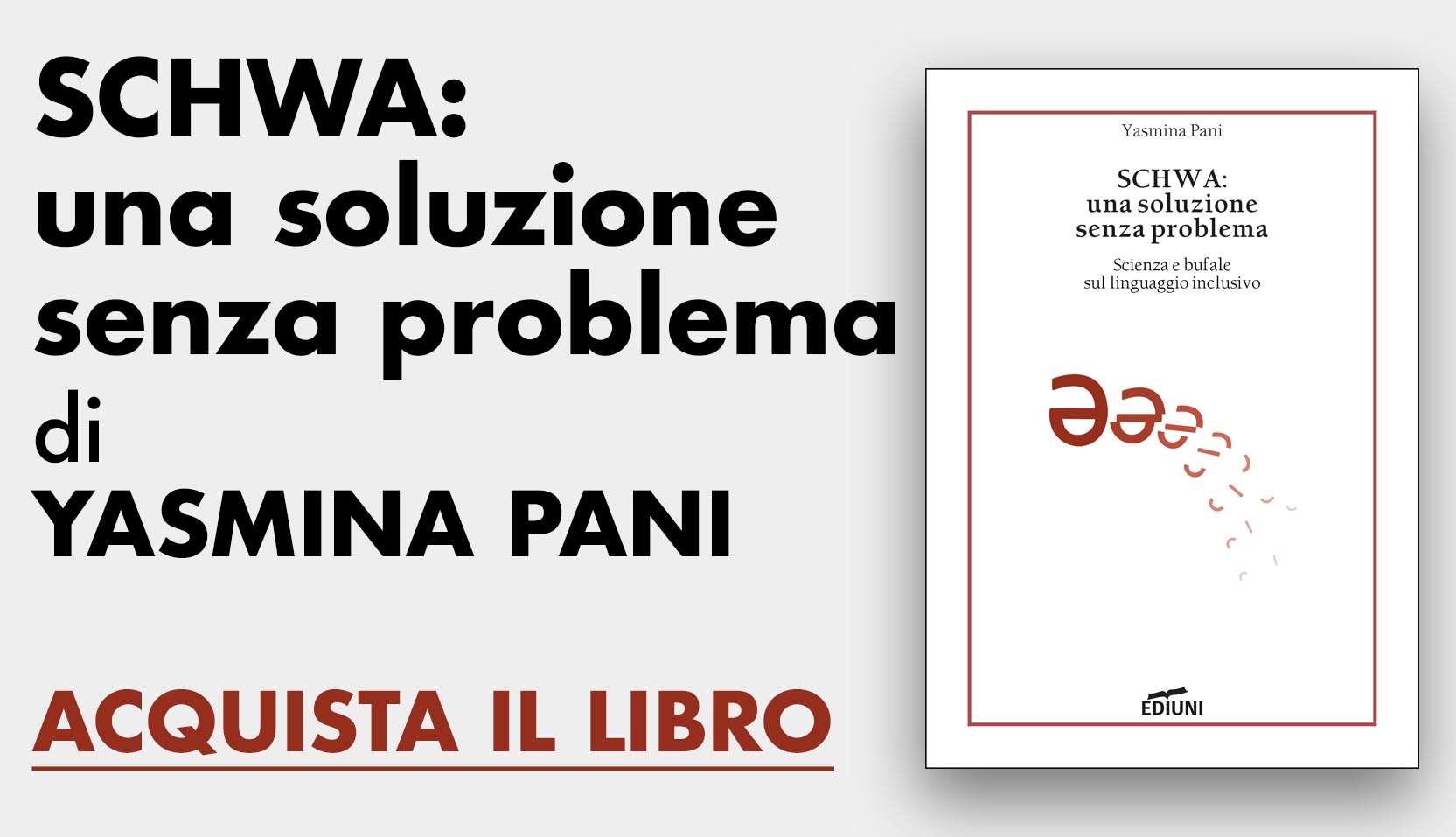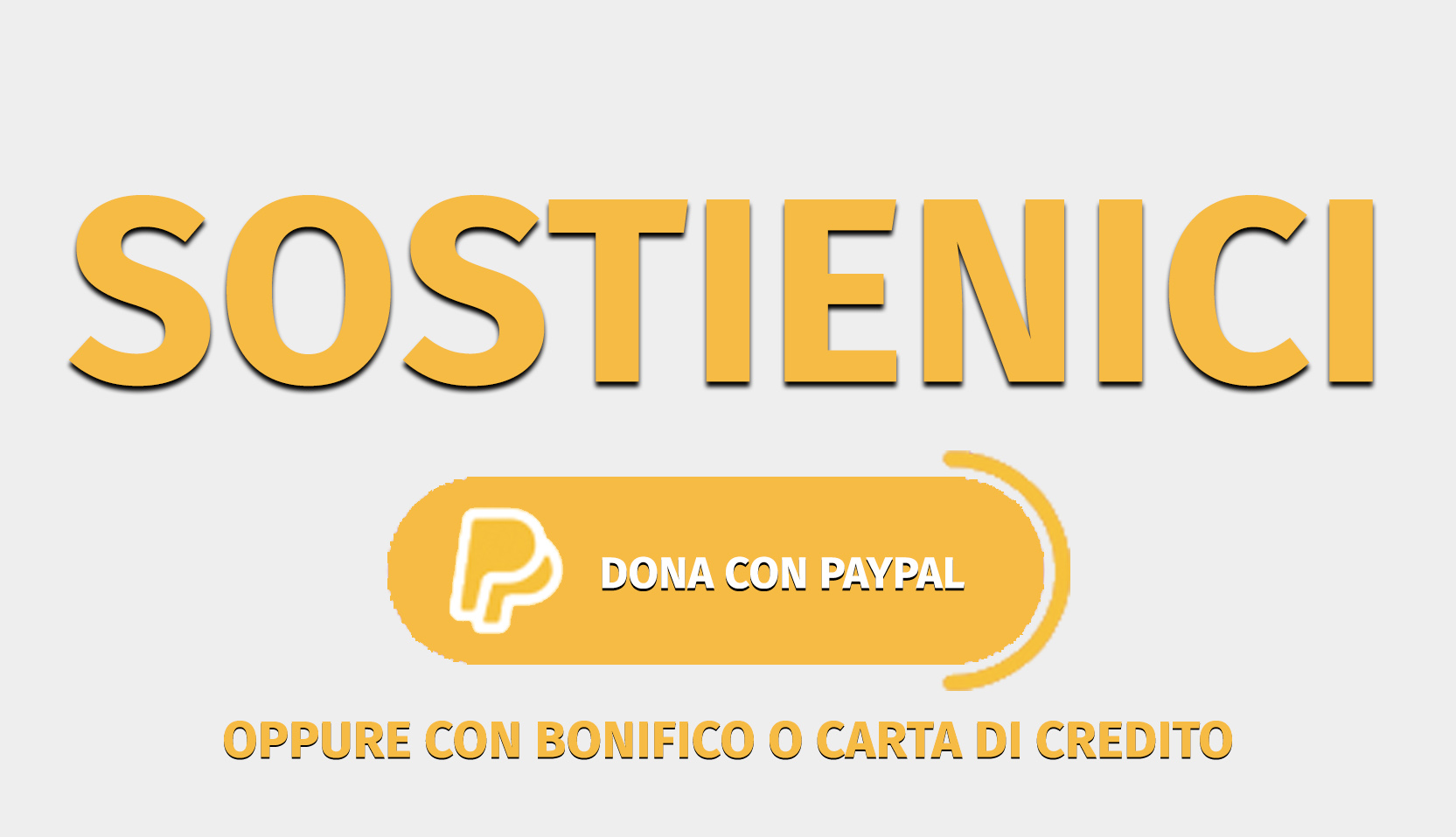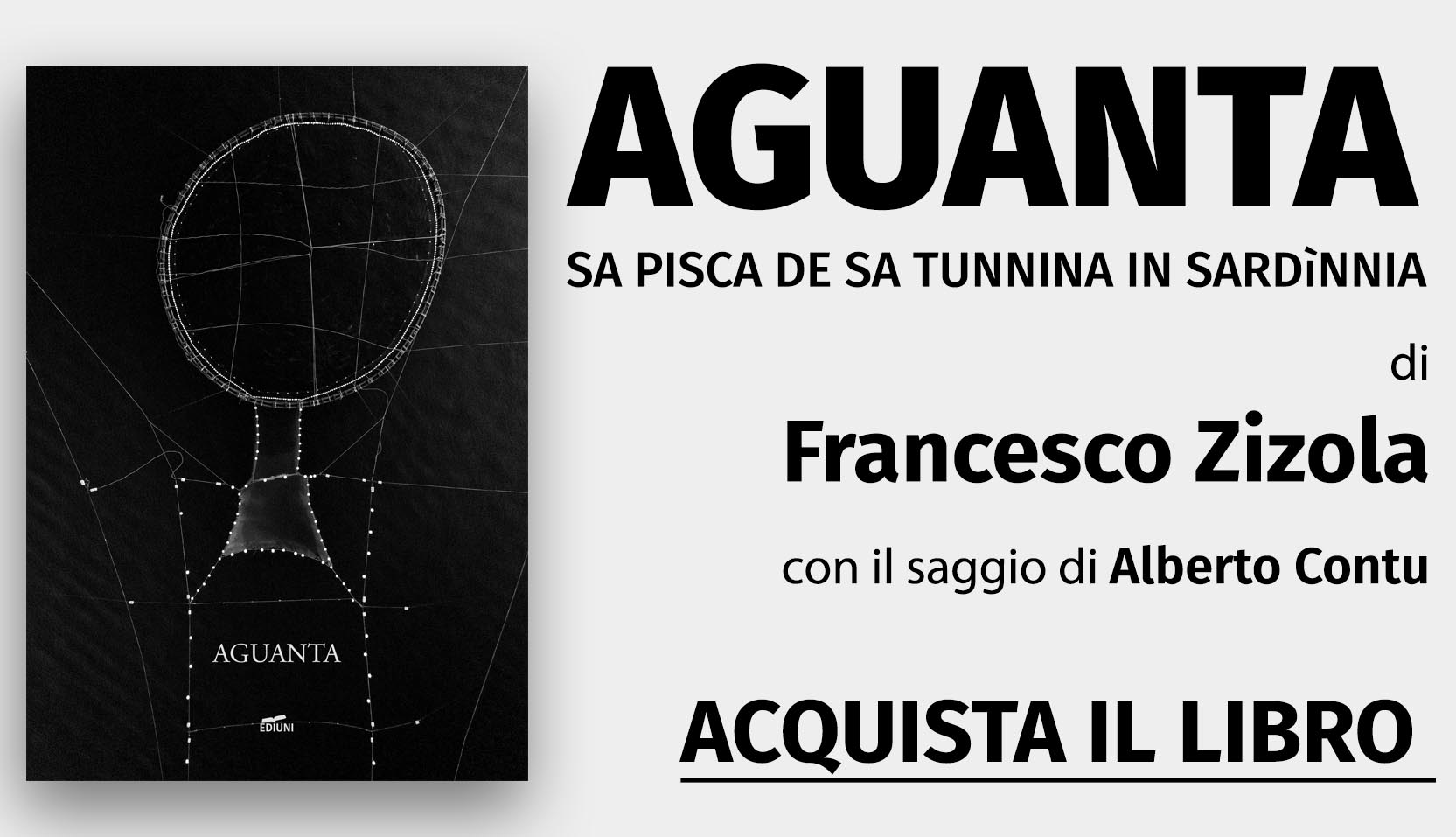Vita e morte di Aldo Molino, il fondatore del circolo “Giovane Sardegna” fra Mazzini e Lussu
di Gianfranco Murtas

Vivendo in via Gialeto con i miei, sovente, mi capitava di percorrere la stessa strada, specialmente al ritorno da scuola, con Aldo Molino, che abitava a pochi passi da me, in un alloggio acquistato con la buona uscita quando il padre fu collocato a riposo. Diventammo perciò presto molto amici con grande compiacimento di questo che, sempre attento a controllare le compagnie del figlio, considerava adatta e tranquilla la mia.
Per questo motivo ne assecondò subito l'intimità. Era un maresciallo dei CC. in pensione; alto, robusto, con larghi baffi che in servizio ne caratterizzarono, secondo la tradizione, l'austerità della funzione e che ora servivano anche, a dargli un tono di solennità per nascondere la bonarietà se, ribelle, osava sostituirsi al consueto volto burbero del carabiniere…
Era affezionatissimo al figlio nel quale aveva concentrato tutti gli scopi della sua vita e aspirava ora a realizzarne, con legittima ambizione, qualcuno, cosa che le vicende, più umili, della sua esistenza avevano per sé stesso ostacolato e perciò Io rendeva esageratamente così ligio ai doveri paterni…
Anche col figlio faceva il carabiniere: lo accompagnava, specialmente all'inizio, a scuola e lo veniva a prelevare, s'interessava del suo profitto e si accertava se questo si manteneva costantemente soddisfacente, sia direttamente sia attraverso frequenti incontri coi vari professori, ai quali spesso chiedeva anche di me, del quale, sapendomi allo stesso livello, era un pochino geloso, specialmente quando le quotazioni, oscillanti sui nostri due nomi, tendevano qualche rara volta, più decisamente sul mio. Ma gli bastava spronare, come probabilmente erasi abituato coi cavallini generosi durante il servizio, il volenteroso ragazzo, per ripristinare stabilmente la sfuggita superiorità.
Imponeva tanta soggezione anche a me, che pure ero abituato a mio padre che veniva rarissime volte a visitare i professori, dei quali neppure si curava di fare la conoscenza e quando gli portavo le pagelle da firmare si limitava a elogiarmi asciuttamente o a rimproverarmi acerbamente, a seconda dei casi, lasciandomi capire che in ogni modo dovevo essere io l'unico arbitro di me stesso rispetto al mio avvenire.
Talvolta mi indisponeva tanto era asfissiante quando, venuto a conoscenza di qualche mia monelleria, mi sgridava come avrebbe fatto col figlio dimenticando però che io non lo ero. Ma a ripensare ora a queste cose, riconosco quanto mi sia stata utile la pedanteria di quell'uomo e soprattutto l'intimità di quel caro mio compagno di scuola che, diventando, dopo mio padre, il mio modello, tanto peso ebbe in molte scelte decisive della mia vita.
Era un ragazzo intelligente, dal discorso facile, fluido e nel contempo serio e schivo dalla ciarlataneria, assennato più che l'età comportasse; sicuro di sé e del suo futuro, sicurezza che aveva comunicato anche a me, trasformatomi nel frattempo in suo emulo fedele. Persino alla foggia di vestire trasmetteva queste qualità del suo carattere: sempre impeccabile ma senza vanità, da grandicello col colletto duro, inamidato, chiuso da belle cravatte di moda ma serie, con modelli di giovanottino, quale appariva per la statura e per la barba mentre io, della stessa età ma ancor imberbe, continuavo ad indossare abiti alla marinara più confacenti alla mia statura e al mio aspetto di adolescente. Aveva grande cura delle unghie e non usciva, mai senza prima aver fatto la barba.
Quasi tutti i pomeriggi, alla fine della scuola, sin dall'inizio della nostra conoscenza, andavo a casa sua, dove rinchiusi per lunghe ore nella sua camera, studiavamo le lezioni e facevamo i compiti per il giorno successivo.
Ricordo che aveva una enorme lavagna che occupava quasi per intero una parete dove, per imprimerle meglio nella memoria, trascrivevamo in succinto e con largo uso di paragrafi le distinzioni e le suddivisioni delle regole o delle varie nozioni da studiare, metodo che, imparato da lui, mi si palesò di rapido profitto anche successivamente e non soltanto nel periodo studentesco.
Più tardi, a metà studio, se ne arrivava la mamma, una donnetta esile esile quasi trasparente con un vassoio voluminoso, dietro il quale scompariva il suo corpicino e ci serviva una squisita e abbondante merenda. Io mi sentivo mortificato di non essere in grado di ricambiare perché non avevo, come lui, una camera tutta per me. La dividevo con mio fratello mentre per studiare mi servivo dell'andito, stretto e corto, che dava l'accesso dall'anticamera al balcone sul giardino, nel quale con grande fatica era stato adattato un minuscolo tavolino con sgabello e, sopra, uno scaffale zeppo all'inverosimile di testi latini, di romanzi e dei libri, di vario contenuto, dell’intera famiglia…
Cagliari all’indomani della grande guerra
È Gustavo Piu che scrive. Magistrato ormai, dopo 44 anni di lavoro, andato in quiescenza egli racconta della sua vita, della famiglia e della scuola nella sua prima età, degli amici… Pubblicherà nel 1977 un primo di due libri di memorie, questo Sardegna di ieri (e nel sottotitolo, appunto, un semplicissimo Nel racconto di un magistrato) edito da Fossataro. A seguire sarà Piemonte d’altri tempi nella vita d’un magistrato. E sembra qui di cogliere come un’eco del viaggio di vita e anche letterario, per i titoli da lui pubblicati, compiuto da Efisio Bacaredda o Emilio Bonfis (in arte scrittoria), il papà del grande Ottone…
Fratello (di secondo letto) del celeberrimo monsignor Mario Piu, per quasi mezzo secolo presidente della Collegiata di Sant’Anna, a Cagliari, l’autore – fornito, beato lui, di una meravigliosa memoria – ricostruisce anche nel dettaglio situazioni lontane o lontanissime e profili umani di quanti entrarono nelle sue confidenze anche di bambino e ragazzo, di studente ginnasiale al Siotto Pintor (ancora a Castello) e liceale al Dettori (ancora alla Marina, vigilato dall’erma di Dante Alighieri).
Fra le amicizie adolescenziali quella con Aldo Molino fu senz’altro, in quelle stagioni così formative, la più incisiva. Con lui fondò il circolo “Giovane Sardegna”, nell’estate 1921, che riuniva studenti in parte già universitari di simpatie sardiste. S’intende: del sardismo di Emilio Lussu capitano reduce ed eroe della Brigata Sassari, del sardismo degli albori, in quel primo dopoguerra, che la battaglia per l’autonomia regionale (allora si diceva soltanto amministrativa) della Sardegna sapeva e voleva condurla con pura coscienza italiana, senza equivoci di sorta. E che, nell’andare delle settimane e dei mesi, quando dunque cominciarono ad affacciarsi sulla scena anche cagliaritana le squadre violente del fascismo, seppe connotarsi, mazzinianamente, in termini di democrazia repubblicana.
Fu redattore volontario al quotidiano “Il Solco” – l’organo del PSd’A la cui sede fu violata e violentata, incendiata, una prima volta nel novembre 1922 (pressoché in coincidenza con l’assassinio scellerato di Efisio Melis) dai quanti ancora festeggiavano Mussolini nuovo presidente del Consiglio dei ministri.
Matricola di giurisprudenza, proprio alla vigilia dei primi appelli all’università, Aldo Molino s’ammalò e nel giro di pochi giorni morì.
Negli scorsi mesi mi sono appassionato alla sua vicenda di vita tanto ricca e generosa quanto sfortunata, in quella Cagliari che pativa tutte le complicazioni della smobilitazione, gli affanni del carovita e della mancanza degli alloggi, il gioco pesante degli opportunisti che rivendicavano, con arroganza, un posto d’onore alla propria insipienza prodromica di una dittatura che sarebbe durata vent’anni portando la patria ad una nuova e disonorante guerra…
Ho cercato di restituire ad Aldo la sua voce, come a volergli assicurare che, dopo cento e tre anni dalla sua scomparsa, v’è ancora chi pensa a lui, alla sua virtuosa e giovanile partecipazione alle faticose vicende cagliaritane del primo Novecento…
Sardisti repubblicani, dettorini, matricole universitarie e sportive
Noi del circolo “Giovane Sardegna” avevamo adottato da qualche tempo, su mia proposta condivisa da Gustavo Piu e Peppino Prosperi, una nostra divisa, come ho accennato prima: la camicia grigia con il distintivo dei quattro mori sul taschino di sinistra. Al colletto un fiocco nero, piuttosto abbondante… Vi sono numerose fotografie che presentano i nostri militanti così abbigliati… I nostri fratelli repubblicani come Cesare Pintus o Silvio Mastio o Taberlet – Amedeo, se ricordo bene, poi emigrato per antifascismo in Francia – mettevano, nelle pubbliche manifestazioni o, organizzati in squadre d’azione, nelle sgradevoli circostanze dello scontro politico e anche fisico con gli avversari, la loro camicia rossa di eredità garibaldina, i fascisti quella nera e bruna i nazionalisti.
Avevamo anche inventato una forma di saluto tutta nostra, lo chiamavamo «saluto di partito», distinguendolo da quello comunista e da quello fascista: consisteva nel piegare il braccio destro per portare la mano sul cuore. Molto semplice e molto significativo.
Presentandoci così individuabili, tanto più per la camicia, subimmo più e più volte gli attacchi degli avversari e anche della forza pubblica. La casistica è enorme, e nel novero resta l’episodio del fermo di Alberto Frau che era in prima liceale e doveva presentarsi il giorno dopo a dare l’esame di riparazione per l’ammissione alla seconda. Il fermo in caserma di tutta una notte e della mattina seguente gli bruciò l’occasione. E perse l’anno costringendolo a recuperare in seguito. Fortunatamente recuperò riuscendo ad immatricolarsi l’anno successivo al mio e a diventare un ottimo medico.
A molti parve allora – e fu un errore grossolano – che la natura degli ideali nostri, originariamente segnati dal patriottismo che ben potevano vantare i reduci e ben potevamo vantare noi giovani che stavamo loro vicini, vicinissimi anzi, si fosse corrotta, quasi… bolscevizzata cammin facendo. No, la distanza dal classismo comunista era e restava grandissima, in condivisione con i comunisti avevamo la lotta al fascismo che iniziava ad alzare la testa aggressivo, dico il fascismo il quale, ogni giorno di più, si mostrava, oltre che rozzo e arrogante, anche violento.
…
Nella scuola, ovviamente, si trovavano – a livello di docenti – personalità molto diverse per orientamento culturale o politico oltreché per temperamento didattico: c’erano democratici e c’erano nazionalisti, c’erano liberali e c’erano cattolici. A vincere su tutti c’erano i bidelli – loro sì una istituzione inamovibile, mentre i professori andavano e venivano per cattedre di tutt’Italia, con poche eccezioni – Scirè, Mundula ed Ancis, il quale ultimo era anche il portinaio sempre complice dei ritardatari che non avrebbero potuto essere ammessi alle lezioni. Più severo invece, forse per ossequio esasperato all’autorità del preside, di lui facendosi l’ombra, era il bidello capo Scirè, che dava il cambio delle lezioni al posto dell’orologio o della campanella.
Il preside era allora il professor Giulio Cesare Bernardi, cui successe nel 1919 il professor Giovanni Battista Marchesa Rossi. Dirò questo: che il professor Bernardi era stato incaricato della direzione del Dettori nel 1916, dopo la rimozione del preside Leonardo Bruni, che era in carica da sei o sette anni. Il ministero ritenne non si fosse mostrato all’altezza del compito quando, nel febbraio 1916, era esploso il “caso Algranati”: quello di un giovane professore di fisica, livornese di radici ebraiche, massone attivissimo in una delle logge cagliaritane, la Karales, che si suicidò avvelenandosi nel laboratorio di fisica del liceo stesso. Ne vennero una ispezione ministeriale e due interrogazioni parlamentari. Fu un momento molto brutto per il Dettori e la memoria di questo dramma restò nel tempo…
Il professor Bernardi era un umanista preparatissimo e il suo successore Marchesa Rossi, che restò a Cagliari anche lui per cinque anni o sei, non gli era però da meno: più sul versante filosofico che non filologico però…
Il corpo docente era di fatto corrispondente alla sua fama che superava il Tirreno. Quello era già il tempo dei Parolisi e dei Nucciotti, degli Azzolina naturalmente… E della loro statura, come di quella dei loro colleghi, fra corso e corso, belle testimonianze sono venute nel tempo. Io, per quanto riguarda me e i miei tempi, rimanderei alle gustosissime pagine di… Gustavo Piu, il fratellino impertinente, ma generosissimo, di quel monsignor Mario Piu che fu per quasi cinquant’anni presidente parroco della collegiata di Sant’Anna e, da giovanissimo sacerdote, colui che favorì l’insediamento dei salesiani a Cagliari.
Fra i tanti che hanno scritto della loro esperienza dettorina nei miei stessi anni citerei adesso, per prossimità ideale, Cesare Pintus che fu una bella figura di mazziniano già dall’adolescenza, antifascista imprigionato, sindaco di Cagliari nel secondo dopoguerra. Egli quella sua esperienza scolastica la evocò dicendo di sé e del suo “fratello” Silvio Mastio, altra meravigliosa creatura con cui ebbi qualche scambio: erano del 1901, Cesare Pintus e Silvio Mastio, avevano soltanto due anni più di me. «L’ingresso nel liceo, in piena guerra europea, segnò la fine della nostra spensieratezza – scrive Pintus in un articolo del 1946 uscito sulla rivista “Il Convegno” –. Quanto avveniva nel mondo era un fatto di sì grande portata storica che anche noi, giovanissimi, fummo presi dalla politica e sentimmo il bisogno di approfondire sui libri le nostre conoscenze scolastiche…». Egli, con Silvio, accedeva al liceo proprio quando l’Italia entrava in guerra, a me e al mio amico Gustavo questo capitava quando, invece, finalmente l’Italia usciva dalla guerra, ma entrava in una epoca quasi altrettanto tremenda, con il malessere sociale diffuso dal quale sarebbe venuta poi la dittatura.
Certamente, l’età di noi studenti era quella, eravamo ragazzi e vivevamo anche la leggerezza dell’età, direi quella degli scherzi, delle furbizie per schivare i rischi di qualche interrogazione, di qualche compito in classe… e la leggerezza magari anche di qualche sport, degli esercizi atletici che già nella palestra dettorina del pian terreno ci restituivano il gusto del gioco. Però non potrei dire che la memoria della guerra e dei lutti sofferti dalla nazione e dalla città non fosse chiara e presente in noi sempre, perché essa era nelle nostre famiglie e nei conversari a tavola, nelle strade che cominciavano a riempirsi di nuove preoccupazioni e anche di nuove tensioni, presto anche di violenze stupide e volgari dei facinorosi…
…
Gli insegnamenti del primo anno – quelli da me frequentati – erano sei: introduzione alle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile, istituzioni di diritto romano, diritto costituzionale, economia politica, statistica e storia del diritto romano. I professori, dunque, erano Atzeri Vacca, Careddu, Marchi, Vinelli e Camboni. Le lezioni, dal lunedì al sabato, erano distribuite nelle varie fasce orarie, fra la prima e la tarda mattina, lasciando il vuoto nel mezzo, e il secondo pomeriggio. Capitava qualche chiamata (il venerdì e il sabato per statistica) addirittura alle otto, ma per il più la tabella degli orari imposti consentiva comodi varchi allo studio in aula o biblioteca, o a casa. Si trattava, per la precisione, di 25 ore settimanali complessivamente. Di curioso, se è possibile dirlo, è che ogni giornata era bloccata dalle 13 alle 14. Bisognava dunque che a casa Molino, se si fosse voluto pranzare tutti insieme, e compatibilmente con le esigenze degli altri, si aspettasse il mio rientro. Peraltro abitavo a cinque minuti soltanto dal palazzo universitario, pressoché la stessa distanza che separava casa mia dal Dettori e viceversa naturalmente: breve tragitto in discesa dalla via Università, passavo in via Mazzini, nelle due piazze Martiri e Costituzione. In risalita all’incontrario.
L’anno accademico 1921-1922 lo inaugurammo lunedì 21 novembre e l’indomani iniziammo le lezioni di statistica, di diritto costituzionale e, a fine mattinata, di istituzioni di diritto romano. Ero assiduo alle lezioni, credo di non averne saltato nessuna: disciplinato come sempre. Avevo studiato sodo e m’ero preparato agli esami che, purtroppo, non avrei potuto sostenere. Mi misi a letto ai primi di giugno per una fastidiosa influenza che però, ad un certo punto, mi parve di aver superato, tanto che avvertii tutti, e soprattutto i colleghi della redazione de “Il Solco”, che sarei tornato prestissimo… L’ultimo giorno di lezioni era fissato per il 16: sabato 17 cominciava la prima sessione degli esami. Io non feci in tempo a riprendermi: morii una settimana prima di quel 17, fu domenica 11. Ciao Cagliari, ciao università, ciao “Giovane Sardegna”, ciao amici sardisti de “Il Solco”, ciao onorevole Lussu, ciao Gustavo che mi hai voluto bene, ciao familiari miei tutti e ciascuno.
Ci ripenso, tutto avvenne con una accelerazione imprevedibile. Il giorno prima che me ne andassi, ricevetti la visita del mio Gustavo, che fu il primo a vedermi, dopo l’exit, come mai avrebbe voluto, disteso sul letto di morte. Nella notte il mio cuore non aveva retto a tanto stress accumulatosi dentro, mi trovarono rovesciato in avanti sulla sponda del letto. Restarono tutti ammutoliti in casa, la scena era inimmaginabile, ma pur si sarebbe ripetuta altre volte in casa, e invero già, ma in altre circostanze, s’era presentata.
Ricevendo Gustavo, abbracciandolo come per ridarsi la vita che aveva in sé spenta, mio padre fra un pianto convulso e mille singhiozzi, si sfogò in un pietoso monologo a me rivolto, gli occhi impietriti puntati sul mio povero corpo inerte. Dovevo rappresentare il futuro di vita di mio padre, e ogni suo sogno fu infranto.
…
Circa poi lo sport e il calcio in particolare, farei questo inquadramento generale. Doveva trattarsi di un torneo non soltanto giovanile ma anche scolastico. Il Cagliari FBC, costituitosi da due anni soltanto, mise a disposizione il suo campo negli stallaggi Meloni del viale Trieste. Il torneo “stretto” fra le squadre di 3.a categoria aveva compreso il Convitto Nazionale, il Dettori, gli Universitari e l’Istituto Tecnico. Nel 1921 la coppa – la coppa “Challenge” – era stata vinta dalla squadra del Convitto. Stavolta ci si allargò ad altre squadre chiamiamole politiche: quella dei giovani Esploratori Nazionali, quella del Battaglione Nazionalisti “Sempre Pronti” e quella nostra, del circolo “Giovane Sardegna” – noi con la maglia grigia delle migliori occasioni.
Riguardo ai nazionalisti ed a noi dovrei dire che la commissione dei giurati si prese qualche tempo perché era in dubbio se ammettere alcuni giocatori che venivano ritenuti troppo anziani – perché magari 25enni o giù di lì – per un torneo giovanile.
Si iniziò domenica 5 marzo, lo stesso giorno della nascita… lo posso dire? di un grande – sia nella letteratura che anche nel gioco del calcio – come è stato ed è Pier Paolo Pasolini. La nostra squadra se la dovette vedere con gli Esploratori Nazionali, in una partita che seguì quella fra la Scuola Tecnica e la Scuola Industriale.
Perdemmo di brutto contro gli Esploratori Nazionali, i migliori: perdemmo addirittura 4 a zero; gli stessi Esploratori sconfissero anche i Nazionalisti per 3 ad 1. Noi comunque ci rifacemmo, in ultimo, e molto bene, appunto contro il Battaglione Nazionalisti vincendo 3 a zero. Così fummo secondi alla fine del torneo: vincemmo una volta su due, perdemmo l’altra, segnammo tre goals e ne subimmo 4.
…
Bene educati dalle nostre famiglie e politicamente bene educati dai nostri dirigenti che sapevamo esemplari sia sotto il profilo intellettuale che sotto quello morale – soprattutto morale – noi certamente eravamo lontani da ogni propensione alla rissa e anche alla provocazione degli avversari, ma pure provocazioni e violenze avevamo cominciato a subirne sempre più di frequente. Gli ultimi mesi del 1922 gli episodi si fecero continui. L’onorevole Lussu non smetteva di raccomandarci prudenza, di non cadere nel tranello delle offese e delle sfide che ci venivano lanciate.
Ma davvero: come comportarsi davanti a provocazioni e violenze? La legittima difesa – lo dice la parola stessa – era legittima e direi anche doverosa, ma doverosa era anche la pazienza di cui ci si doveva munire per mai alimentare alcuna rissa, alcuno sterile scontro. Parve necessario, ad un certo punto, e ne ho già accennato, organizzarsi con delle squadre d’azione per rintuzzare ogni attacco cretino ma anche pericoloso. Sarebbe stata cosa più marcata, e più necessaria, poco più in là nel tempo. Per adesso l’invito era a stare in guardia, e si protestava per le gratuite offese.
Già il 2 settembre il direttivo della “Giovane Sardegna”, riunitosi in seduta straordinaria, aveva diffuso un suo documento che mi parrebbe importante evocare. Questo:
«Il Consiglio direttivo della Giovane Sardegna protestando vivamente per l’aggressione subita da un suo socio, dichiara di allontanare da sé ogni responsabilità per quello che potrà accadere in seguito al ripetersi di tali fatti.
«Nello stesso tempo ha diramato fra i soci la seguente circolare:
«“Il Consiglio direttivo dopo aver vivamente protestato a mezzo della stampa per la violenza cui fu fatto segno un nostro consocio, vi invita alla calma e soprattutto a evitare qualsiasi provocazione da parte vostra, ciò per il bene del nostro Partito, in un momento in cui avversari amanti della zuffa tendono a scaricare sugli altri la responsabilità di quello che altro non è se non conseguenza del proprio operato; per il bene della nostra Sardegna, ove noi, come la parte più sana e più intelligente dell’isola, dobbiamo impedire si ripeta quello che ha costernato le regioni consorelle. Che se poi l’avversario vorrà assolutamente la lotta, allora “Forza Paris!”».
Devi accedere per poter commentare.