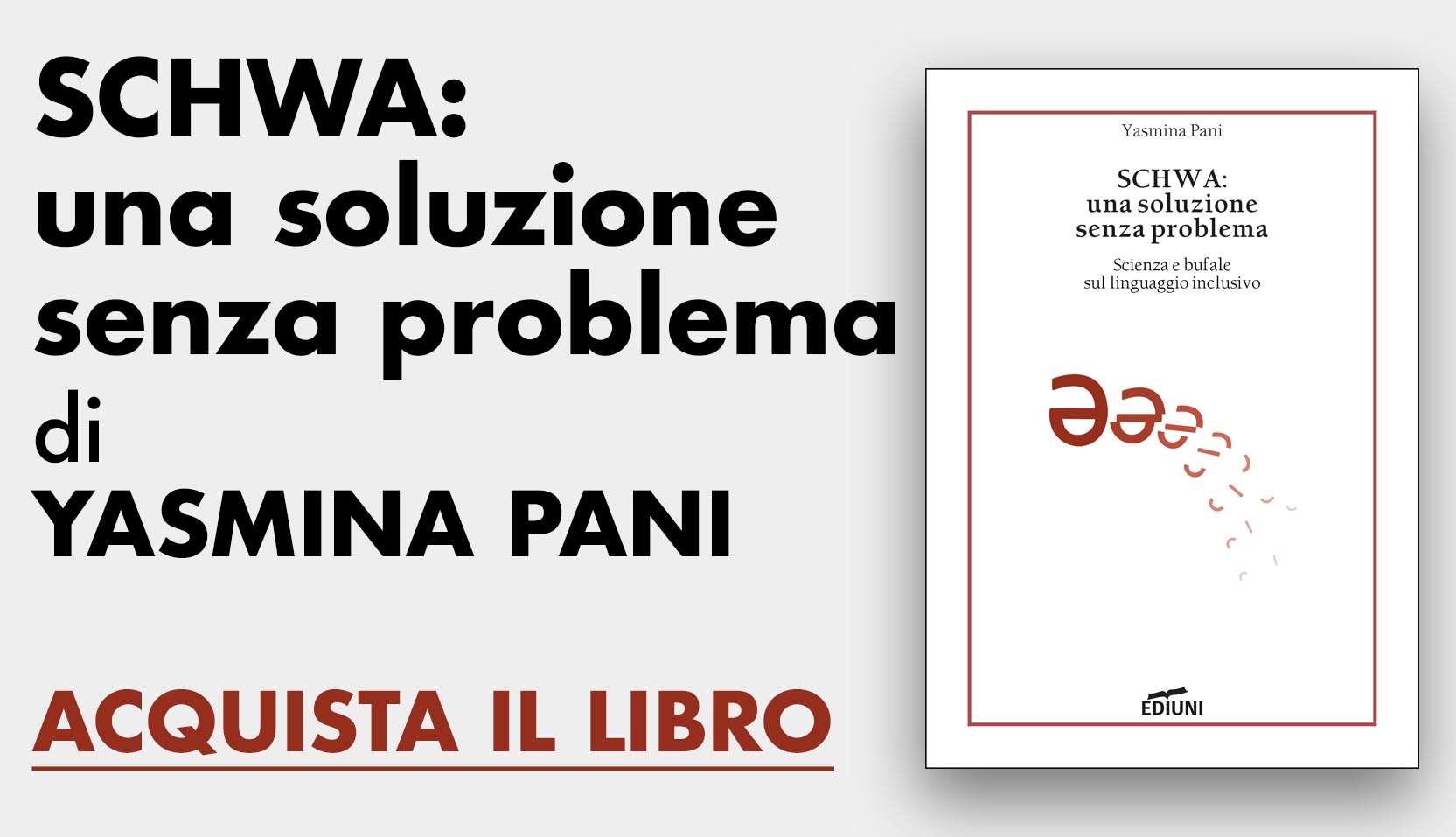“Giro Volante degli Stati Uniti”, maggio-giugno 1958. Firmato Fabio Maria Crivelli per L’Informatore del lunedì (e L’Unione Sarda)
di Gianfranco Murtas

«Vi prego di prendere il titolo di questa conversazione “Giro Volante degli Stati Uniti” in senso letterale. Perché d’un volo soprattutto si tratta, d’un lungo volo dall’Oceano Atlantico al Pacifico, attraverso buona parte dell’America, 22mila chilometri percorsi con un Convair, 26 giorni piuttosto intensi, con ricevimenti, visite d’obbligo, pranzi d’onore, che si prendevano buona parte della giornata. In complesso 80 ore di volo, e soste in dieci stati e in undici città fra grandi e piccole, oltre che in tre grandi basi aeree e in quella navale di Norfolk. Ma di queste non vi parlerò perché penso che di armi, di aerei, di missili ne leggete già abbastanza sui nostri giornali e piuttosto cercherò, imitando se possibile la rapidità con la quale il viaggio s’è svolto, di darvi qualcuna delle immagini che in un carosello così affannoso sono rimaste più in evidenza, immagini naturalmente più fotografiche e superficiali che complete ed esaurienti, e non potrebbe essere altrimenti…».
Così inizia la conversazione che Fabio Maria Crivelli, al tempo (e già da quattro anni, dal 1954) direttore de L’Unione Sarda, tiene al Rotary Club di Cagliari sul recente suo viaggio per gli Stati Uniti compiuto con una folta rappresentanza del giornalismo italiano (e non solo). Lo sbobinato viene poi pubblicato a tutta pagina su L’Informatore del lunedì il 9 giugno 1958. Titolo dell’articolo: “Il giro dell’America in ottanta ore di volo”, con occhiello “Impressioni di un viaggio attraverso gli Stati Uniti”.
Eccone, impressionistico ed insieme descrittivo, il testo completo che – unitamente alla ripresa di una serie di sue corrispondenze dal congresso nazionale socialista dell’ottobre 1963 (e due editoriali di appoggio) che conto di postare nei prossimi giorni – propongo alla pubblica lettura come omaggio straordinario alla grata, gratissima memoria dello storico direttore de L’Unione Sarda alla vigilia della data centenaria della sua nascita (11 gennaio 1921 / 2021) in quel di Capodistria.
All’indomani delle elezioni presidenziali che negli USA hanno portato alla elezione di Joe Biden e alla santa fuoriuscita di scena di Donald Trump, può forse rileggersi la lunga relazione rotariana di Fabio Maria Crivelli con lo spirito positivo di chi, pur rilevando infinite contraddizioni nella società americana, pure ne apprezza ed ammira le capacità di slancio e purificazione…
In quello stesso 1958 cui si riferisce il viaggio americano dei giornalisti è ambientato il film Loving, che mi è occorso di vedere recentemente trasmesso ida un qualche canale televisivo: un matrimonio interraziale (lui bianco, lei nera) impedito dalla legge dello stato della Virginia e sanzionato infatti da un algido tribunale penale (per evitare il carcere i due coniugi dovrebbero vivere per venticinque anni separati, e risiedere in stati diversi!), fino al ricorso – dopo inenarrabili umiliazioni e sofferenze – alla Suprema Corte federale e alla vittoria: la legge illiberale viene dichiarata incostituzionale. Senza purtroppo mai risolvere definitivamente, con la norma, il gap che può imprigionare certo spirito pubblico, come ancora si è visto in tempi recenti con i disordini e le violenze di segno razzista e le velleità suprematiste di taluno.
Ma aggiungo, riprendendo le conclusioni di Crivelli indagatore del “nuovo” continente, ancorché il suo viaggio sia avvenuto ora sono più di sessant’anni fa. L’Europa non ha da sfigurare e non meriterebbe – per le infinite sedimentazioni e interrelazioni delle sue culture nazionali, fra arte e letteratura, musica, pittura e filosofia – nessun aggettivo penalizzante rispetto al “nuovismo” americano. In realtà – per quello che si è saputo, scrive il direttore – «gli americani sono avanti all’Europa solo in fatto di comodità materiali, ma come spirito e come sistema di vita sono indietro a noi di almeno due secoli, vivono ancora fermi sulle idee del secolo diciottesimo… L’insegnamento, la morale, la religione, le scienze qui sono tutte in funzione di una unica dominante concezione: quella che stabilisce che l’uomo ha per scopo fondamentale della vita la felicità terrena; e di conseguenza … ogni sforzo è teso in questa unica direzione».
Aggiunge Crivelli (e forse l’eco dei trattati di Roma del 1957, che impostano l’Unione Europea ha la sua parte): «perché chiamare vecchia e magari decrepita quest’Europa che dimostra ancora la sua capacità di rinnovamento continuo, la sua capacità di trovare ancora soluzioni nuove a nuovi problemi? … Sapere che per qualche secolo almeno la nostra Europa ha ancora una funzione ben precisa e insostituibile rispetto a questo gigantesco mondo, nuovo solo in apparenza e nei contorni materiali, mi pare importante; assai più importante della visione dei missili visti a Cape Canaveral e della visita alle fabbriche Douglas, dove migliaia di operai lavorano otto ore a ritmo febbrile soprattutto per pagarsi la rata della comoda automobile che li aspetta all’uscita».
Battute che riportano equilibrio fra prefigurazioni e sentimenti opposti, tutti legittimi e tutti segnati da parzialità. Importante però anche questo, pensando alla malapianta del sovranismo demagogico che s’affaccia sgangherato da noi, arrivando a rovesciare di segno le tradizioni più belle (e nel minimo, davvero nel minimo, e per restare alla logica di secolo compiuto, penso adesso al sardismo fattosi pagano, destrorso e leghista… che pena!).

Impressioni di un viaggio
A Washington si respira aria di provincia – Ventimila case nuove per i poveri di Filadelfia – Fiori senza profumo nell’impero dei Du Pont – «In questo paese potete comprare una bomba atomica, se avete denaro – Ma se perdete un bottone siete un uomo finito» – All’avanguardia del progresso tecnico, l’America riceve dall’Europa ogni soffio di vita spirituale
Ripensandoci mi sembra davvero d’aver visto l’America dall’alto, dall’aereo, e se penso al Texas, per esempio, rivedo un’immensa distesa di terra giallo-nera e poi una foresta di luci, al momento dell’atterraggio, ed è El Paso che mi viene incontro…
Un caleidoscopio d’immagini, insomma, un groviglio d’impressioni fuggenti, confuse, contraddittorie. Ho cercato di legarle ad un unico filo di curiosità, ed appena ho potuto ho cercato di rispondere ad una sola domanda. Come vive l’uomo medio americano, cosa pensa, cosa sogna, è felice, è diverso da noi, perché lo è?
x x x
A Washington, la prima città visitata, l’incontro con il tipico uomo medio americano è stato difficile. In realtà Washington è poco America, come per altri versi lo è poco, anzi addirittura pochissimo, New York. La capitale degli Stati uniti è una città sui generis; ha un milione d’abitanti ma è città di provincia, sotto molti aspetti, assai più di quanto lo sia Cagliari. Soprattutto è una città artificiale, nata a freddo, disegnata per esser quella che è oggi quando aveva meno di diecimila abitanti. Così non è il tempo, non le necessità, non gli eventi o le mode che l’hanno a poco a poco determinata come accade a tutte le altre città del mondo. Un architetto francese che era anche militare e che si chiamava L’Enfant ne ha fatto la pianta centocinquant’anni fa in base ad un unico e ben preciso criterio: che tutte le strade avessero l’uguale larghezza di trentatre metri e la avenue cinquanta metri, che tutte fossero rettilinee e alberate, che i grandi monumenti in stile neoclassico sorgessero nei grandi spiazzi al centro dell’enorme rettangolo, e che nessun edificio potesse superare in altezza la cupola del Campidoglio, cioè l’altezza di una nostra normale casa di tre piani. Il risultato è la Washington di oggi: un’enorme distesa di case tutte uguali, strade in cui non esistono pedoni, giardini che sono tante copie di un unico infantile acquarello, negozi sbiaditi e senza fantasia, comode linee di tram silenziosi e un’aria di noia, di scarsa vita intellettuale, senza tumulti, senza passioni, l’immagine della burocrazia che la popola, gente che dei numeri, dell’ordine, della precisione più che una scienza ne fa una religione. Un solo dato: a Washington non esiste un teatro di prosa, rarissime sono le rappresentazioni d’opera, ancora più rari i concerti. La città oggi conta fra i suoi abitanti una metà tutta negra; ma fra negri e bianchi è ben poca la differenza. Abitano negli stessi tipi di villette, si servono negli stessi negozi tutti uguali, adoperano le stesse macchine, vanno agli stessi cinema in cui si proiettano film già proiettati un mese prima a Cagliari.
Il tipo dell’uomo medio a Washington penso non sia rappresentativo: è un funzionario di ministero, un dipendente della Casa Bianca, un impiegato del Pentagono. E’ un burocrate e i burocrati si rassomigliano in tutto il mondo; qui sono meglio pagati, ma in ogni caso sono sempre negli scalini più bassi del reddito, e in definitiva sono un’eccezione rispetto alla massa degli americani che pone la caccia al dollaro al primo posto nella scala dei propri desideri e delle proprie esigenze.
x x x
Fra Washinton e Filadelfia c’è meno di un’ora di aereo; ma è già tutto un altro mondo. Oggi la capitale della Pennsylvania attraversa un momento particolare e non è, esteticamente, un bello spettacolo a vedersi. Filadelfia è una città distesa su un’enorme tavola operatoria e la stanno sventrando. Letteralmente. In base ad un piano approvato anni fa gran parte della vecchia città sta scomparendo, giorno per giorno, ora per ora quasi; cadono a ritmo incessante gli agglomerati urbani abitati prevalentemente da negri, casette in legno fetide, antiigieniche, molto peggio forse dei sottani del Castello o di Via Garibaldi; e a pochi metri di distanza dai buchi che le escavatrici hanno aperto sorgono i nuovi quartieri: e blocchi di casette ad un piano con una parvenza di giardinetto e alveari di dietri piani con grandi cortili dove ci sono locali di ricreazione per i bambini, i servizi essenziali, qualche alberello scheletrico. Non sono belle le nuove case, e gli appartamentini per le affollate famigliole negre non sono grandi. Ma c’è il bagno, la cucinetta con tutti i comfort, la radio, spesso anche la televisione; un piccolo paradiso in confronto ai tuguri che scompaiono. Il piano di ricostruzione di Filadelfia è basato su una combinazione finanziaria in cui il finanziamento dello Stato è la parte fondamentale ma ampiamente integrata dall’iniziativa privata. Le ventimila famiglie che hanno già dovuto sgombrare dagli slums abbattuti hanno avuto dal Municipio la somma occorrente per pagare l’anticipo della nuova casa; il resto lo pagheranno in vent’anni, in rate mensili che vanno, a seconda del tipo d’alloggio, dalle venti alle trentamila lire.
Una somma che gli abitanti dei tuguri nostrani non potrebbero davvero pagare; ma i poveri di Filadelfia lo possono, lavorando moglie e marito, mentre i bambini sono a scuola o, se ancora non vi vanno, restano affidati alle cure di assistenti sociali che sono dislocate nei vari centri delle piccole comunità create ogni due o tre blocchi di nuove case.
Lo sventramento e la ricostruzione di Filadelfia non interessano solo i negri e gli strati più bassi. Anche zone abitate da gente meglio retribuita stanno per scomparire; e per questa gente già sorgono nuove zone residenziali sulle colline che sovrastano la città. Qui si tratta di villette con giardini più grandi, in genere a due piani, con maggior spazio e maggiore comodità. Ho visitato una di queste villette, accolto da un certo sig. John Renzi, nato in America da genitori italiani. E’ impiegato in una delle ditte che lavorano nel piano di ricostruzione di Filadelfia, guadagna abbastanza bene da poter pagare sessantamila lire al mese per il riscatto ventennale della casa, ha una macchina comperata nuova quest’anno, tutti i comfort di modello più recente, una moglie di origine canadese e due bambini che non vanno ancora a scuola. Dopo avermi fatto visitare con orgoglio manifesto la casa nuovissima mi ha detto: «Credo che ci starò per cinque anni. Poi troverò qualcuno che mi subentri nel pagamento e mi trasferirò più a nord. Se gli affari vanno bene penso di potermi permettere due stanze in più e un giardino più grande. Naturalmente con quello che recupererò dal passaggio di proprietà qui potrò pagare la prima rata della casa più bella».
La casa più bella o la casa nuova. Come il nuovo modello di auto che chi può cambia ogni anno, e come il frigorifero o il televisore. E’ un aspetto della mentalità americana, soltanto un dettaglio.
A un’ora di pullman da Filadelfia c’è Wilmington, una città di ottantamila abitanti nello stato del Delaware, quello che è rappresentato dalla prima delle 49 stelle sulla bandiera degli Stati Uniti. A Wilmington tutto è Du Pont: Du Pont le enormi fabbriche di nylon, di plastica, di pellicole, di esplosivi, Du Pont l’albergo principale, Du Pont il maggior cinema cittadino. A Winterthur, una località dei dintorni, c’è perfino il Museo Du Pont dove, a pagamento, la gente va a vedere la storia di questa famiglia francese giunta qui un secolo e mezzo fa e dove, in mezzo a enormi distese alberate, sono ricostruite al naturale le prime piccole filande, i primi baracconi dove si fabbricava la polvere da sparo, con impiegati svizzeri e svedesi e operai indiani, spesso domati a colpi di moschetto. Vicino al museo c’è la residenza di uno degli attuali Du Pont, una specie di piccolo castello barocco, circondato da un enorme parco, ricco di serre le più perfette. Nel parco e nelle serre crescono le più svariate qualità di fiori, fiori stupendi, rari, di proporzioni talvolta inusitate. Ma non ho visto un fiore, uno solo, che avesse il benché minimo profumo, Senza odore le magnolie, senza odore i lillà, senza odore le rose. M’è venuto il dubbio che fossero di plastica. Plastica Du Pont, naturalmente.
Nella casa del signor Du Pont ho incontrato la prima e unica cameriera vista negli Stati Uniti; negra, naturalmente. E’ un aspetto noto della vita americana, questo. Si sa che le donne di servizio non esistono. Ma c’è qualcosa di più che manca: è il servizio stesso, o per il concetto che noi abbiamo del servizio. L’idea che qualcuno qui debba servire un altro è inammissibile. Il cliente che entra nel negozio si sceglie ciò che gli occorre da solo, poi prega un commesso che gli faccia il pacco e che gli dia lo scontrino per la cassa. Il “thank you” del cassiere è una pura formalità.
Al ristorante se non c’è il self service (cioè il vassoio che ognuno si riempie da loro passando davanti ai vari banchi) c’è l’addetto che vi porge una lista dove voi potrete scegliere fra i vari piatti numerati (e solo fra quelli) e che ha poi l’incarico non di servirvi ma di fare da tramite fra la cucina e il tavolo per darvi infine lo scontrino che porterete alla cassa. Nessun rapporto di confidenza, nessuna di quelle frasi cordiali o invitanti o quei consigli che sono il fraseggio d’obbligo d’ogni ristorante europeo.
La mancanza di questo concetto del servizio è soprattutto evidente negli alberghi. Quando avete ritirato la chiave della vostra stanza e trovato, con un po’ di fatica, qualcuno che vi trasporti il bagaglio in camera, i rapporti con il personale sono finiti. Voi potete restare anche un mese dentro quell’albergo e poi sparire senza che nessuno si preoccupi di voi, vi chieda qualcosa, si faccia in alcun modo vedere. Le iniziative devono eventualmente partire tutte da voi, ma sono anch’esse limitate. Potete tramite il telefono, far portare la biancheria ad una lavanderia o un vestito a far stirare, ma non altro. Camerieri e cameriere non esistono, voi siete da solo con i vostri piccoli problemi.
Il giornalista spagnolo del nostro gruppo commentava questa situazione con questa frase: «In esto pays usted puede buscar la bomba atomica se tiene el dinero suficiente. Ma se a usted tombe un boton usted es un hombre muerto!».
In realtà con un po’ di pazienza e di tempo penso sia possibile in ogni città trovare il negozio specializzato nell’attaccare bottoni: ma all’amico che si reca in America consiglio comunque, oltre allo studio dell’inglese, anche lo studio dell’arte di attaccarsi i bottoni e di eseguire qualche rammendo di emergenza. Non c’è tuttavia bisogno di portare con sé l’occorrente per cucire: lo troverà nella stanza di ogni albergo, nel cassetto in cui c’è sempre carta per scrivere, l’elenco telefonico, qualche scatola di fiammiferi e la Bibbia.
x x x
La Bibbia mi suggerisce due rapide righe sulla religione. Ho visitato a Washington, a New York, a Los Angeles, qualche chiesa protestante e qualche chiesa cattolica. Mi hanno colpito i frequentatori delle seconde: uomini e donne qui li ho visti sempre compostamente inginocchiati, li ho visti profondamente genuflettersi e segnarsi all’uscita e all’entrata. Non ho mai visto persone in piedi o sedute. Ho avuto l’impressione che sentissero la religione in modo più totale, più profondo, più convinto di quanto accada da noi. Diversa impressione ho avuto nelle chiese protestanti, dove la religione mi è parsa avere aspetti più convenzionali, molto legati a funzioni sociali e rappresentative, e dove la numerosa varietà di sette mi fa pensare sia più in funzione di tradizioni, di interessi sociali o di origine che di vera convinzione interiore. Ciò non toglie che la vita americana, specie quella degli stati interni e delle città più piccole, sia ancora profondamente influenzata dal protestantesimo, e dove la intransigenza puritana ha lascito solchi profondi e usanze che più marcatamente costituiscono la differenza di mentalità fra americani ed europei non anglosassoni.
x x x
A Lincoln, capitale del Nebraska, una città di centotrentamila abitanti che io considero il modello delle città medie americane, abbiamo avuto una giornata singolare.
In mattinata abbiamo visitato il penitenziario di stato. E’ una di quelle tipiche carceri modello americane che abbiamo visto tante volte nei film. Tutto è lucido, tutto ordinato, tutto regolato da meccanismi elettrici. I cancelli si aprono a comando, le enormi gabbie sono rigorosamente numerate, i detenuti non pericolosi lavorano in ampi stanzoni, dormono in spaziose camerate, giocano a calcio, si godono in alcune ore la radio e la televisione. I ribelli o i pericolosi sono invece segregati in cellette di due metri per due, dove non possono far altro che star seduti o dormire. Noi abbiamo mangiato nel refettorio comune, al tavolo nel centro, con il solerte direttore del penitenziario, la moglie e la figlia.
Nei tavoli tutto attorno mangiavano in silenzio, lo stesso nostro cibo, i detenuti. A metà pranzo un’orchestrina di carcerati, quasi tutti negri, attaccò una serie di frenetici pezzi jazz. Io pensavo alle carceri storiche: allo Spielberg di Silvio Pellico, al fetido carcere napoletano dal quale però Settembrini guardava il golfo di Napoli. Qui dalle finestre sbarrate si vedevano solo le torrette delle sentinelle armate di mitra, e lontani, oltre la serie di cancelli percorsi dalla corrente ad alta tensione degli uccelli liberi in una fetta grigia di cielo.
La sera abbiamo invece assistito, nell’Auditorium di Lincoln, all’elezione di Miss Nebraska. Dodici ragazze che si rassomigliavano un po’ tutte, che camminavano allo stesso modo, che sorridevano allo stesso modo, sono sfilate sulla passerella, fra l’attenzione molto distaccata piena di serietà del pubblico, prima in abito da sera e poi in costume da bagno. Alla fine hanno sostenuto la cosiddetta prova di talento: chi ha suonato il piano, chi la tromba, chi ha recitato una poesia, chi ha eseguito una danza. L’interesse del pubblico non aveva nulla di ironico o di sottinteso: si trattava d’una faccenda maledettamente seria, la vincitrice avrebbe rappresentato il Nebraska nell’elezione di Miss America, c’erano in ballo migliaia e migliaia di dollari.
Che cosa significhi Miss America c’era lì quella dell’anno scorso a ricordarlo, un’autentica regina, una ragazza che si è assicurata un avvenire. Alla fine fu eletta Miss Omaha, e la biondina longilinea era raggiante, si sentiva che per quel traguardo aveva sofferto e sperato intensamente; molte delle sconfitte piangevano senza nascondersi.
Guardando Miss Nebraska ’58 mi venne fatto di ricordare che nel carcere visitato al mattino c’era, in una cella d’isolamento, quel diciannovenne che proprio a Lincoln aveva fatto fuori undici persone, dichiarando al momento dell’arresto: «Volevo essere qualcuno». Bene; non c’era forse un sottilissimo filo psicologico a legare la gentile e sorridente vincitrice al mostro che andrà presto sulla sedia elettrica? In un paese in cui la caccia alla ricchezza è pensiero quotidiano, principale, assillante, di ogni uomo e di ogni donna, anche questi due, in maniera assolutamente diversa, cercavano qualcosa, ma qualcosa di più degli altri; tutti e due volevano essere qualcuno.
x x x
Non sono neanche alla metà del viaggio e dovrei parlarvi di Los Angeles, di Hollywood, di New York, la metropoli che forse è più Europa che America, ma dove certi aspetti dell’America raggiungono il loro vertice, dove tante avventure dell’uomo americano principiano o finiscono. New York che rappresenta un po’ il paradiso e un po’ potrebbe essere il resto degli Stati Uniti.
E c’è sempre senza risposta la domanda che più mi incuriosiva, quella sull’uomo medio americano. Bene, finirò raccontando l’incontro con Vincent Collura, un figlio di siciliani del quale sono stato ospite a Lincoln, una domenica.
Vincent Collura è nato a Chicago trentasei anni fa; suo padre si trasferì in America da Patti, Sicilia, nel 1912. Il vecchio siciliano ha fatto il muratore, il guardiano notturno, poi il magazziniere; ha tirato su cinque figli, li ha fatti studiare, ora sono tutti sistemati. Il figlio Vincent a Lincoln si occupa di rappresentanze per forniture d’ufficio, guadagna seicento dollari al mese circa, ha una bella casetta a venti chilometri dal centro, una moglie figlia di tedeschi, quattro bambini piccoli. La casa è costruita allo stesso modo delle altre 199 che formano il piccolo centro, ammobiliata nell’identico stile, ha un giardinetto del tutto identico a quelli adiacenti. Il signor Collura ha due macchine: una con la quale gira per lavoro, l’altra per portare a spasso la famiglia la domenica. Parla ancora qualche parola di siciliano ma è americano e si sente americano. Mi ha mostrato la casa con visibile orgoglio, ha voluto che ammirassi un armadio a muro che ha costruito da sé nelle ore libere, lavora dalla mattina alle sette alle sei di sera. Poi resta in casa a vedersi la televisione con la moglie e i bambini. Ha due grandi desideri: poter essere ammesso al Country Club, cioè al circolo campestre della zona, e poter fare con la famigliola un lungo viaggio che comprenda la visita alle cascate del Niagara. Dell’Italia e dell’Europa in genere ha un’immagine molto vaga, dei problemi del mondo cognizioni piuttosto scarne. «Devo pensare soprattutto al lavoro - mi ha detto: la mia famiglia è il mio mondo». Tuttavia è d’accordo con Eisenhower e con i capi del Pentagono sul fatto che l’America non deve badare a spese nell’armarsi anche se questo richiede forti tasse ai cittadini; «i russi non ci attaccheranno mai fin quando noi saremo più forti».
Durante il pranzo ha però preferito parlare di cucina, della scuola che stanno costruendo nella zona e dove manderà i due bambini più grandi. Poi della macchina che spera poter comperare l’anno prossimo e di quelle di cui aveva letto la réclame la mattina sul giornale. La moglie s’interessava un po’ più dell’Europa, forse preferirebbe al viaggio alle cascate, una visita all’Italia e alla Germania, anche se non ricorda più in quale parte di questo paese siano nati i suoi genitori. Ma un viaggio in Europa rappresenta una cifra proibita per noi, ha detto il marito. A meno che… A meno che… Ho capito poi che la speranza molto esile era tutta basata sulla morte prematura di un collega quarantacinquenne che precede nella graduatoria della ditta il signor Collura e il cui posto rappresenta circa il doppio dello stipendio.
Naturalmente durante la conversazione io pensavo, inevitabilmente, a Babbitt e a Miller con la sua “Morte di un commesso viaggiatore”. Pensavo al tragico personaggio di George, l’umo che lavora tutta la vita per pagare le rate della casa, della macchina, del frigorifero, e che correndo di qua e di là pensa ai momenti di pace da trascorrere sotto l’alberello davanti alla casa... Ma quando il discorso con il signor Collura passò brevemente sui libri scoprii con sollievo che fra i tanti che egli non aveva mai letto c’erano tutti quelli di Sinclair Lewis e che, in quanto ai lavori di Miller, la “Morte di un commesso viaggiatore” egli non l’aveva visto neanche al cinema. Ne fui felice per lui.
Concludo. Mi pare che se non ad altro questo viaggio mi sia servito per chiarire a me stesso almeno un paio di concetti essenziali, e, soprattutto ad appurare la infondatezza di alcuni tra i più diffusi luoghi comuni sugli Stati uniti e sugli americani. E così, come ho scoperto che le città americane non sono davvero quelle enormi foreste di grattacieli che la gran parte degli europei immagina, ma sono invece tutte città orizzontali che sfruttano con ritmo sempre crescente la maggior ricchezza del paese, cioè lo spazio, credo di poter concludere sfatando un altro dei più diffusi miti americani: quello che dipinge gli Stati uniti come la nazione più giovane, all’avanguardia del progresso mondiale.
In realtà – per quello che si è saputo – gli americani sono avanti all’Europa solo in fatto di comodità materiali, ma come spirito e come sistema di vita sono indietro a noi di almeno due secoli, vivono ancora fermi sulle idee del secolo diciottesimo, la concezione che domina la loro vita è tutta impregnata delle idee care agli illuministi, agli enciclopedisti. L’insegnamento, la morale, la religione, le scienze qui sono tutte in funzione di una unica dominante concezione: quella che stabilisce che l’uomo ha per scopo fondamentale della vita la felicità terrena; e di conseguenza tutto è basato su questo settecentesco concetto, e ogni sforzo è teso in questa unica direzione: il diritto naturale d’esser felici sulla terra sottomette ogni altra filosofia e lo stesso stato dovrebbe – almeno apoliticamente – adeguarsi alla teoria comune e alla comodità del singolo.
Questo può spiegare perché, sul piano culturale, gli americani siano arretrati rispetto all’Europa; indietro in fatto di letteratura, di pittura, di musica, perfino di moda. Ogni soffio di vita spirituale qui è europeo, solo europeo.
E allora, vien fatto di chiedersi, perché chiamare vecchia e magari decrepita quest’Europa che dimostra ancora la sua capacità di rinnovamento continuo, la sua capacità di trovare ancora soluzioni nuove a nuovi problemi? Non vi sembra una domanda consolante come conclusione d’un viaggio?
Sapere che per qualche secolo almeno la nostra Europa ha ancora una funzione ben precisa e insostituibile rispetto a questo gigantesco mondo, nuovo solo in apparenza e nei contorni materiali, mi pare importante; assai più importante della visione dei missili visti a Cape Canaveral e della visita alle fabbriche Douglas, dove migliaia di operai lavorano otto ore a ritmo febbrile soprattutto per pagarsi la rata della comoda automobile che li aspetta all’uscita.

Devi accedere per poter commentare.